Angelo Colla Editore
Recensioni
- home page [1]
- la casa editrice [2]
- catalogo [3]
- autori [4]
- recensioni [5]
- cerca un libro [7]
- ordini [8]
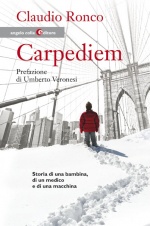 Claudio Ronco
Claudio Ronco
Carpediem
«Corriere della Sera»
23-01-2015
Il medico vicentino che ha inventato una macchina per salvare i bambini
«Alzo il telino sopra la culla. Lisa gira gli occhi a destra e a sinistra quasi a cercare qualcuno. Quando mi vede si ferma e comincia a succhiare con la bocca come per chiedere il latte. Chiamo un'infermiera e cominciamo a darle il biberon... Succhia, ha fame... È determinata, non molla, come non abbiamo mollato noi».
Lisa è una bambina nata due volte. La prima volta, alla fine di agosto del 2013, a causa d'un parto complicato, aveva una gravissima insufficienza renale. Così grave che pareva irrimediabilmente perduta. Il destino di 90 su 100 dei piccoli nati con quei problemi. Come potevano salvarla se non esistevano macchinari per la dialisi dove tutto fosse in miniatura e le multinazionali non erano interessate a metterci soldi per costruirli? La seconda volta, Lisa è nata negli ultimi giorni dell'estate. Quando finalmente chiese il latte. Dopo tre settimane di speranze, angosce, spaventi, notti insonni dei genitori, dei medici, degli infermieri.
Da grande potrà raccontarla come un'avventura di cui non ricorderà nulla. Tranne quello che le spiegheranno i genitori. E cioè che è stata la prima neonata al mondo salvata da una macchina costruita apposta per lei e i bambini venuti dopo lei (il 18% dei prematuri) all'Ospedale San Bortolo di Vicenza da un medico che, dopo aver lavorato in America e fatto esperienza in mezzo mondo, è riuscito a mettere su una squadra che tiene insieme scienziati di varie discipline. Si chiama Claudio Ronco, ha diretto il laboratorio del Beth Israel Medical Center di New York, ha pubblicato i suoi lavori sulle più prestigiose riviste scientifiche del pianeta, è finito nel 2014 al primo posto nella classifica dei più importanti scienziati del rene stilata dalla John Hopkins University, insegna in vari atenei italiani, americani e cinesi ed è appena uscito con un libro in cui racconta la sua «storia di una bambina, di un medico e di una macchina».
Si intitola, il libro, col nome proprio di quella macchina, Carpediem. In linguaggio scientifico: Cardio-Renal-Pediatric-Dialysis-Emergency-Machine. In latino, come ricordano i lettori di Orazio, «ruba un giorno» al futuro. E con quello spirito partì la battaglia intorno alla culla di Lisa: l'obiettivo era di rubare un giorno e poi un altro e un altro ancora alla cattiva sorte che pareva non lasciare scampo.
Scrive nella Prefazione Umberto Veronesi: «Carpediem è un miracolo della tecnologia e della fusione di più discipline scientifiche allo scopo di realizzare il rene artificiale perfetto per i bambini neonati. Qualcosa che non c'era, qualcosa di cui vi era necessità, qualcosa che, per fare eco ai colleghi americani, cambierà il modo di fare medicina nei pazienti neonati con problemi renali».
Il tutto grazie a un metodo: «Claudio ha realizzato quello che per anni è stato anche il mio sogno medico», spiega il grande oncologo che nel 2000 fu anche ministro della Sanità, «e cioè mettere assieme in un'unica struttura l'assistenza, la didattica e la ricerca. L'assistenza dei pazienti con una buona dose di umanità affiancata alla forte vocazione tecnologica della disciplina nefrologica».
Per capirci: il reparto vicentino, spiega il suo creatore, consiste oggi in «due piani dedicati all'assistenza dei pazienti con malattie renali, terapie extra-corporee e trapianti renali, ed un piano in cui sono collocati laboratori di ricerca, di biologia molecolare, fisica e ingegneria applicata, farmacologia, modellistica, economia sanitaria, sociologia e medicina renale». Di più: «L'istituto è economicamente autonomo e vive di progetti finanziati ad hoc». Lingua ufficiale: l'inglese. Miscuglio di nazionalità: «I ricercatori sono per il 50% stranieri e hanno un'età media di 25 anni». Alla faccia della gerontocrazia imperante...
Dove Ronco abbia preso i primi rudimenti tecnologici lo spiega: riparando antenne, da ragazzo, col suo amico Flavio. Uno dei tanti lavoretti dettati da una curiosità vulcanica che lo spinse a fare «il gelataio, il falegname, l'imbianchino, il riparatore di radio a galena, il meccanico di biciclette, il cacciatore di frodo (non era proprio un lavoro, ma aveva i suoi segreti), il bottonaio (avevo comperato un aggeggio per fare bottoni per signore con il tessuto dei loro vestiti), il recuperante di reperti bellici, il raccoglitore di muschi per presepi».
Un miscuglio di interessi che gli sarebbe tornato utile per capire quanto le divisioni in compartimenti stagni di una volta tra medici e ingegneri e sistemisti e programmatori «non abbiano alcun senso». Come la notte in cui, per salvare Lisa, decise di mettere in parallelo due Carpediem, inventando al momento come farli funzionare insieme: «Ci mettiamo a modificare il circuito in piena notte. Forbici sterili, connettori, tubi e filtri: sembriamo idraulici e, date le minime dimensioni, anche orologiai...». Mica facile, con le «cannule più sottili di un capello».
Fatto sta che, dopo aver fatto il giocatore di hockey, il chitarrista di un complesso rock, il costruttore di bob e un mucchio di altre cose, Ronco dimostra ora di sapere anche scrivere. E tiene insieme, con ritmo, tre racconti paralleli: la sua storia personale (prima notte da medico condotto, emozionatissimo, nel paese di Cornedo: un parto prematuro e un'appendicite acuta!), la storia della macchina e la storia di Lisa. Sempre con parole virtuosamente "facili". Un'arte imparata, giura, in America: non si trattava più di comunicare un concetto o una prognosi in "medichese", ma di trasferirlo al paziente in "malatese", ovvero in un linguaggio a lui comprensibile. Finalmente mi era chiaro il valore di comunicare e farsi capire...».
Carpediem, spiega Ronco, non è stato brevettato: «Una scelta precisa. Non l'abbiamo costruita per fare soldi, quella macchina. C'è solo un impegno preso insieme con le aziende Medica e Bellco di Mirandola, nell'area modenese sconvolta dal terremoto, che lo producono. Ogni dieci macchinari venduti, uno viene donato a un ospedale pubblico».
La bambina nata due volte, oggi, sta bene. Comincia a parlare. La mamma, quando le parla dell'uomo col camice bianco, lo chiama «zio Claudio». (Gian Antonio Stella)
 Cecil H. Clough
Cecil H. Clough
Luigi da Porto. Lettere storiche 1509-1513
«Amedit»
15-06-2014
D’altra parte, la decisione di Clough di riscattare il da Porto da un immeritato oblio storiografico e letterario diventa, con l’ampliarsi del lavoro di scavo filologico, determinazione caparbia a difendere l’integrità magmatica di quel lavoro, provocando dimissioni e defezioni a catena tra editori e mecenati, incuriositi dall’ “affaire da Porto” ma comprensibilmente smarriti e sgomenti di fronte alla mole del dossier messo insieme da Clough.
Le rassomiglianze aumentano e si approfondiscono man mano che ci si addentra nel volume. La figura del da Porto risulta davvero un gradino intermedio tra il riserbo del letterato italiano del Rinascimento, per cui la letteratura resta un passatempo aristocratico e abbastanza solitario, in un contrasto spesso imbarazzante tra la brillantezza della personalità pubblica e la modestia delle opere pubblicate, e la ruminazione insoddisfatta e perenne dell’erudito e umanista Clough, per cui il proprio lavoro costituisce soprattutto un risarcimento dovuto, e con gli interessi, a una fetta di passato altrimenti destinata ad annegarvi.
Il Proemio al libro I delle Lettere storiche sembra effettivamente la trascrizione in toscano letterario del Cinquecento del credo personale e professionale di Cecil Clough: «L’ingratitudine veramente fra tutti gl’altri vizi degl’uomini, che infiniti sono, è grandissimo; la cui villania tanto deva essere biasimata, quanto che sia da lodare il gentilissimo suo contrario; laonde ciascun uomo, al quale nei suoi giorni gran fatti di guerra venga veduto, nei quali, e l’animosità e la prudenza e l’ingegno s’adopra, mi pare che sia per il servizio dai passati ricevuto, molto obbligato di lasciarne ai posteri memoria, i quali passati le gran cose con tanta virtù dagli antichi operate, che altramente a noi sarebbono state nascoste, ci han col loro scrivere quasi sotto un bel cristallo lasciate dipinte, le quali mirando, e considerando, e più arditi e più saggi, e per loro esempio più alle virtù inclinati possiamo divenire. Io dunque per non restare di questa bruttura macchiato, ho voluto raccorre alcune lettere da me in spazio di alquanti anni, nella nostra comune lingua, e agl’amici d’intorno al fatto delle guerre del mio tempo, e del mio paese scritte; e per l’obbligo che ai passati si ha, del vano e del troppo quanto per me s’è potuto avendole scemate, lasciarle ai futuri».
La struttura concatenata della frase daportiana, caratteristica dell’umanesimo italiano del XVI secolo, e così ossequiosa delle consuetudini espressive della tradizione letteraria da non farsi scrupoli nel mettere a dura prova la pazienza e la disponibilità di tempo dei posteri, riflette la tessitura organica del lavoro di Clough, per il quale «le gran cose dagli antichi operate» vanno sì tramandate «sotto un bel cristallo», ma al fine di preservare, insieme col contenuto, il contenitore: perché il cristallo, infine, non è meno prezioso della gemma che custodisce. Insomma, se a tratti sembra difficile stabilire chi, tra da Porto e Clough, sia il salvatore dell’uno e il salvato dall’altro, non c’è dubbio che la gratitudine del lettore è da estendere a entrambi, a da Porto non meno che a Clough, poiché le Lettere storiche, senza la storia avventurosa che le ha riportate alla luce, perdono una buona percentuale del loro pathos.
In tanto connubio di fedeltà documentaria e ambizione letteraria, di imperativi morali e motivazioni individuali e personalistiche, ecco servita al lettore, in un unico piatto, una tipica vicenda italiana senza tempo vissuta e narrata da un personaggio altrettanto tipico dell’Italia non solo rinascimentale. Luigi da Porto appartiene infatti a una famiglia patrizia molto ricca e molto ben collocata nel vicentino, che vanta legami con le più prestigiose famiglie veneziane e, per via di matrimonio, con le principali dinastie locali: i Thiene, i Nievo, i Sesso, i Trissino… Quella della Lega di Cambrai (sodalizio militare voluto da papa Giulio II per frenare l’espansionismo della Repubblica di Venezia, con adesioni da parte di mezza Europa e dell’Italia che contava) è per i da Porto una guerra condotta all’insegna del cerchiobottismo, intesa unicamente a salvaguardare le proprietà e i diritti feudali della famiglia. Inizialmente filo-imperiali per insofferenza verso i Veneziani e la loro ingerenza negli affari d’entroterra, nel novembre del 1509 i da Porto stringono un’alleanza problematica e dilemmatica con la Repubblica di San Marco, tra incessanti fratture e dissidi interni. Lo stesso Luigi nasconde a fatica un sentimento di avversione nei confronti di Venezia, a fianco della quale si schiera. Le sue velleità di affermazione personale non sono modeste ed emergono per affinità con i particolarismi e i cambi di fronte di una guerra che mantiene un tono e un andamento non certo da conflitto europeo, ma da faida municipale e amministrativa. Durante la guerra, osserva Clough, «a causa della sua posizione strategica e della sua intrinseca debolezza difensiva, Vicenza cambiò di mano qualcosa come ventiquattro volte in otto anni», causando grovigli convulsi di confische e rivendicazioni feudali. Ferito da un colpo di lancia durante un combattimento il 20 giugno 1511, e quasi ridotto a paralisi, Luigi da Porto si dedica con fervore alle Lettere storiche. Nella loro composizione (1522-1525) cerca la rivincita dall’estromissione prematura dai fatti della guerra, confortato in questa sua opera di ricostruzione dal magistero intellettuale del cardinale Pietro Bembo, che attingerà con larghezza all’opera dell’amico per comporre le proprie.
Tra i pregi del volume c’è un risvolto di copertina straordinario, che crediamo di pugno di Giovanni Pellizzari: un capolavoro di sintesi, precisione e partecipazione emotiva. Impossibile non riportarne almeno una parte: «Nelle Lettere del da Porto si alternano e si fondono momenti di felice vitalità e drammi sanguinosi: le scaramucce fra cavalieri d’eccezione sotto gli occhi degli alti comandi veneziani, come in un teatro verde, a due passi da Verona; lo spettacolo, in Friuli, di un commilitone ungherese la cui calma e folle audacia strappa un applauso a Luigi, d’un tratto trasportato nel mondo fiabesco e stralunato delle chansons de geste e dei romanzi cavallereschi spagnoli; le imprese della maestrevole e sinistra cavalleria leggera albanese al servizio di Venezia; l’orrore ipnotico delle esecuzioni capitali con i loro rituali di degradazione; l’imboscata al chiaro di luna fatta, si direbbe, come una serenata alla sua donna, col buio finale che precede l’alba, e il ricordo dell’inno a Venere di Lucrezio. E poi, il buio improvviso della paralisi per una ferita alla gola rimediata da Luigi in uno scontro sul fronte friulano, la solitudine nella sua campagna di Montorso, o nel palazzo di Vicenza, e il sentimento del tempo, che gli fa riordinare, con le carte, il passato. Una vera recherche, che gli riporta davanti agli occhi i volti e le parole dei tanti compagni morti: a partire da quel suo zio, Antonio Savorgnan, figura paterna che poi tradì Venezia e finì tragicamente. Lettere dunque reinventate dopo vent’anni, e riscritte nello stile mutuato dal Bembo, il suo caro, più illustre e mondanissimo amico. Come dire: coscienza, kunstwollen di divenire un classico, scrittura per i futuri: per noi».
«La Stampa»
17-05-2014
Giulietta e Romeo? Si sono amati a Udine
In un tempo in cui la cultura è il danno collaterale della Tv e al posto del dibattito sugli Universali c'è la disputa se sia meglio l'oliva nera o l'oliva verde, un editore vicentino uscito dalla Macchina del tempo di H.G. Wells o forse sbucato da un'astronave parcheggiata nell'Area 51, si è permesso una sprezzatura inaudita. Angelo Colla Editore in Vicenza ha infatti pubblicato in un ampio volume le Lettere storiche (1509-1513) di Luigi da Porto, una cronaca dettagliata della guerra della Lega di Cambrai, curate dall studioso inglese di Machiavelli Cecil H. Clough. Un'opera monumentale per la delizia di pochi storici ed eruditi destinata a sfrecciare invisibile oltre la finestra della cucina, dove il lettore comune impara a fare un sugo con le vongole di Chioggia.
La rinascimentale guerra della Lega di Cambrai è per la storia italiana un momento di Sliding doors: se le cose fossero andate diversamente, avremmo avuto l'Italia unita (almeno in parte: una macroregione forse...) quattro secoli prima, sotto la bandiera della Repubblica di Venezia. L'espansionismo veneziano era visto con fastidio dalle grandi potenze: la Francia di Luigi XII, il Sacro Romano Impero di Massimiliano I e la Spagna di Ferdinando il Cattolico. Ma anche Giulio II era evangelicamente preoccupato dell'avanzata veneziana in Romagna, allora sotto il dominio secolare pontificio. Così riunì i potenti nel 1508 a Cambrai, adesso in Francia, vicino al confine belga, allora principato della Chiesa, per formare un'alleanza anti-veneziana. Chi pensa a un'immagine pensi a Il mestiere della armi di Olmi, che però racconta fatti di qualche anno dopo, quando le alleanze si erano già rimescolate: Venezia combatteva col Papa e i Francesi contro Carlo V.
Luigi da Porto, le cui lettere il cardinal Bembo saccheggiò ampiamente nella Storia di Venezia senza mai citarle, è il vero padre di Romeo e Giulietta. La sua novella Giulietta fu la base da cui Shakespeare trasse, circa 70 dopo, la sua tragedia. La vicenda avrebbe un fondo autobiografico: l'amore infelice di Da Porto per la cugina Lucina Savorgnan. Storicamente dunque, teatro dell'amore impossibile per eccellenza sarebbe Udine e non Verona, nonostante i turisti ogni giorno sotto il celebre balcone.
Claudio Gallo
«ladomenicadivicenza.gruppovideomedia.it»
03-05-2014
Da Giulietta e Romeo alle Lettere storiche
Un'opera attesa da decenni dalla comunità degli studiosi del Rinascimento italiano ora è finalmente disponibile grazie all'impegno dell'editore vicentino Angelo Colla. Presentato nella prestigiosa cornice della sala Stucchi a palazzo Trissino, sede del Municipio di Vicenza, il volume è la prima edizione critica delle Lettere storiche di Luigi Da Porto redatta da Cecil Clough e curata da Giovanni Pellizzari. Un'opera unica in una moderna edizione, come consuetudine per i libri editi da Colla, che in questo caso si è avvalso della collaborazione dell'imprenditore Luciano Giacomelli, sponsor dell'iniziativa. Il ricco volume di oltre 650 pagine, disponibile al prezzo di 65 euro, è destinato a riscoprire la grandezza di uno scrittore e di un personaggio vicentino come Luigi da Porto finora trascurato e, per la ricchezza dei materiali documentari inediti che contiene, a dare nuovo impulso agli studi di storia locale.
Luigi da Porto (1485-1529), nobile vicentino noto come autore della novella di Giulietta e Romeo, cui si ispirò il capolavoro di Shakespeare. Ma prima di essere scrittore, poeta e storico fu un giovane e coraggioso capitano di cavalleria che partecipò alla Guerra di Cambrai. Ferito in battaglia e rimasto parzialmente paralizzato, si dedicò all’attività letteraria. Le Lettere storiche sono la più dettagliata storia della Guerra di Cambrai. Ma ogni lettera realmente scritta o ricevuta dallo storico vicentino fu completamente riscritta una quindicina d’anni dopo i fatti per farne un’opera di narrativa, che è all’origine di un genere di scrittura letteraria molto fortunata.
Le Lettere storiche costituiscono uno dei più interessanti testi letterari cinquecenteschi poiché ha dato origine ad un nuovo genere letterario, tra il resoconto di un inviato di guerra e il memoriale. Narrano la guerra della Lega di Cambrai in modo veritiero e ricco di emozioni poiché l'autore, Luigi Da Porto, ha combattuto in quegli anni in qualità di capitano della cavalleria dell'esercito veneziano. Emerge una nuova e particolarmente biografia di Da Porto tracciata da Clough e riportata nella parte introduttiva del volume. L'uomo appare come un personaggio nobile, coraggioso e amante dell'avventura cavalleresca, poeta sensibile, cui il destino infranse i sogni della gloria militare e dell'amore con una ferita rimediata in combattimento che gli deturpò il corpo e gli fiaccò lo spirito facendolo morire giovane.
Da Porto appare come uno scrittore non inferiore agli storici e letterati fiorentini del grande Rinascimento, con tutte le caratteristiche per essere riscoperto come una delle bandiere vicentine. La storia del manoscritto originale delle Lettere appare piuttosto rocambolesca. Bernardino, fratello minore di Luigi, aveva prestato il manoscritto a Bembo, amico intimo di Luigi, che non lo restituisce più, anzi lo saccheggia ampiamente per la sua Istoria veneziana (storia ufficiale di Venezia commissionatagli dalla Repubblica) e non cita nemmeno la fonte. Alla morte di Bembo il manoscritto fu venduto insieme agli altri libri della biblioteca bembiana e finisce in mare al largo di Ancona in seguito ad un attacco di pirati alla nave che lo trasportava.
Sulle guerre nate dalla Lega di Cambrai (1509-1517) - si legge nelle note del volume - non mancano testimonianze di cronisti dell’epoca, che però si limitano a narrare ciò che avviene entro la cinta delle mura cittadine o che, come il cronista veneziano Marin Sanudo, affastellano notizie d’ogni dove. Ma la testimonianza di una guerra combattuta da un gentiluomo privato, e narrata dallo stesso, è cosa propria di Luigi da Porto, e di nessun altro nel Cinquecento. Guerra cui egli partecipa volontario, con l'entusiasmo dei suoi vent’anni, baldanzoso e sicuro della propria forza e destrezza, ma anche curioso, attento, indagatore e pensoso. Nelle Lettere si alternano e si fondono momenti di felice vitalità e drammi sanguinosi: le scaramucce fra cavalieri sotto gli occhi degli alti comandi veneziani; lo spettacolo d’un commilitone ungherese la cui calma e folle audacia strappa un applauso a Luigi, d’un tratto trasportato nel mondo fiabesco dei romanzi cavallereschi spagnoli; le imprese della sinistra cavalleria leggera albanese al servizio di Venezia; l’orrore delle esecuzioni capitali con i loro rituali di degradazione.
Leggendo il libro si scopre una figura di scrittore di cultura classica coi suoi richiami umanistici, e una non meno influente ideologia cavalleresca: la guerra come splendida avventura, da vivere a colpi di agguati e duelli al sole. Ma c’è anche la percezione politica della guerra, con lo smarrimento di fronte alle sue atrocità, che detta all’autore considerazioni e giudizi sull’esercizio tortuoso del potere e violento del comando, e sulla psicologia dei soldati e delle masse contadine degni dei migliori scrittori politici del Rinascimento.
Abbiamo incontrato il curatore Giovanni Pellizzari.
La sua è un'opera editoriale impegnativa e mirata ad un target circoscritto: cosa l'ha spinta a realizzarla?
Non tutto ciò che è buono deve essere per forza alla portata di tutti. Tanto più quando un'iniziativa editoriale come la nostra non drena neanche un centesimo di danaro pubblico. Come dice nella sua prefazione Gino Benzoni, già ordinario di storia della storiografia all'Università di Venezia e oggi segretario della Fonazione Cini, una volta opere così erano appannaggio di enti pubblici e di banche: oggi da Porto dall'Aldilà, Clough e il sottoscritto dobbiamo ringraziare l'intelligente passione culturale d'un privato, l'industriale Luciano Giacomelli, che si è sobbarcato i costi vivi dell'opera, che altrimenti mai avrebbe potuto affrontare il mercato librario. Target circoscritto, certamente per il nostro libro ma attenzione: le opere di autentica cultura, per ardue che appaiano, finiscono per filtrare e irradiare, contribuendo a rivitalizzare un ambiente, agendo come un catalizzatore, forse a distanza di anni o di decenni. Almeno, questa è stata la nostra scommessa. E comunque Clough ha scritto per un orizzonte di lettori di tutto il mondo. Noi abbiamo seminato: qualcuno, magari in Australia o in Canada, magari oggi ancora non nato, raccoglierà. Perché l'opera di da Porto è viva e capace ancora di farsi ascoltare".
Quali sono le vicende storiche che hanno ispirato l'opera e in cosa si differenzia da altri precedenti riferimenti letterari?
Quando nel 1522 Luigi da Porto si accinse a dare forma letteraria alle sue Lettere storiche, Niccolò Machiavelli non aveva ancora pubblicato le sue Storie Fiorentine né Guicciardini la sua monumentale Storia d'Italia, che, compiuta nel 1540, comincerà a circolare ben più tardi. Da Porto non vuole confondersi con i cronisti cittadini, che limitavano il loro interesse alla propria città, affastellando notizie d'ogni genere. Né d'altra parte voleva compilare una storia d'Italia o d'Europa, sulla base di documenti poco affidabili. Egli sceglie intenzionalmente di raccontare la Guerra della Lega di Cambrai contro Venezia, e dentro questo preciso orizzonte temporale e spaziale, dà un rilievo particolare alla propria testimonianza vissuta, dapprima di gentiluomo privato in una città come Vicenza, esposta ad una serie di occupazioni militari; e poi come capitano di cavalleria, sul fronte veronese, e poi su quello orientale, dove in una mischia ricevette il colpo di pugnale alla gola che lo rese paralitico, vanificandone i sogni di gloria. Che il suo valore in guerra non sia invenzione o amplificazione, sappiamo da altre fonti insospettabili. Riassumendo: la Guerra, quella guerra, cruciale per Venezia e per le sorti dell'Italia, vista dall'interno, con l'occhio d'un gentiluomo di terraferma; e narrata sotto forma di informatissime lettere: ecco la specificità di da Porto.
Da Porto fu militare, ma anche "inventore" del mito di Giulietta e Romeo, con tutto il rispetto per il sommo Shakespeare... una figura quasi "romantica" di altri tempi?
Il 'guerriero' da Porto fu l'inventore del mito di Giulietta e Romeo. Chi solo legga la Lettera 48 non dubiterà dell'anima diremmo romantica del nostro cavaliere: e la cavalleria è una civiltà, o, se vogliamo, una mitologia globale, nel senso che ci ricorda l'Ariosto nei primi versi del suo poema ("Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori..."). La Guerra è feroce, spesso disumana, ma in essa alberga pur sempre, e non è solo un bel sogno, l'ideale cavalleresco. In esso, l'amore, un certo tipo di amore 'patetico', quasi iniziatico, vi ha larga parte. Ecco da dove viene la novella che da Porto immagina essergli narrata da un suo anziano arciere veronese. Sappiamo, da una lettera del Bembo al più giovane amico, che, adolescente, Luigi si era innamorato e, respinto o tradito che fosse, si ammalò così gravemente, che l'amico veneziano temeva per la sua vita. Un pezzo d'uomo, "bellissimo" e coraggioso, stando al Bembo, ma fragile e ipersensibile. Del resto, non fosse stato per il vescovo Bandello, che 'rimpolpò' la novella Giulietta e Romeo, prosaicizzandola, forse essa non sarebbe mai giunta a Shakespeare. Resta il fatto, che da Porto si studiava a Oxford quando Clough vi intraprese gli studi di italianistica che lo resero famoso.
Cosa ha lasciato Da Porto in eredità a Vicenza e alla sua tradizione culturale?
Le circostanze della sua vita e quelle successive alla sua morte, fecero sprofondare nell'oblio Luigi da Porto, di cui restava a stampa la novella e una raccolta poetica. Solo nell'Ottocento, grazie alla popolarità immensa goduta da Shakespeare in età romantica, di riflesso, anche da Porto cominciò ad attirare l'attenzione degli studiosi. E così saltarono fuori, dalla Marciana e dall'Ambrosiana, i primi manoscritti delle Lettere Storiche, fino allora ignorate (l'originale era finito in mare, nei primi anni del Seicento, durante un assalto saraceno a due navi da carico). A Vicenza, Luigi da Porto godé allora, improvvisamente, d'una fama postuma, che ispirò quadri, musiche, studi critici. Ma, avendo scambiato le Lettere Storiche per una fonte bene informata, quando, alla fine del secolo, apparvero a stampa i 58 volumi degli enormi Diarii di Marin Sanudo, pieni di vivacità e curiosità d'ogni genere, straordinariamente ricchi di informazioni di prima mano, e scritti in un pittoresco veneziano stretto, essi eclissarono, agli occhi degli eruditi, l'opera di da Porto: tanto più che l'impegno stilistico dello scrittore vicentino lo rendeva più 'distinto' e 'distante' rispetto alla sanguigna e istintiva cronaca del veneziano. Solo che da Porto quelle 'lettere' allo zio, agli amici, alla sua amata, le rielaborò con precisi intenti d'arte, dieci d'anni dopo i fatti che aveva vissuto e annotato: la sua fu una vera 'ricerca del tempo perduto', un dialogo con gli amici morti, con se stesso giovane, entro una civiltà e una città che già non era più la stessa. Volle che la sua storia mantenesse il carattere epistolare, per continuare a dialogare con le care ombre della sua breve vita felice da cavaliere.
Alessandro Scandale
 Giuseppe D'Alessandro
Giuseppe D'Alessandro
Truffe, truffati e truffatori
«Il Mattino»
14-01-2013
Nella giungla infinita delle truffe c’è da perdersi senza ritrovarsi, dal momento che ciascuno di noi – confessiamolo – almeno una volta nella vita è stato preso in giro da un mago o da un avvocato corrotto, da un commerciante disonesto o dal tassista con il resto sbagliato, da una banca fittizia o da una onlus affarista, da un medico opportunista o da un’asta televisiva, da un’università fantasma o da un sito web taroccato. Anziché scagliare la prima pietra, perciò, conviene attrezzarsi. Perché imbrogliare è peccato, ma è peccato anche farsi imbrogliare! Con questo slogan Giuseppe D’Alessandro, avvocato cassazionista e già autore di due fortunati Bestiari giuridici, pubblica ora l’istruttivo manuale Truffe, truffati e truffatori. Da leggere per divertirsi, da consultare per guardarsi le spalle. Data l’enorme mole di leggi, sentenze e documenti processuali, un risultato miracoloso.
Le statistiche Istat non disegnano perfettamente la situazione, perché in Italia il numero delle denunce è basso. I motivi? Almeno tre: il danno di poca entità; la lentezza della macchina giudiziaria; la paura di essere giudicati incapaci. Ma c’è anche disincanto sulle pene, che non sono abbastanza severe. Pescando a piene mani nel repertorio, stupisce la gran quantità di magistrati e avvocati coinvolti in truffe anche gravissime. Mentre il primato assoluto tra gli enti pubblici truffati va all’Inps, specie nella versione «pensione di disabilità». I filmati di falsi invalidi che guidano da ciechi e ballano da paralitici sono ormai quasi quotidiani in tv. Siciliani e abruzzesi sono i primi in classifica, ma anche Napoli e il suo hinterland non scherzano. Ad Arzano, anno 2005, una famiglia di venti persone godeva tutta della pensione Inps. E il Pallonetto di Santa Lucia ha qualche problema: ben 400 dei suoi abitanti è riconosciuto «non sano di mente» e quindi destinatario di benefici pensionistici. Altrettanto frequenti, purtroppo, i medici disonesti con il dono del’ubiquità, che inventano piani terapeutici, che curano pazienti morti. Tra le truffe più singolari, quella di un curatore di fallimenti romano autorizzato a versare il dovuto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Cosa che regolarmente faceva. Solo che la sigla era l’acronimo di Insegnamento nella Partecipazione Sindacale, una società creata appositamente per intascare le somme che, all’atto del sequestro, ammontavano a quasi tre milioni di euro.
C’è una «truffa alla nigeriana» (organizzata professionalmente con apposito sito e consistente nel contattare persone asserendo di aver bisogno di un prestanome per riscuotere grossi capitali). E c’è la truffa mordi-e-fuggi dei diamanti, che il tizio cerca di vendere sottocosto alla vittima (di solito anziana). Ma a farne le spese sono anche fior di professionisti. Con la stessa tecnica un banda di slavi qualificatisi «sceicchi» si è impossessata in una gioielleria di Valencia dei preziosi appartenuti a Evita Peron. Ricchissimo il capitolo delle truffe «soprannaturali», tra religione e superstizione. Non solo maghi, tarocchi e fattucchiere, Vanna Marchi compresa con i suoi rituali anti-malocchio mescolati alle soluzioni «scioglipancia». C’è anche la potente Scientology con il suo «listino delle donazioni obbligatorie» imposte agli adepti. E si chiude con le truffe tecnologiche, da quelle telefoniche al «phishing» in rete, cioè il tentativo di carpire via internet dati finanziari sensibili a ignari utenti. (Santa di Salvo)
 Angelo Colla
Angelo Colla
Guida per Vicenza
«www.associazionivicentine.it»
07-12-2012
Vicenza, del resto, è una città presa in considerazone dall'Unesco con ventisei edifici palladiani inseriti nella lista dei monumenti patrimonio dell’Umanità, ma è anche una città ricca di eleganti dimore prerinascimentali e di palazzi del gotico fiorito che fanno invidia alla stessa Venezia. Il che non è affatto poco.
Quella di Colla è una guida "emozionale", come la definisce l'editore stesso, vale a dire capace di svelare al visitatore i tesori cittadini privilegiando il ritmo lento e interiore delle emozioni. Siamo lontani, allora, dalle fugaci visite mordi e fuggi, che molti turisti sono costretti a fare, loro malgrado, per "esigenze di tempo" (o forse per esigenze dei tour operators?).
Un volume riccamente illustrato e soprattutto adatto a tutti, non solo agli eruditi o agli "addetti ai lavori". Un libro che si legge con piacere e che si inserisce nella tradizione delle guide classiche di Vicenza: da quelle del secolo scorso di Barbieri-Cevese-Magagnato e di Neri Pozza fino alla monumentale monografia Vicenza. Ritratto di una città, di Barbieri-Cevese del 2004 (pubblicata dallo stesso Colla).
Questa guida, che ha conciliato l’erudizione dei tre maggiori storici dell’arte vicentini con la sensibilità artistica di Neri Pozza, si compone dunque di tre itinerari per il centro storico che permettono al turista, spesso soltanto di passaggio, di visitare nell’arco di una giornata i palazzi, le chiese e le piazze più importanti di Vicenza, e di tornare a casa con la sensazione di aver conosciuto davvero, e non solo guardato, la città berica.
Ma non è tutto. Per il turista che vorrà dedicare una seconda giornata, o una seconda visita, a Vicenza, Colla ha tracciato sette passeggiate che costituiscono altrettante occasioni di approfondimento dei capolavori che abitano le colline e la campagna nelle immediate vicinanze della città: La Rotonda del Palladio; Villa Trissino a Cricoli; Villa Valmarana ai Nani e Villa Loschi Zileri dal Verme al Biron con gli affreschi dei Tiepolo; la basilica di Monte Berico e altro ancora.
Stiano attenti però i vicentini e non credano di cavarsela così... le passeggiate sono state pensate anche per loro (in fondo lo raccomandano anche i migliori medici, camminare fa molto bene alla salute e allunga la vita...). Se volessero scoprire itinerari o vedute della loro città a cui avevano prestato poca o nessuna attenzione potranno trarre utile spunto dalle eleganti pagine di Colla.
Si pensi a che cosa si può osservare con un solo colpo d’occhio rimanendo fermi su Ponte Furo, la meta della prima delle sette passeggiate: davanti, la Basilica con la Torre Bissara, uno degli scorci più tipici e romantici di Vicenza; dietro, la vista del santuario di Monte Berico; a sinistra, palazzo Civena-Trissino di Palladio; a destra, la Loggetta settecentesca di Bertotti Scamozzi, le mura altomedievali con l’imponente Porton del Luzzo, il profilo della cavea del teatro romano segnato dai palazzi costruiti su quelle che erano un tempo le sue gradinate.
Tutti gli edifici e i monumenti descritti sono anche illustrati da oltre 160 foto a colori. Il corredo illustrativo è inoltre arricchito delle immagini dei capolavori di pittura classica conservati nel Museo civico di Palazzo Chiericati e dei più bei dipinti visibili nelle chiese vicentine. In appendice, indice dei luoghi, indice dei personaggi storici e degli artisti, carte topografiche per orientarsi dentro e fuori la città, con indicazioni dei parcheggi, orari di visite a musei e collezioni pubbliche e private. (Alessandro Scandale)
«http://libriinviaggio.vanityfair.it»
27-11-2012
«Il Giornale di Vicenza»
09-01-2012
Innanzitutto che è diventata città (e provincia) Unesco con 26 opere palladiane da circuitare nel mondo. In secondo luogo che c’è un modo diverso di leggere il centro storico dopo Neri Pozza, l’editore ed artista scomparso nel 1988 che amava passeggiare per il centro e che firmò decine di incisioni di una città in bianconero, spettrale e nitida nelle architetture. L’editore Angelo Colla, che di Pozza è stato alungo primo collaboratore, ha afferrato il “toro” per le corna e ha curato e pubblicato una Guida per Vicenza che fa tesoro e lezione di quanto prodotto in passato ma le regala il passo agile necessario al turista e al visitatore colto, che vuole conoscere i dietro le quinte.
Colla articola così un percorso in centro storico in tre itinerari fotografici di due-tre ore in cui riassume il sapere necessario e regala qualche emozione narrando dei palazzi e delle chiese fanno di Vicenza un unicum mondiale. Una città che ha coltivato se stessa dai paleoveneti in poi, che rivela la sua origine romana e la coltiva in quel corso – che si chiama non a caso Palladio – attorno al quale perdere la testa tra facciate e lesene di grande rigore e grande bellezza. Colla elenca i monumenti importanti e quelli di poco minori esaltando i caratteri del Cinquecento ma valorizzando anche la precedente produzione gotica, e poi quella successiva di Scamozzi, Pizzocaro, Muttoni, Calderari, in duecento anni di cantieri e laboratori che non hanno uguali.
Giardini, palazzi e chiese è il primo itinerario, la piazza della Signoria e la via dell’aristocrazia è il secondo; musei civici, teatro Olimpico e Santa Corona da soli valgono un terzo percorso. Così come i 23 capolavori della Pinacoteca e le 13 tele segnalate nelle chiese. E confidando che lo sguardo del turista – ma anche quello del vicentino appassionato della sua terra – si allarghi alla periferia , il curatore disegna sette passeggiate a godere di oratori, abbazie e santuari – Monte Berico compreso – che a pieno titolo fanno di Vicenza una meta da centellinare. (Nicoletta Martelletto)
 Stefano D'Andrea
Stefano D'Andrea
Lamerikano
«www.mangialibri.com»
01-10-2012
Ecco una città che per decenni ha rappresentato, infervorato, eccitato l'immaginario collettivo italiota: ci sono tanti modi di raccontarne un pezzo, perché tutta intera proprio non si può, anche il villaggio più recondito e minimale non si può esaurire con qualche descrizione. Allora meglio l'impressionismo personale, la fotografia del quotidiano che però è costante, catturare l'essenza e l'istante più che teorizzare sui massimi sistemi. Non sempre tutto quanto riesce, ma talvolta invece sì. Magari se a scrivere poi è uno studioso di sociologia della comunicazione, di mentalità aperta, innamorato della Grande Mela e sempre più deluso dal Paese di nascita, questa Italia bislacca e talvolta incivile…
Lamerikano di Stefano D'Andrea è un libro riuscito. Linguaggio agile, sintetico, tipico di post pubblicati su blog con rapide ed efficaci notazioni sul quotidiano dei newyorchesi, spesso partendo o arrivando a situazioni analoghe vissute in Italia. Il paragone che ne nasce ovviamente è ingeneroso per noi. Come spiega il sottotitolo al libro, gli statunitensi sono ancora capaci di sognare, gli italiani no. E così anche la metropoli di una nazione di fatto senza storia, nata appena duecentocinquanta anni fa o giù di lì ma che fino all'alba del Ventunesimo secolo era grande ed invincibile, supera e surclassa la gloriosa Italia dalla storia millenaria, sempre più affogata nelle proprie miserie e contraddizioni etiche, sociali politiche ed economiche.
Il progetto del libro è una di quelle storie semplici e vere, anche se tipicamente internettiane. A dimostrazione che come al solito il virtuale può essere o diventare solido e concreto, in quando mero mondo strumentale che non elimina il reale, anzi lo arricchisce. Come si legge nella breve ed esauriente introduzione, la “non solo blogger” Viviana Musumeci affida al “quasi cosmopolita” Stefano d'Andrea una rubrica virtuale nella quale postare dei paragoni tra ciò che si vede nella Grande Mela e ciò che è diventata o rimasta l'Italia. Interessante operazione. Certo randomizzata, autoreferenziale, quasi schizofrenica, visto che lo stile risente della natura “bloggeriana”: i frammenti sono immediati, circoscritti, hanno poco in comune con la “vecchia” Letteratura o con il giornalismo di una volta. Ma indubbiamente ci piace come D'Andrea, a suo rischio e pericolo, ci notizia le sue impressioni da esule. E se lo dice uno come me che non ha mai amato New York e gli Usa anche in un periodo dove questo sentimento doveva e poteva, secondo gli altri, solo essere connotato da matrici politiche e non meramente di gusto, vuol proprio dire che è un libro che vale la pena di leggere. (Paolo Pappatà)
«www.mangialibri.com»
01-10-2012
Stefano D’Andrea è milanese di nascita, ma oramai cosmopolita per formazione. Professore universitario ma non troppo, scrittore, autore radiofonico ma soprattutto blogger apprezzato e “inventore” di “Profili d’autore”, pagina web che offre servizi di scrittura biografica per persone ed aziende. Visti i suoi lunghi soggiorni a New York, i suoi post in proposito spesso non teneri con l’Italia, e la pubblicazione di un libro, l’abbiamo contatto via Facebook per approfondire qualche questione.
New york per decenni è stata la città mito per l'immaginario collettivo italiano. Pensi che possa continuare (o tornare eventualmente) ad esserlo? Possa diventare "educativa"?
Credo di sì. Inoltre la possibilità di volare a prezzi ragionevoli consente a molte persone di vivere un’esperienza più forte e diretta rispetto a quella mediata dai prodotti culturali, e sono convinto che così come sta succedendo con Barcellona, Londra e Berlino, presto saranno più numerosi di quanti già sono, gli italiani che si sposteranno a New York, anche solo per un periodo di formazione, fortuna che prima era riservata solo a una classe sociale molto elitaria.
Di contro personalmente non pensi che alla luce della attuale situazione economica, sociale e politica, non sia il caso di sognare Berlino? o magari addirittura Pechino?
Berlino è certamente un luogo affascinante, e non è un caso che le energie che dimostra di liberare siano principalmente legate a personalità non tedesche di nascita, e che la città sia in fondo un luogo “nuovo”, rinata letteralmente dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e dalla tragica divisione delle Guerra Fredda. È una specie di “frontiera” interna al Vecchio Continente. Una piccola America. Pechino no, è semplicemente un altro mondo, troppo distante per cultura, storia millenaria e lingua. Nessuno è mai riuscito a mescolarsi con i cinesi, e non riesco a capire il perché. Ma non mi attira, se non per un motivo turistico e antropologico.
Ho apprezzato molti paragoni "irriverenti", fra comportamenti italiani e newyorchesi. Ma forse alla fine non credi che perderemmo il confronto con molte altre metropoli anche magari meno trendy?
Ahimè, sì. Il mio amore (razionalizzato) che ho cercato di raccontare nel libro, vuole anche essere la rappresentazione delle nostre difficoltà e il sogno di un cambiamento possibile ma non probabile. E per far ciò era necessario utilizzare un confronto estremo. Temo che avremmo perso (parlando di città e della mia, Milano, in particolare) anche contro Lione.
Che ne pensi della recente rielezione di Obama?
Politica interna americana, a noi incomprensibile. Sorprendente che se ne parli così tanto e conoscendo così poco. Il “nero e di sinistra” Obama, in Italia, dimezzerebbe domani il numero di impiegati pubblici, solo per cominciare. Lui va bene per loro. Qui sarebbe un pericoloso rivoluzionario, ma in senso opposto a quello che ci si aspetta. Hanno bisogno di più stato sociale, noi abbiamo bisogno di altro. Il dato più piacevole è stato il concession speech di Romney. Commovente. Il suo “nemico” politico è diventato Presidente e lui lo ha ringraziato chiedendogli di lavorare per il bene di tutti, e si è messo a disposizione per lavorare insieme, per il bene di tutti.
Il progetto sfociato nel libro Lamerikano rimarrà isolato, oppure c'è qualcosa di nuovo all'orizzonte come scrittore?
La tentazione di scrivere un libro sull’Italia vista dall’America, sulla falsa riga di Lamerikano, c’è. Ma anche la necessità di lavorare a un romanzo. Forse proverò a fare le due cose contemporaneamente. (Paolo Pappatà)
«Il Venerdì di Repubblica»
10-08-2012
 Giorgio Vasari
Giorgio Vasari
Le Vite
«Amedit»
01-10-2012
Nella compilazione delle vite degli artisti la sua intuizione più formidabile (e moderna) fu quella di far confluire quante più informazioni possibili attingendo dalle fonti più disparate, senza tralasciare il nutrito patrimonio orale. Si servì dei Commentari di Ghiberti, del Trattato di Cennino Cennini, del Libro di Antonio Billi, della Historia Longobardorum di Paolo Diacono, delle Cronache di Matteo e Giovanni Villani, degli scritti di Palladio, di Serlio, di Filarete, di Leon Battista Alberti, delle Vite dei papi di Platina, del Libro vecchio della Compagnia dei pittori fiorentini, delle Memorie del convento di San Marco, della corrispondenza privata di numerosi artisti, nonché di numerose fonti ignote oggi perdute.
Tutte queste informazioni, isolate e frammentarie, convergono per la prima volta in un resoconto unitario ragionato ed esaustivo, condite infratesto dalle considerazioni più svariate. Al dato biografico dell’artista di volta in volta preso in esame (la provenienza geografica, i trascorsi, l’apprendistato), Vasari affianca veri e propri ritratti psicologici: l’artista è descritto diffusamente anche nel suo carattere, nel suo temperamento, nelle sue inclinazioni, individuando così uno stretto legame tra la personalità e le caratteristiche tecnico-espressive del talento e dello stile. Le Vite vengono così a profilarsi non come schede asettiche di sapore enciclopedico o come meri elenchi, ma come singole storie che interagiscono tra loro, singole tessere di una Storia dell’Arte ancora in fieri ma già significativamente delineata, una macchina sperimentale che seppur difettosa e rudimentale ha spianato la strada all’affinarsi progressivo di una nuova grande disciplina storica. Senza Vasari la Storia dell’Arte avrebbe affrontato un cammino di certo più impervio e tardivo.
La prima redazione delle Vite risale al 1550 ed è denominata edizione “torrentina” (dal nome dello stampatore ducale Lorenzo Torrentino); qui compare il titolo in esteso Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, e la dedica a Cosimo I de’ Medici. Una seconda redazione, riveduta e ampliata, vide la luce diciotto anni dopo, nel 1568, ed è nota come edizione “giuntina” (dal nome degli stampatori ducali Giunti). Se nella torrentina vengono magnificati gli artisti toscani (primo fra tutti l’ineguagliato Michelangelo) per la maestria disegnativa e prospettica, nella giuntina trovano spazio anche i veneti (Tiziano in primis), lodati per l’impiego sapiente e tonale del colore. Questa distinzione tra la sensibilità toscana verso il segno e quella veneta verso il colore si attestò subito fra le più acute, ed è considerata per gran parte valida ancora oggi. Va detto però che l’autore delle Vite non brillò sempre per correttezza e oggettività, tanto saldo e militante era in lui il campanilismo fiorentino e certe prese di posizione tutt’altro che elastiche ed imparziali; in molte biografie non mancano infatti giudizi sentenziosi e deliberatamente personali (un po’ alla maniera di Dante nella Divina Commedia). Tuttavia sono proprio questi passaggi che oggi ai nostri occhi contribuiscono a rendere il testo ancora più ghiotto, e che lo affrancano letterariamente dal genere specialistico meramente storiografico.
Il metodo delle biografie, dicevamo, non era una novità assoluta. Vasari seppe però rielaborarle e disporle in successione, seppe relazionarle ciclicamente l’una all’altra, dai vagiti di Cimabue fino alle liriche di Michelangelo, come una sorta di stella che nasce, si irradia e poi si spegne, come ogni grande storia destinata a un gran finale. Per Vasari andare oltre il genio indiscutibile di Michelangelo, superare quella perfezione, non era possibile. Oltre Michelangelo poteva sussistere solo la maniera di Michelangelo, un manierismo con un modello di riferimento ben preciso. Prima, durante e dopo: questa tripartizione è denunciata dal Vasari già nell’edizione torrentina. Su grandi linee l’importanza del testo vasariano è per molti versi ascrivibile a quella del testo manzoniano. In entrambi i casi, infatti, viene a verificarsi quello che potremmo definire un “collaudo di genere”, più disarticolato e inconsapevole quello di Vasari e più programmatico e ragionato quello di Manzoni. Da una parte la Storia dell’Arte e dall’altra il Romanzo. Tanto nelle Vite quanto ne I promessi sposi, nonostante lo iato di quasi tre secoli, il dato che emerge per primo e che più affascina è il tentativo di individuare un canale linguistico, uno schema narrativo nelle trame vergini del linguaggio letterario, il tutto rapportato a una “lingua italiana” e a una grammatica non ancora compiutamente vocabolarizzate. Due opere letterarie distanti anni luce ma accomunate per l’appunto da questo pionierismo di fondo. Forse il paragone potrebbe suonare forzato ma di certo aiuta a comprendere la portata straordinaria dell’operazione vasariana.
Scrive Luigi Grassi: «Non sempre al capolavoro si arriva in forma organica e sintetica: e propriamente il difetto di struttura organica si risolve in quell’aspetto o configurazione delle Vite vasariane, che è come un grandioso sistema orografico, con vette, valli, dirupi, luci, ombre, colori, aria e orizzonti». Il sottobosco umano e quotidiano delle Vite costituisce in parallelo forse il documento più prezioso che, sorprendentemente intatto, ci giunge da quell’epoca ormai così lontana. Schlosser, non a caso, si spinge a definire le Vite un «romanzo storico». Al di là dell’Arte, infatti, e più in generale delle diverse caratteristiche tecnico-espressive di ciascuno dei centosettantotto artisti esaminati, è la Vita che emerge prepotentemente da questi racconti, una vita eroica e insieme così umana e quotidiana, una vita antica e al contempo così incredibilmente moderna. Ed è proprio la modernità che Marco Cavalli – già autore di una versione in italiano moderno della Vita di Benvenuto Cellini – riesce a restituire di queste vite, riconsegnandole a un linguaggio vivo, potente, presente, riesumandole da una lingua letteraria ormai troppo lontana, e comunque per la gran parte inaccessibile al lettore italiano contemporaneo.
I lettori stranieri, che hanno da sempre potuto beneficiare di traduzioni fluide e comprensibili, sono stati in tal senso più fortunati. «Le Vite», scrive Cavalli nella nota al testo, «non sfugge al paradosso che attanaglia i monumenti della prosa italiana del Cinquecento: se li si vuole leggere, bisogna prima studiarne la lingua. L’accesso alla letteratura italiana del passato segue da noi percorsi inversi rispetto a quelli battuti normalmente dalle altre letterature europee. Le altre nazioni leggono la loro letteratura e poi la studiano. Noi studiamo la nostra letteratura per poterla leggere – se avanza del tempo, e sempre che ce ne rimanga la voglia».
Tradotte nell’italiano di oggi le Vite si rianimano in un grande affresco d’insieme, in un vero e proprio romanzo che ha per protagonista l’uomo (o, se si preferisce, l’artista) dalle penombre del Medioevo alle luci abbaglianti del Rinascimento. Delle centosettantotto biografie Cavalli ne sceglie ventuno dall’edizione torrentina, operando una selezione ragionata per passare in rassegna tutte le modalità narrative del Vasari biografo. La lettura finalmente scorre fluida, godibile, perfettamente comprensibile, epurata dagli ostacoli e dai rallentamenti imposti dal toscano cinquecentesco. La traduzione da un italiano all’altro colma definitivamente la distanza storica e fa sì che la voce dell’autore, scavalcando la bellezza di quasi mezzo millennio con una sola ardita falcata, torni a parlare nitida, vicina, affettuosa. Tra le operazioni analoghe è doveroso menzionare quella pionieristica di Aldo Busi con la straordinaria traduzione del Decamerone di Boccaccio (1990-91).
La traduzione di Cavalli rende finalmente accessibile a un pubblico più vasto un testo tra i più fondamentali del nostro patrimonio storico, un testo rimasto per troppi secoli blindato, prima appannaggio esclusivo di soli studiosi e specialisti. L’impresa di riscrittura, lungi dal risolversi in una semplificazione, non sacrifica nulla della letterarietà originaria vasariana, anzi ne amplifica i contrasti e le sfumature. Tra tutte le biografie quella che emerge più inaspettatamente è proprio quella del Vasari, il suo punto di vista, le sue predilezioni, i suoi limiti, i suoi condizionamenti culturali, finanche la sua ironia, come se nel ritrarre gli altri non avesse fatto altro che comporre gradatamente e parallelamente un ritratto vieppiù dettagliato di se stesso.
L’opera, per come questa traduzione ce l’ha finalmente restituita, si offre contemporaneamente su più piani di lettura, in un bilanciamento perfetto tra testo storiografico e testo letterario. Ai passaggi tecnici e manualistici, infatti, si affiancano sempre le digressioni sugli aspetti umani più curiosi.
Dietro lo splendore dell’artista ci sono sempre le ombre dell’uomo: le sue ossessioni, le sue miserie, le sue ambizioni, e poi le invidie, le rivalità, le contraddizioni, le inquietudini; nell’ordito del racconto Vasari intreccia un campionario eterogeneo di informazioni mescolando pettegolezzi e inesattezze ai dati reali, contaminando le cronache attendibili con aneddoti improbabili, facendo convivere in un unico organismo leggenda e memoria storica, ed è qui che il confine tra il rigore dello storiografo e la licenza del romanziere si fa straordinariamente labile. La traduzione operata da Marco Cavalli ha il pregio di mettere in risalto proprio questo aspetto, restituendoci un Vasari come mai l’avevamo letto. (Massimiliano Sardina)
«Il Giornale di Vicenza»
13-09-2012
Il ritmo è fluido, leggero, spesso ironico, altre volte più incalzante e concreto. Il risultato è uno straordinario affresco della vita artistica italiana fra Tre e Cinquecento raccontata attraverso notizie, sescrizioni e aneddoti dei suoi principali protagonisti.
Le Vite di Giorgio Vasari, nella loro doppia edizione del 1550 e del 1568, rappresentano un documento di fondamentale importanza per la nascita della storia e della critica d'arte.
Ma non è solo questo. Le Vite potrebbero essere lette anche come un grande romanzo o una commedia umana «in cui cronaca e leggenda, pettegolezzo e memoria s'intrecciano dando forma e sostanza alla più vasta ed esaltante epopea narrativa incentrata sulla figura dell'artista».
Ed è proprio qui che si è appuntata l'attenzione del critico e saggista Marco Cavalli: «Tradurre in italiano moderno Le Vite del Vasari significa restituire al piacere di una lettura rimasta fino a oggi inaccessibile a causa della distanza storica che ci separa da quel toscano di base fiorentina che difficilmente si lascia avvicinare da un lettore ordinario».
Una sfida intorno alla quale il giovane studioso vicentino ha lavorato per molti mesi cercando di trovare il bandolo di una matassa piuttosto intricata e complessa.
Il risultato sta in duecento pagine risolte con scrittura rapida e vivacissima, capace di evocare con piglio sicuro alcuni intensi passaggi dell'arte italiana dal Medioevo al Rinascimento in ventuno biografie scelte, per ricchezza narrativa e gusto del dettaglio, tra le 133 che compongono la prima edizione pubblicata a Firenze dall'editore ducale Lorenzo Torrentino.
La decisione di affidarsi a questa prima stesura, anziché a quella più celebrata del 1568 edita per i tipi dell'editore Giunti e per questo chiamata Giuntina, viene così spiegata dal curatore dell'opera: «Tra la Giuntina, più riccamente informata, e la Torrentiniana, meno appesantita da preoccupazioni erudite, ho scelto di tradurre quest'ultima. Il Vasari della Torrentiniana è uno scrittore che duetta con il compilatore e spesso gli ruba la scena. Racconta con le informazioni che ha ma anche con quelle che non ha. Considera la tenuta narrativa del personaggio essenziale quanto la ricostruzione storicamente fondata della sua identità».
«Tra l'affresco monumentale e il ritratto lapidario - precisa ancora Cavalli - ho cercato di includere tutti i modi alternativi e talvolta contraddittori con cui Vasari assolve al compito di biografo. Se infatti il Vasari narratore non è tutto d'un pezzo, si trova però sempre tutto intero in ciascuno dei suoi pezzi. C'è in lui la bonomia del raccoglitore di aneddoti, la loquacità predicatoria del moralista, la tendenziosità dell'agiografo, l'enfasi un po' comica del campanilista, il colpo d'ala del romanziere che d'un tratto risale dal fatto particolare all'osservazione psicologica di carattere generale».
C'è Giotto, il pastore che disegna le pecore, e c'è il Cristo miracoloso del Giorgione. Ci sono le invenzioni di Leonardo e c'è il caratteraccio di Piero di Cosimo. C'è la vena alchemica del Parmigianino e c'è il verbo profetico del Buonarroti...
Il cammino della storia dell'arte tracciato da Vasari si configura come un'affascinante "bohème del nostro Rinascimento" che nella traduzione di Cavalli scorre sul filo di un'appassionata adesione narrativa. Per secoli l'immagine dell'arte italiana è stata quella tracciata dalla progressione delle splendide Vite del critico aretino colte nel momento dell'azione, dell'operare dei singoli autori.
Un disegno grandioso, che l'invecchiamento precoce di quel toscano di base fiorentina di cui sono intessute le sue narrazioni ha contribuito a circonfondere di un'aura tanto preziosa quanto sostanzialmente inaccessibile.
Valente pittore, abile architetto, artefice di una pietra miliare nell'ambito della storiografia e del linguaggio nel campo dell'Arte, Vasari ha dalla sua una qualità di scrittura, una capacità d'intessere raffronti e rapporti, che la traduzione in italiano moderno operata da Marco Cavalli restituisce al lettore contemporaneo senza alcun timore reverenziale, fedele più al ritmo narrativo che a una sterile riproposizione degli stilemi linguistici originari.
Un modo per ripercorrere con occhio fresco e avvincente uno dei testi fondanti delle arti figurative italiane e per gustarne l'ampio ventaglio di registri tonali pennellati da un novellare che ha il profumo luminoso del mito. (Maurizia Veladiano)
«La Repubblica»
05-08-2012
«Antiquariato»
01-08-2012
 Giuseppe Grava, Giovanni Tomasi
Giuseppe Grava, Giovanni Tomasi
La fienagione nelle Dolomiti venete
«Lettera da San Giorgio»
01-09-2012
Dopo l'uscita nello scorso anno de Il Veneto dei contadini 1921-1932 di Paul Scheuermeier, ecco, di Giuseppe Grava e Giovanni Tomasi, La fienagione nelle Dolomiti venete, con la quale i due autori estendono geograficamente la loro pluriennale ricerca - i cui frutti antecedenti hanno visto la luce ne La fienagione nelle Prealpi venete (1999) - alla parte settentrionale della provincia di Belluno, fino al Cadore e all'isola germanofona che appare tanto più preziosa quanto più rari e difficili da reperire sono diventati i materiali dialettologici alla base dell'indagine, patrimonio di un numero sempre più esiguo di informatori, e che attesta anche nel 2012 la vitalità della «Collana di Studi e Ricerche sulle Culture Popolari Venete», patrocinata dalla Regione del Veneto e impegnata sistematicamente nella memorizzazione di vicende dalla lunga durata.
Il volume comprende anche un ricco corredo di fotografie e di tavole, che contribuiscono in maniera determinante a restituirci nel loro insieme le tecniche della fienagione e le sue parole, riconfermando ancora una volta l'indissolubile rapporto che da sempre lega cultura materiale e lingua: da un lato il lavoro, dall'altro un ambiente, un paessaggio geoantropico in cui natura e presenza umana interagiscono.
 Giuseppe Brugnoli
Giuseppe Brugnoli
L'ironia di Dio
«www.culturaeculture.it»
22-01-2013
Parte da questo assunto L’ironia di Dio, quasi un romanzo, libro che racconta del pellegrinaggio alla grotta di Massabielle di un anonimo professore universitario, né credente né miscredente, che si reca a Lourdes con l’unico scopo di dimostrare che i miracoli non esistono. Alla fine del percorso umano e spirituale che lo coinvolgerà, dovrà ricredersi e ammettere che i veri eventi prodigiosi non sono quelli che sconvolgono le leggi naturali ma quelli che spingono le persone a cambiare vita.
Dopo la morte della madre, unico legame affettivo stabile, il protagonista del romanzo, di cui non conosceremo mai il nome, si lascia convincere dal suo vecchio insegnante di religione al liceo, ora divenuto vescovo, ad intraprendere il pellegrinaggio. Solo e insoddisfatto della propria esistenza, l’uomo accetta e si imbarca sul treno per la Francia in qualità di barelliere insieme ad altre sei persone. La settima assegnata al suo scompartimento non si presenterà. Ognuno si reca a Lourdes in cerca del proprio miracolo, portando con sé le angosce e le inquietudini della vita. Ognuno, alla fine del percorso, otterrà quanto richiesto anche se ci sarà un prezzo da pagare.
Il protagonista vivrà il pellegrinaggio e il resto della sua vita sospeso tra lo scetticismo e il desiderio di riscoprire la fede che, al pari del miracolo, non ha la forza di una tempesta o di un terremoto, ma somiglia a un venticello leggero, appena percettibile, in grado di dare sollievo anche nelle giornate più afose.
I miracoli avvenuti a Lourdes non saranno immediatamente visibili ma si manifesteranno con il tempo. Il protagonista ne verrà a conoscenza al matrimonio di uno dei suoi compagni di viaggio e, proprio quando comincerà a pensare di essere l’unico a non aver ricevuto segni, vedrà il piccolo miracolo anche nella sua vita, che cambierà radicalmente e diventerà ricca di quell’amore e quel senso di appartenenza e soddisfazione che gli erano mancati in precedenza.
Il libro si chiude con la stessa considerazione con la quale si era aperto ma questa volta, alla luce dell’esperienza, il protagonista comprende che i piccoli miracoli, quelli assimilabili al “caso”, non sono altro che il frutto dell’ironia di Dio che agisce nei piccoli fatti della quotidianità, quell’ironia che è «il guizzo di un’intelligenza superiore che affronta il problema e lo risolve da un angolo mai neppure intravisto prima, e che in qualche modo si diverte a scompaginare e rovesciare i termini della discussione, lasciando tutto apparentemente intatto in superficie, ma profondamente mutato la suo interno, anche se nulla sembra aver influito sul corso degli avvenimenti, che si susseguono secondo una logica apparentemente casuale che noi usiamo chiamare destino». (Piera Vincenti)
«La Voce dei Berici»
23-09-2012
Non è difficile infatti ravvisare nel racconto un'esperienza personale, che via via emerge fino a risultare non più ristretta al narratore, ma capace di interpellare e coinvolgere chi legge.
La cornice narrativa di un viaggio a Lourdes si presta perfettamente a delineare un vero percorso di ricerca, che il protagonista vuole compiere per trovare un senso alla propria vita, apparentemente riuscita (è un professore universitario), ma in realtà priva di valori autentici. L'incontro con il suo insegnante di religione al liceo, un vecchio prete saggio e anticonformista, è l'occasione per raccogliere una sfida con sé stesso, con lo spirito scettico e razionalista che alberga in ogni essere pensante, ed è questo che dà al romanzo una dimensione universale. Chi di noi non vorrebbe avere la prova provata di un miracolo, della presenza indubbia del divino nella sua vita?
Il racconto si legge d'un fiato, è scritto con una verve giornalistica che alterna sapientemente toni umoristici e profonde intuizioni. Gustosi sono i profili e le innocenti manie degli altri compagni di viaggio, i barellieri volontari che assistono i malati sul treno che corre verso il famoso santuario mariano. Ognuno di essi, in cuor suo, si aspetta un miracolo, una prova tangibile della propria fede, mentre il narratore lo vorrebbe per poter credere. In realtà nessuno ottiene la grazia sperata: ne ottiene un'altra, perché Dio ha le sue strade, a noi ignote, con le quali raggiunge e incontra gli uomini, trasformando la loro vita.
Anche il narratore cambierà vita e deciderà di spenderla non tanto cavillando su argomenti che la ragione non riesce a dipanare, bensì donando tempo ed energie per chi è povero e dimenticato dalla società dei consumi.
Questa storia di un «cercatore di miracoli» si può ben dire una parabola della vita di ciascuno: Dio sa dove va il nostro cammino, è lui che in modo imprevisto e imprevedibile ci aspetta all'angolo della strada o a una svolta repentina, che si rivela alla fine una via di salvezza. (Luigi Dal Lago)
«Il Piccolo»
14-08-2012
La dimostrazione, sperimentata per sé e per il suo vecchio insegnante di religione, è che Dio non esista, che i miracoli siano pure fantasie umane, se non straordinarie coincidenze. Insomma, per dirla come Aratole France, che il Caso sia lo pseudonimo di Dio. C'è molto fascino in questo personaggio annoiato, scritto in punta di penna e la cui eleganza si punteggia di ironia. Brugnoli riesce a destrutturare, soprattutto nella prima parte, quella sorta di bigottismo e misticismo che spesso si pensa (impropriamente) intorno a qualsiasi ente religioso. Non è una sfida facile, anche perché è una provocazione che decide di andare contro il luogo comune del pensiero laico, contro la scienza dell'intellighentia, contro ciò per cui (e per molti intellettuali) non vale proprio la pena di soffermarsi. Insomma parlare di Dio è piuttosto controcorrente. Il coraggio di Brugnoli è farlo tramite una voce romanzata. Non solo. Tramite una storia che ci porta a Lourdes, destinazione che avrà il compito di deridere gli assurdi pellegrinaggi, i presunti miracoli, i fanatici commerci.
Ed è con quest'animo che il protagonista decide di intraprendere il tragitto. Con lui altri compagni di viaggio, ognuno alla ricerca della sua personalissima grazia. Richieste non così complicate: figli irriconoscenti, lavori frustranti, matrimoni alla deriva, in fondo piccole invocazioni umane. Il dono, se così si può chiamare, avverrà a distanza di tempo, quando il nostro scoprirà che – a un prezzo talvolta alto – Dio ha collaborato alla risoluzione di quei problemi, non senza una punta d'ironia: «Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie…». Nessun miracolo è dato nella forma in cui ce lo aspettiamo. Prospettiva ben sviluppata nella struttura narrativa e nello stile. E miracolosa è l'attesa di un cambiamento, l'eterna pazienza per affrontare il disordine, non senza un'apertura all'idea di speranza e di comunità. Brugnoli ci restituisce una scrittura persuasiva quando racconta di luoghi e persone quotidiane. Quando traccia vecchie e nuove mappe mentali. Quando trasfigura i paesaggi in luminosi quadri o indossa, come una maschera, un doloroso monologo. Quando il miracolo è aprirsi all'altro senza muri di verità inquisite. (Mary Barbara Tolusso)
«Corriere di Verona»
27-07-2012
Funziona così, l'«ironia di Dio». Quel «quasi un romanzo», come lo definisce un vezzoso sottotitolo in corsivo, «a cura» di Giuseppe Brugnoli. Perchè quello che si definisce «storia di un "cercatore di miracoli" e di sette barellieri in treno per Lourdes», quello che vuole essere «un libro che invita a riflettere sulla natura della fede e sull'intervento di Dio nella vita quotidiana», in realtà, oltre al mistero assoluto del rapporto tra uomo e Altissimo, di «enigmi» ne nasconde più d'uno. A partire da quel «quasi un romanzo» per arrivare a quel «a cura di Giuseppe Brugnoli». È solo nell'appendice che quello che è stato per oltre vent'anni direttore de «L' Arena» e del «Giornale di Vicenza» racconta di quel plico ricevuto da un monsignore.
Letto e trascritto «al computer, apportandovi qualche lieve modifica per rispettare la richiesta di anonimato fattami da chi me l'aveva affidato e che del resto rispettava l'intenzione dell'autore. Qualche volta, durante il lavoro di trascrizione, mi era venuta voglia di ricercarne le tracce per identificarlo: una tentazione a cui ho resistito, per cui dell'autore di questo scritto non so nulla di più di quanto egli abbia voluto dire».
E ha voluto dire tantissimo, in realtà. Perchè non serve un nome e un cognome, un'identità anagrafica o di luogo, quando metti a nudo la parte più pudica della natura umana: quella che riguarda il rapporto con quel Dio in cui molti hanno il dono di credere. E del quale altrettanti dubitano.
Giacomo è un giovane professore universitario che della «Fede» non ha mai fatto un dogma. E per il quale un viaggio a Lourdes diventa una sorta di chiave di volta. Spirituale, ma anche molto umana. Per lui, ma anche per quei suoi cinque compagni di viaggio che, come lui, su quel treno di pellegrini salgono come volontari. «Eccomi qui – racconta Giacomo – davanti alla grotta alla quale ero stato spinto, me ne rendevo conto in quel momento, soltanto dalla morbosa curiosità di tutti: per vedere il miracolo, per accertarmi visivamente, concretamente, dell'esistenza di un'altra dimensione, misteriosa e sconosciuta, invano investigata da filosofi, sapienti, santi, lungo inutili millenni. Una dimensione più alta di quella del quotidiano in cui siamo immersi, e che avrebbe potuto dare significato alla mia vita, come a quella di milioni di pellegrini che erano approdati da tutto il mondo a quel luogo...». E «l'ironia di Dio», Giacomo come ciascuno, la incontrerà... (Angiola Petronio)
«L'Arena»
19-07-2012
Pensare che Dio sia capace di ironia non è cosa di tutti i giorni. Di sicuro è un’ipotesi seducente, come affidare un messaggio a una bottiglia abbandonata alle onde, certi che qualcuno in qualche dove la troverà e leggerà.
Già in copertina L’ironia di Dio. Quasi un romanzo dice abbastanza. C’è chi indossa un nom de plùme per non firmarsi e chi precisa di aver solo redatto, con interventi minimi, esclusivamente in chiave di riservatezza, il testo che il gioco dei venti e delle maree esistenziali gli ha consegnato perché altri, molti altri, lo leggano. Così ha scelto Giuseppe Brugnoli, che per Angelo Colla Editore consegna alle stampe lo scritto che il tempo (ancora!) ha custodito come un seme addormentato in attesa del risveglio. Lui, direttore del «Giornale di Vicenza» e poi dell’«Arena» per oltre vent’anni, non ha urgenza di mettere in mostra il suo mestiere come chi ben sa d’essere capace di cambiare codifica in ragione del lettore e dell’occasione senza infingimenti né artifizi.
Il «quasi romanzo», dando per buona la storia del faldone giunto tra le sue mani dopo chissà quale viaggio, è una prova d’autore. Detto senza piaggeria ché suonerebbe per il direttore come uno sfottò e ci mancherebbe pure farsi guardare in cagnesco per uno scherzuccio di dozzina.
DUNQUE, l’anonimo protagonista è un «cuore in inverno», per dirla alla Sautet, un solitario solo come un cane, con una cronometrica, noiosa vita da docente universitario. Misogino, misantropo, ipocondriaco e dichiaratamente antipatico. Aggiungiamo: spocchioso più che snob, provinciale per DNA, un irrisolto con cui si scambierebbe a fatica un «buongiorno» in ascensore. Guardiamoci intorno, guardiamoci dentro: ne vedremo un battaglione schierato per benino.
TAGORE diceva che ogni buona cosa nasce da un gesto d’intelligenza. Un prete, don Aldo, vecchio professore di liceo, innocente ma tutt’altro che inesperto, del nostro infelice scrittore. Una specula e una sfida: il miracolo (etimologicamente: la cosa meravigliosa) non è la gamba amputata che ricresce, ma lo straordinario (perché fuori dall’ordinario), quotidiano incastro del gigantesco puzzle di cui siamo la più piccola e insignificante tessera.
Sali sul treno e vai a Lourdes, abbi l’umiltà di attendere e di provare, di ammettere e di accettare, di sconfessarti da solo e di confessare. Di essere più lieve, più aereo, più vivo.
Qualcuno verrà, qualcosa accadrà. Forse, il fittone del miracolo già germoglia nel buio voluto della nostra esistenza che il più delle volte è «campare».
Come la diligenza in Ombre Rosse di John Ford. Sei barellieri, compreso il protagonista e un settimo che non c’è, alla Ibsen. Ciascuno con il suo sogno molto umano, il suo alibi, la sua pretesa.
Più avanti, molto più avanti, vicino alla motrice, gli scompartimenti dei malati e di chi li accompagna.
Un bambino di quarant’anni vaga nella demenza vegliato dagli occhi di cielo di una mamma dalle ossa di cristallo che ne va orgogliosa. Veci e bocia con il cappello da alpino cuociono una minestra di fagioli sorprendentemente buona. Anche la moquette delle Ferrovie dello Stato può essere un giaciglio confortevole per un uomo se avverte che il pugno di ghiaccio che gli rinserra in cuore sta allentando la stretta.
DIO ha tempo di aspettare. Il treno corre nella notte e nel giorno e nella metafora dell’attraversamento. Il filtro della fisiognomica (un uomo corpulento, un giovanotto simpatico, un untuoso divoratore di cioccolatini che conserva la stagnola «per le missioni», uno smilzo biondiccio, un cinquantenne brizzolato e arruffato) lascia spazio a una lettura dell’altro che, finalmente!, sfiora la solidarietà e poi la pietas, e in primis, il rispetto.
La pietra in cui il protagonista ha blindato se stesso si frattura come un uovo alla schiu- sa. Ogni uomo vale una storia e la più flebile, un canto.
Il miracolo è già avvenuto al primo sobbalzo del treno sulla giunzione tra le rotaie. Sotto la pioggia, a Lourdes, nel bric à brac di Madonne fosforescenti e grotte di plastica illuminate a led. In una parola desueta ma abusata: «amico».
Tutto può essere occasione e seduzione, nella dismissione di noi stessi, anche la letizia udita e trattenuta a pochi passi da una casa d’angolo che libera l’armonia famigliare mai conosciuta dal professore d’università nel cimiteriale silenzio della sua abitazione.
La commozione è uno dei primi passi. Non c’è vergogna nel chiedere.
Lo si voglia o no, credere è anche il supremo gesto d’intelligenza, l’ipotesi prima ed estrema.
L’ANONIMO autore (diciamo così, fedeli alle note del curatore), nei reflussi da pollaio borghese in cui zampetta la comunità cittadina di appartenenza, è tentato di stilare una graduatoria di merito per chi attende il miracolo, sia esso la riconciliazione con i figli, la guarigione da un male incurabile, la definizione di una situazione sentimentale in cui si vorrebbe tirare Dio per la giacchetta...
Questione di ore, questione di dolore. Anche questo vezzo da autosopravvalutazione sparirà.
La tentazione di continuare ci sarebbe, eccome, ma il compito affidatoci è di presentare e non di svelare e dunque ci fermiamo qui, prendendoci la libertà di anticipare che un’altra occasione (di festa, stavolta), darà modo al nostro di comprendere che i cinque barellieri stipati in quel vagone e anche il settimo, contando il protagonista, che mai si è visto, sono stati esauditi.
L’ULTIMO, eccolo in articulo mortis, sulle pagine più lette di uno storico quotidiano locale. Ci correggiamo: sulle pagine lette prima di tutte le altre, quelle con le «testine», tanto per capirci. Era un uomo che contava, e ha lasciato i suoi beni in beneficenza. Il Carneade scrittore se ne andrà lontano, molto lontano, in America Latina, forte di una cesura volutamente irrimediabile con la vita di prima.
Capita che non ci sia più tempo per rimandare la ricerca della pace su questa terra e in quell’istante, la rete si tende e i nostri viottoli commerciali, sentimentali, politici e carrieristici sono meno di una ditata sulla battigia.
Chissà che non sia anche questa l’ironia di Dio. (Donatello Bellomo)
«Il Giornale di Vicenza»
12-07-2012
Una scrittura tesa e pensosa analizza con attenzione la vita e la psicologia di questo giovane studioso nato e cresciuto nella silenziosa penombra di un’austera casa borghese abitata dallo spirito di una madre esigente e severa, che finisce col rinchiuderlo in un recinto asettico e sostanzialmente tirannico, dal quale ogni via di fuga appare rigorosamente preclusa. Una scrittura, quella di Brugnoli, che ricorrendo all’espediente del manoscritto casualmente ritrovato e pubblicato, ricerca una meditata distanza dai fatti narrati, quasi a levigarne ogni vibrazione troppo accesa, ogni coinvolgimento troppo ravvicinato e scoperto.
Il movimento narrativo, stratificato e avvolgente, passa dunque dalla prima persona del giovane docente che ripercorre le strane coincidenze che lo hanno portato sulla strada di Lourdes, al disvelamento finale di un diario raccolto e curato da una terza persona che di queste pagine si fa divulgatore e imparziale testimone. Una soluzione a doppia mandata. Un vorticoso gioco di scatole cinesi con epilogo e sorpresa. Invitato dopo qualche tempo al matrimonio di uno dei cinque barellieri, l’autore del memoriale scopre infatti che qualcosa di speciale in quel lontano pellegrinaggio deve essere per forza accaduto, se è vero come è vero che ognuno dei suoi compagni di viaggio ha visto alla fine esauditi i propri desideri. Nessun botto miracolistico, ben inteso, nessuna deflagrazione mirabolante, nessun fatto inconsueto in grado di rompere violentemente le regole. Molto più semplicemente «un procedere sotterraneo, per vie del tutto ordinarie, ha disposto gli avvenimenti secondo una coordinazione cronologica e logica perfettamente spiegabile».
L’ironia di Dio, evocata nel titolo del «quasi romanzo» di Brugnoli, si svela dunque «nel guizzo di un’ intelligenza superiore che affronta il problema e lo risolve da un angolo imprevisto, lasciando tutto apparentemente intatto in superficie, ma profondamente mutato al suo interno». Non eventi straordinari, ma deviazioni minime in grado di produrre effetti inattesi, i cui esiti finiranno con il riverberarsi anche sull’autore del diario, che lascerà docenza e abitudini consolidate per trasferirsi armi e bagagli in una sperduta contrada andina. Riconciliato con la sua parte più genuina e profonda, si sentirà finalmente capace di accogliere e assaporare la pienezza e bellezza di un’esistenza che in quel luogo sembra evocare l’intensità di cieli e terre nuove, «dove gli odori sono insieme profumi intensi e quasi violenti di fiori sconosciuti che si aprono nella notte, e zaffate imperiose di fetori di una terra che marcisce e si rinnova continuamente».
Razionalità e ricerca d’assoluto s’intrecciano all’interno di un percorso narrativo che nella misura stilistica, nell’attenta tessitura tonale, in un ritmo agile e contenuto trova le giuste coordinate di un movimento espressivo ampio e analitico, che nel finale si apre a un lirismo delicato e sospeso, su cui risplende «un cielo fitto di stelle, così vivide e vicine che pare di toccarle...». (Maurizia Veladiano)
 Alessandro Zaltron
Alessandro Zaltron
Crociera e delizia
«Marco Polo»
01-12-2012
Sono moltissimi i curiosi della crociera che si accingo a salire per la prima volta su una nave senza immaginare cosa li attenda. Alessandro Zaltron svela tutti i preparativi pe rla partenza e i retroscena della vita a bordo. Un vademecum di sopravvivenza, per non farsi trovare impreparati. (Isa Grassano)
«Traveller»
01-08-2012
L'autore in crociera ci è andato davvero (ma probabilmente non ci tornerà più) e ha scritto un libretto che nessuna compagnia navale dovrebbe ignorare. Divertente, cattivello (non vi offendete se leggendolo scoprirete che tra tutte le vacanze quella in alto mare è decisamente foolproof, cioè a prova di cretini, perché a bordo vi verrà chiesto, a chiare lettere, di non occupare dieci sdraio con oggetti vari se siete da soli o di non usare il ferro da stiro in cabina, o ancora di coprirvi il naso e la bocca con un fazzoletto quando tossite o starnutite), ma sicuramente utile per affrontare la convivenza forzata (e democraticamente esclusiva) di una settimana in mezzo al mare insieme a emeriti sconosciuti.
«La Tribuna»
03-07-2012
 Howard Burns
Howard Burns
La villa italiana del Rinascimento
«Il Sole 24 Ore»
02-09-2012
Già a partire dal titolo, Ackerman metteva in tensione il tradizionale approccio architettonico formale con la specificità del fenomeno-villa, vale a dire la nascita nel Rinascimento di una tipologia nuova, generata da una ideologia: il culto delle virtù, dei piaceri e dei vantaggi della vita in campagna (naturalmente dal punto di vista del proprietario e non del contadino). Nel farlo, Ackerman dichiarava i suoi debiti verso scritti come Civiltà delle ville venete di Michelangelo Muraro, pubblicato nel 1964, Committenza e tipologie nelle ville palladiane di Manfredo Tafuri del 1969 o il libro di Bentmann e Müller sulla villa come architettura di potere, Die Villa als Herrschaftsarchitektur, pubblicato nel 1970. Per la prima volta un libro ricostruiva l'intera parabola della residenza in campagna in Italia e della sua successiva fortuna nel mondo anglosassone, dalle prime ville medicee a Frank Lloyd Wright, intrecciando architettura e testi letterari.
Con La villa italiana del Rinascimento, Howard Burns intreccia un dialogo a distanza con gli studi di Ackerman e dei suoi predecessori. Restringe lo sguardo ai due primi secoli dell'invenzione della villa, il Quattrocento e il Cinquecento, ma al tempo stesso lo allarga a una scala europea che non esclude la Francia e l'Inghilterra o la Russia, ma nemmeno l'Oriente, con arguti parallelismi fra la villa di Poggio a Caiano di Lorenzo il Magnifico e i padiglioni di divertimento ottomani o persiani a pianta centrale, come il Cinili Kösk a Istanbul.
Burns si pone innanzitutto il problema di definire il territorio di indagine. Da un lato si domanda quanto, nella corsa rinascimentale all'insediamento in campagna, siano campioni significativi i capolavori che fanno la storia dell'architettura, quelli che noi siamo abituati a identificare come «le ville rinascimentali»: edifici simmetrici, baricentro di complessi gerarchicamente organizzati, aperti su paesaggio o giardini, con colonne e frontoni. Un quesito di norma insolubile per le trasformazioni subite dagli edifici nei secoli successivi, ma Burns pone la nostra attenzione su un taccuino del 1578 dove un ignoto disegnatore schizza più di duecento significative residenze campestri nel Bolognese. Come la zanzara imprigionata nell'ambra di Jurassic Park quelle veristiche vedute ci consentono di rivivere virtualmente la campagna cinquecentesca, e scoprirla popolata di edifici eterogenei e irregolari, per la maggior parte ancora con caratteri difensivi come torri e merlature, eredità delle residenze medievali fortificate. Rare sono le logge aperte, e ancor più l'esibizione degli ordini architettonici.
Non c'è dubbio che la crescita demografica di fine Quattrocento, la crescente redditività dell'agricoltura, le grandi bonifiche nei territori di Venezia, Ferrara e Milano nonché la pace diffusa a partire dagli anni Trenta del Cinquecento provocarono in Italia un rinnovato interesse per la vita in campagna da parte delle élite cittadine. Ma ci deve essere chiaro che solamente un sottoinsieme seppe coniugare la residenza campestre con edifici innovativi in grado di distinguersi sia dai castelli che dai palazzi di città. Di essi Burns racconta la storia, a partire dalle ville medicee fiorentine, e ripercorrendo le grandi realizzazioni dalla Farnesina di Peruzzi a villa Madama di Raffaello, fino a palazzo Te e a Palladio.
È la storia di un'affermazione progressiva della villa come forma architettonica aperta sulla natura e il paesaggio, i cui caratteri specifici vengono messi a punto dapprima in edifici che sorgevano appena fuori delle mura cittadine, dove le necessità difensive erano meno marcate, per progressivamente trapiantarsi più addentro nella campagna. Sul piano ideologico, gli scritti di Petrarca, Boccaccio, Alberti, Pietro Bembo, Palladio e Bernardo Tasso, a loro volta in larga misura fondati su Cicerone, Virgilio o Varrone, rafforzarono la convinzione della maggiore qualità della vita campestre, e non solo per motivi economici, per sfuggire i morbi o per addestrarsi alla battaglia cacciando.
La casa di campagna diviene il luogo dove praticare il «buon vivere» in ogni senso, dove la virtù non è vista in contrasto con il profitto e dove viene a definirsi - nel Veneto come poi nelle campagne inglesi e russe o nell'America di Jefferson - la nuova figura sociale del proprietario di villa «gentiluomo». Ben diverso dal prepotente nobile feudale, egli si impegna nel gestire oculatamente i propri possedimenti, a vivere in modo sano e a usare il proprio tempo anche per una crescita culturale e spirituale. È un ideale sociale che Burns pone in dialettica con il «cortegiano» di Castiglione, un paragone che già nel Cinquecento il francescano Guevara, predicatore di corte di Carlo V, radicalizzava nell'opporre esplicitamente l'immoralità della vita di corte alla sobria moralità di quella in campagna.
La storia secolare della villa è quella di un rapporto in equilibrio fra mondo urbano e rurale, che oggi si è rotto, soprattutto nei territori dell'Italia settentrionale dove l'edificazione sta progressivamente cannibalizzando le campagne e assediando le ville. Va anche detto che certamente il bucolico Veneto agricolo del primo Novecento era cosa diversa dall'attuale, ma era anche una terra da cui emigrarono per fame milioni di persone. Per salvare le ville va pensato un nuovo rapporto con la campagna, in chiave anche economica. (Guido Beltramini)
«Il Gazzettino»
26-05-2012
Nell'analizzare quella che è forse la tipologia edilizia che meglio caratterizza il paesaggio nordestino (e italiano) e ne qualifica l'offerta turistica dalle ville palladiane, a Palazzo Te o a villa d'Este, il presidente del Comitato scientifico del Cisa intreccia sapientemente storia dell'architettura e storia sociale, economia e costume. Da questo quadro ricco e vivace emerge che le ville in Italia non sono luoghi della vacanza per nobili annoiati, che esaltano se stessi tramite l'architettura. Esse piuttosto, a volte vere e proprie eredi del castello medioevale, rispondono alle esigenze di sicurezza e sfruttamento economico delle campagne, in vista dell'aumento della produzione agricola reclamato dall'incremento demografico e dal desiderio di autonomia alimentare registrato negli Stati a partire da fine Quattrocento. (S.F.)
 Valentina Casarotto
Valentina Casarotto
Il segreto nello sguardo
«http://babilonia61.com»
25-04-2012
La Storia per me non è un concetto astratto. Per uno studioso è il respiro dei manoscritti, la polvere dei volumi antichi, il fascino delle incisioni, la fragilità della carta corrosa dall’inchiostro ferroso, è il soffio della vita del passato che rivive nei particolari insignificanti della quotidianità: un termine in dialetto in una lettera del Seicento, una glossa privata che si insinua in un atto pubblico. Spesso, mentre sfoglio i manoscritti, ascolto la musica del medesimo secolo e magari ricordo la produzione di qualche pittore coevo. Mi sembra che mi aiuti a capire maggiormente quel tempo che dista da noi qualche secolo. Come si vede quindi per me il rapporto con la Storia è una necessità declinata al presente.
Che cosa significa avere coscienza storica e a che cosa serve?
La coscienza storica è saper attribuire un valore agli oggetti che la storia ci ha consegnato in eredità ma anche in custodia per le generazioni future, come del resto cita il nostro Codice dei Beni culturali e la Costituzione Italiana. La comprensione del valore di un bene quale testimonianza di una civiltà o di un momento storico inizia attraverso la conoscenza delle sue caratteristiche materiali e stilistiche, si realizza attraverso la tutela del bene nella sua integrità, ma si concretizza pienamente attraverso la valorizzazione, che è poi un processo di condivisione del suo valore con l’intera società. In ultima analisi solo la coscienza storica permette di preservare e tramandare il passato, comprendendone il valore assoluto per l’intera umanità.
Coscienza storica potrebbe significare anche prepararsi per scrivere un romanzo come quello suo, Il segreto nello sguardo, in cui Rosalba Carriera è la protagonista, quindi indagare, ricercare, analizzare, verificare dati, e allora mi chiedo: dove finisce la storia e inizia la fantasia del romanziere?
Mi sono avvicinata a quel confine con profondo timore, data la mia natura di storico dell’arte. Quando ho scritto il prologo del romanzo, nel 2003, sotto una sorta di suggestione provata davanti all’ultimo ritratto di Rosalba Carriera conservato alle Gallerie dell’Accademia – dove a quel tempo lavoravo – mi sono sentita decisamente intimorita dalla mole di studio che avrei dovuto affrontare. Il sostegno e l’incoraggiamento di molti amici mi ha persuaso a tentare l’impresa.
Il punto di partenza è stato lo studio dei ritratti, scegliendo come fil rouge del romanzo quelli da cui spiccava un aspetto vivido della personalità del soggetto: gli occhi tristi di Federico IV di Danimarca, lo sguardo giocoso di Luigi XV fanciullo, il piglio piccato di una fanciulla con la scimmietta, lo sguardo languido del pittore Antoine Watteau, la spavalderia della contralto Faustina Bordoni Hasse, e così proseguendo. Perché questo è un romanzo d’arte sull’arte, in cui le opere sono protagoniste al pari di Rosalba Carriera: è un racconto sull’arte del ritratto, sulle vicende dei personaggi ritrattati, sull’intreccio del collezionismo internazionale a Venezia e a Parigi, ma anche sulla mondanità e sulla cultura – fatta di teatro, feste, opere liriche e concerti realmente avvenuti – della prima metà del Settecento.
Intrecciando documenti e ritratti, la parte inventiva fioriva spontaneamente dallo studio dei carteggi, dei diari della pittrice, i quali mi avvicinavano al suo animo, all’indole determinata e alle motivazioni delle sue scelte di vita. È stato un passo naturale incrociare questi dati con la Storia e gli eventi della società del tempo, scoprendo singolari punti di tangenza. La fitta trama storica, precisa nei minimi particolari, a uno sguardo d’insieme si schiudeva da sola a suggerirmi l’invenzione poetica. Del resto, l’espediente dell’io narrante, che ho sempre considerato l’unica scelta possibile, racconta i riti dell’aristocrazia e del bel mondo veneziano e parigino del tempo e ha il merito di coinvolgere profondamente nella vicenda umana della pittrice, restituendo alla sua voce sentimenti, speranze, ambizioni e rimpianti.
Era un mio fermo proposito inoltre mantenere per ogni personaggio le caratteristiche più evidenti della personalità che spiccava dallo studio dei documenti: l’alterigia del consigliere de Brosses, la machiavellica personalità del finanziare John Law, il carattere seduttivo e contraddittorio del Reggente. E in particolar modo ho cercato di rispettare l’indole di Rosalba Carriera in ogni suo gesto o parola, cercando di rendere giustizia a una donna che in un modo sorprendentemente pacato ha raggiunto un grado di libertà, indipendenza e affermazione professionale assolutamente invidiabile e unico per quel tempo. Quindi nei dialoghi e negli incontri, plausibilmente verosimili o storicamente avvenuti, ho immaginato le sfumature emotive e le tensioni sentimentali, mentre ho conservato quasi integri i contenuti, rimodulati da lettere, diari e resoconti degli stessi protagonisti o di personaggi a loro vicini.
Perché proprio Rosalba Carriera, cosa le ha colpito, qual è stato l’elemento, se esiste, che l’ha spinta a scrivere di lei?
Essendo i miei pittori favoriti Giovanni Bellini e Tintoretto, la risposta a questa domanda non è così scontata. Trascinata da alcuni studi sul Settecento e sul Grand-Tour in occasione di un’esposizione temporanea, mi sono avvicinata con maggiore consapevolezza alla opere di Rosalba Carriera esposte alle Gallerie dell’Accademia, cosa che è abbastanza rara per i noti problemi di conservazione del materiale.
Solo guardando, anche con occhio poco allenato, i suoi ritratti a pastello si può comprendere la fascinazione che ho subìto. Rosalba era una virtuosa in questa tecnica, primeggiava nella leggerezza di tocco e nelle sfumature impalpabili. La sua maestria nel rendere la verosimiglianza fisiognomica del personaggio con quel velato tocco di idealizzazione richiesto dalla committenza, ne ha decretato il successo europeo. Mi ha colpito poi il suo carattere a tratti gioviale, amante della conversazione, delle feste e del teatro, e per altri aspetti malinconico e solitario. M’incuriosiva questo soprattutto quella sua tanto decantata moderazione, definita dalle sue stesse parole “priva di eccessi”, e mi sono stupita che fosse accompagnata da una tenacia straordinaria, che le ha permesso di raggiungere una posizione invidiabile, conquistata sul campo e con un’oculata gestione del suo dono, senza il clamore di scandali o relazioni pericolose. Una rivoluzionaria silenziosa la definirei…
Che cosa ha permesso alla nostra pittrice aver successo in una società che è vero apriva lentamente alle donne, ma ancor chiusa dentro certi parametri sociali?
Potrei citare Roberto Longhi, che fu il primo a rivendicare nella nostra epoca la grandezza di Rosalba, pur vissuta nel tanto vituperato Rococò, poiché “seppe esprimere con forza impareggiabile la svaporata delicatezza dell’epoca”.
Eppure, anche secondo la critica moderna, oltre alla innegabile bravura, furono una serie di caratteristiche precise delle sue opere a decretarne il successo. Innanzitutto il genere del ritratto era un genere minore, uno dei meno lucrosi, e il ritratto a pastello poi ancor meno. Era quindi adatto a esser praticato da una donna, da sempre esclusa, salvo rari casi, dalla più remunerativa pittura di storia e dai generi maggiori. La velocità propria di questa tecnica, non paragonabile alle lunghe ore delle sedute dei ritratti a olio, lo rendeva un acquisto perfetto per i viaggiatori del Grand Tour che giungevano a Venezia sulla via del ritorno in patria: veloce da realizzare, poco costoso, facilmente trasportabile. Le caratteristiche peculiari del pastello poi si adattavano magnificamente all’estetica fragile ed effimera del Rococò, e l’esser donna assecondava la mania dell’esclusività e della ricercatezza delle novità tipica del secolo: cosa poteva esserci di più raro ed esclusivo di un ritratto dipinto da una donna?
È pur vero che la società tuttavia, proprio in quel momento storico, stava lentamente cambiando. Negli anni ’20 del secolo si stava dibattendo nelle Accademie e nei salotti, anche in modo appassionato, l’accesso delle donne allo studio e alla libertà di espressione. Nel salotto di Rosalba Carriera erano spesso ospiti nobildonne e letterate, cantanti e attrici che opera dopo opera rosicchiavano brandelli di concessioni alla causa del gentil sesso. Ed è proprio questo momento storico che si respira nella seconda parte del romanzo. (intervista di Gaspare Armato)
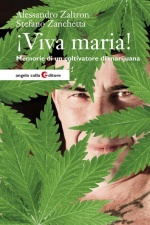 Alessandro Zaltron, Stefano Zanchetta
Alessandro Zaltron, Stefano Zanchetta
¡Viva maria!
«L'Indice dei libri del mese»
15-09-2012
L'occasione la fornisce la recente pubblicazione di Viva maria! Memorie di un coltivatore di marijuana, monologo autobiografico raccolto da Alessandro Zaltron sulla base di una serie di interviste a Stefano Zanchetta, considerato uno dei più esperti coltivatori di marijuana in Italia, e all'epoca dei colloqui detenuto nel carcere di Vicenza. La biografia di Zanchetta è assai rocambolesca, e conquista le pagine presentando una figura di produttore-consumatore di cannabis lontana dai prestampati dell'immaginario condiviso: da un coscienzioso fumatore di marijuana con l'attitudine per il misticismo ecologista difficilmente ci si attende un passato nella Folgore e negli ambienti della "sicurezza privata" in Italia e in Africa, solo per citare alcuni degli avventurosi trascorsi de l'hombre marijuano, come ebbe a soprannominarlo un'anziana cubana
A dispetto del titolo di cannabis non si parla poi molto, in questo libro: ma quando avviene, appare chiaro che la marijuana di cui Zanchetta ha fatto una passione viscerale non ha nulla a che vedere con la "droga" comunemente intesa. Zanchetta è una figura più simile a uno sciamano (salta anche in mente una specie di monaco guerriero, non fosse un'immagine fin troppo estemporanea), che costruisce innanzitutto un rapporto spirituale con la pianta, e prima ancora con la terra su cui decide di curarne la coltura: l'atto del fumare è il compimento di un processo lento e naturale, diametralmente opposto alla cultura da supermarket che caratterizza il consumo di sostanze oggi. Per una personalità come Zanchetta l'ipotesi della legalizzazione del commercio di cannabis non ha senso, come non ha senso lo "sballo" in quanto tale, l'ebrezza che non abbia un fine meditativo, autoconoscitivo, elevato e dunque necessariamente regolato: chi vuole fumare marijuana dovrebbe innanzitutto assumersi la responsabilità di coltivarla, accudirla, farla sua: conoscerla, non acquistarla. Altrimenti è inutile o, peggio, dannosa.
In diversi passaggi, l'hombre marijuano sottolinea il controsenso intrinseco al fenomeno del consumo di cannabis nella nostra società: la sostanza è illegale, ma il suo utilizzo, oltre ad essere in costante espansione, è ormai ampiamente tollerato dai costumi. È un peccato che simili riflessioni occupino poche decine di pagine del volume, perchè si tratta di questioni centrali nel valutare il fenomeno droga - non solo cannabis - e distinguere la pratica di consumo dall'emergenza, prendendo in considerazione alcuni dei cosiddetti fattori protettivi: tra cui il rispetto della sostanza in quanto pharmakon (tanto rimedio quanto veleno), per le sue potenzialità, rischi, scopi: da questo discende il senso che il consumatore attribuisce al gesto (al rito) e agli effetti che l'assunzione produce sulla percezione, e dunque sull'esistenza, e che concorre a tracciare il discrimine tra uso, abuso e dipendenza patologica. (Luca Borello)
«Il Giornale di Vicenza»
27-03-2012
Ci siamo divisi i compiti: lui ha messo un pezzo delle sue avventure, io la narrazione. L'idea di scrivere un libro sulla filosofia di vita di Stefano Zanchetta mi è venuta a seguito del suo primo arresto, riportato con ampia evidenza visto che non si trattava del solito ragazzino sorpreso con mezzo grammo di 'fumo' ma di un uomo maturo che coltivava più di 3.000 piante di canapa, a casa sua, con una dedizione incredibile. Lui ha accettato di raccontarmi la sua storia e l'ha fatto in dialetto e con il ricorso alla mimica. Si faceva capire bene! La mia sfida letteraria è stata quella di inventare una lingua italiana altrettanto vivace e una struttura romanzesca tale da rendere appassionante la vicenda umana e professionale di Zanchetta.
Ci sono diversi passaggi in cui si sostiene la liceità del consumo di droghe leggere. Pensiero del protagonista alla fine condiviso dall'autore o solo gioco delle parti?
Il protagonista, paradossalmente, è scettico sulla liberalizzazione delle droghe perché teme che il riconoscimento istituzionale della marijuana la trasformi in un business, sottopostoo alla medesima legge di massimizzazione del profitto a scapito della cura artigianale e della qualità del 'prodotto'. Personalmente, sono contrario a ogni proibizione immotivata. Se ammetto che l'uso smodato di marijuana – peraltro utilizzata nei secoli da mistici e papi – sia del tutto sconsigliabile, non posso esimermi dal notare gli effetti ben più gravi che producono molte altre dipendenze socialmente accettate: l'alcol, il gioco d'azzardo, il sesso, il lavoro smodato. Questo libro non è un inno alle droghe, leggere o pesanti che siano, ma la storia di un bandito guascone della provincia veneta.
Zanchetta ne ha combinate di tutti i colori. Mai una titubanza nella descrizione, talora anche efferata, di furti, pestaggi e altro?
L'hombre marijuano è un personaggio letterario che prende spunto dalla persona reale. Ha una sua coerenza intrinseca che può piacere o meno, ma lo rende unico e riconoscibile. L'aspetto che mi ha colpito di lui è che non è il classico 'fattone' ma ogni sua esperienza ha avuto alla base delle motivazioni forti, degli ideali, una sorta di etica. Chi si sente investito di una missione, per quanto discutibile a parere degli altri, non può avere esitazioni nel proprio agire. Non a caso è diventato «il più grande coltivatore europeo di marijuana».
Il libro è un tentativo di riabilitazione?
Una delle frasi che ho attribuito al protagonista è «Se mi pento? Sì, di non avere fatto di più». Il personaggio non chiede scusa, né cerca riabilitazioni tardive, proprio perché non ha agito a caso. Sapeva i rischi che correva, per ogni azione compiuta, e se ne è sempre assunto la responsabilità. Ora vuole condividere questa esperienza. ¡Viva maria!" è una biografia romanzata, la storia esemplare di una vita atipica, non certo l'arringa difensiva di una persona che, anche sul piano giudiziale, ha sempre saputo difendersi molto bene da sé. Però sono sicuro che chi l'ha emarginato dopo il suo arresto adesso non tarderà a riconoscerlo come amico. (Nicoletta Martelletto)
«Il Giornale di Vicenza»
27-03-2012
Pazientemente lo dissodò, estirpò le erbacce, piantò i semi miracolosi che s'era procurato in gran numero dopo lunghe peripezie e trattative. In capo a pochi mesi le piantine vegetarono rigogliose. Sole e acqua fecero il resto. Di suo, il coltivatore, ci mise tanta passione e una cura maniacale. Non passava giorno che non scalasse i mille metri di dislivello per curare le sue pianti-ne. Tanto zelo non sfuggì a chi frequentava regolarmente la montagna. Le voci di quella magica coltivazione arrivarono alle orecchie delle forze dell'ordine, che già tenevano d'occhio il povese. Avviarono, con discrezione, le indagini. Eseguirono appostamenti, prelevarono campioni, attesero il 'coltivatore' fino a sorprenderlo con le mani nel sacco.
Le piantine erano di cannabis, volgarmente conosciuta, come canapa indiana, ottime per ricavarne marijuana. Finirono sequestrate. Arrestato, invece, il 'contadino' che con tanta premura aveva seguito il loro sviluppo e già si stava preparando per il raccolto, certo che una volta immesse sul mercato le infiorescenze essicate e conciate avrebbero fruttato dei bei soldini.
Sono passati alcuni anni – denuncia nel 2004, arresto nel 2006 – da quella scoperta che suscitò clamore e sorpresa nel Bassanese e il coltivatore, Stefano Zanchetta, pagato il conto con la giustizia, ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare al nostro collega Alessandro Zaltron tutta la storia.
È nato così ¡Viva maria! Memorie di un coltivatore di marijuana, non un inno mariano ma un libro nel quale il coltivatore in grande stile di marijuana, spiega in prima persona come arrivò a creare il campetto, dalla decisione di eliminare «l'erba cattiva», quella del prato, per sostituirla con quella «buona» mettendo a dimora, per lui preziosi, semi di cannabis.
Orchestrando con sagacia l'affabulazione di Zanchetta, personaggio singolare dalle molteplici e contrastanti identità, Alessandro Zaltron ce lo ricorda ex chierichetto, parà della Folgore, guardiano in una miniera di rubini in Tanzania, turista non per caso in Centroamerica, boyguard di uomini della politica, e ancora raffinato sommelier e ristoratore e ora, saldati i conti, conduttore di una fattoria ecologica modello in Veneto.
Un libro piacevole, da leggere tutto d'un fiato, divertente e ironico, scritto con garbo da Alessandro Zaltron, la cui produzione letteraria s'arricchisce anno dopo anno di nuovi titoli e successi. Stefano Zanchetta, raccontandosi in prima persona, riapre pagine di cronaca nostrana da rileggere con leggerezza e distacco, grazie a quel provinciale senso di disincanto che rende agile e scorrevole la penna di Zaltron. Sul filo del giornalismo prestato alla letteratura o, meglio, della letteratura prestata al giornalismo… (Roberto Cristiano Baggio)
 Ilaria Beretta
Ilaria Beretta
Una storia al mese più una per la teiera
«Il mio casale»
01-12-2012
Con un titolo così, il libro di Ilaria Beretta non poteva che incuriosire. Una storia al mese più una per la teiera racconta la storia di Ilaria e la sua scelta di trasferirsi in campagna. Non solo aria buona, cibo bio e bei paesaggi... ma anche avventure e disavventure vissute con una narrazione ironica e divertita. Così Ilaria ha imparato che, nell'angolo di Monferrato che ha scelto, ogni stagione ha i propri tempi e ritmi.
«La mia abitazione country & country»
01-05-2012
Una nuova casa ottenuta rimodernando diverse strutture antiche nella campagna piemontese, in un luogo in cui l'assenza di rumore, il silenzio, affascina ma può anche spaventare, quando si è abituati al caos della città. Lo racconta, assieme a tante altre avventure (e un nutrito numero di disavventure), Ilaria Beretta che, a chi decide di andare a vivere lontano dalla città, come ha fatto lei da qualche anno, suggerisce di acquistare e ristrutturare una casa country «pensandola e pensandosi nel tempo. Da me adesso ci sono tante scale, quando diventerò vecchia forse saranno un problema! Poi», continua Ilaria, «verificare i confini, soprattutto se sono antiche proprietà: può capitare che diritti di passo o di usufrutto, rimasti sepolti per anni se non per secoli, al momento del vostro arrivo vi piombino addosso in modo non proprio simpatico (leggete il capitolo dedicato al sambuco, ndr)». Ed è da considerare anche la mancanza di una vita sociale, almeno come quella di un tempo... «Il primo cinema spesso è a un'ora di auto», dice Beretta, «così la solitudine e il silenzio potrebbero far pensare di aver sbagliato a scegliere la vita di campagna per quel senso pungente di isolamento, e invece è proprio quello il momento in cui il cambiamento comincia, e il contatto con la natura e una vita più vera penseranno a ripagare presto di quel disorientamento».
E cosa c'entra la teiera del titolo? Beh, si scoprirà solo leggendo...
«Il nostro giornale»
29-03-2012
Ilaria Beretta, una cittadina-contadina, come si è definita lei stessa, è capace di raccontare non solo la sua di esperienza, ma getta una luce inattesa anche per i 'nativi' sul territorio.
Autrice Rai, sia per la radio che per il video, attualmente Ilaria Beretta, milanese con origini liguri, collabora con la casa editrice gaviese Edibrico. Insieme al marito Vincenzo si trasferisce dalla città a Tramontanina quasi nove anni fa. «In questi capitoli, che sono suddivisi seguendo i mesi dell'anno, ho raccontato in prima persona le cose che mi sono capitate - spiega Ilaria - quando ho fatto questa scelta ero convinta che trasferendom in campagna avrei trovato la pace. Oggi posso dire che l'ho trovata, ma non come pensavo io né dove credevo io».
E così nelle pagine del suo libro non troviamo un racconto edulcorato della vita di campagna, ma un resoconto sincero e appassionato di una cittadina che ha trascorso il tempo a conoscere e 'spiare' il territorio.
«Il primo anno è stato difficile, non lo nego - prosegue Ilaria - Mi sono ritrovata da sola in una casa enorme. Colpisce il silenzio da cui si è circondati. Bisogna tener duro, perchè quello è l'inizio. E le piante, la natura in generale, sono una metafora di quello che ci accade. Infatti, come il seme deve marcire prima di germogliare, anche noi abbiamo un periodo difficile, ma è una fase». Così da gennaio a dicembre nel libro scopriamo insieme alla scrittrice le sorprese che riservano la natura e questo territorio che sta in mezzo, tra collina e montagna, tra Liguria e Piemonte. E come per la preparazione del tè, per cui bisogna mettere un cucchiaino per ogni persona e aggiungerne un altro per la teiera, dopo dicembre c'è un'ultima storia, quella di un sambuco. «Alla fine posso dire che una radice l'ho messa anch'io», conclude Ilaria Beretta. (Angela Agostino)
«www.stradanove.net»
15-03-2012
Così, da una serie di avventure e disavventure sono nate «le cronache ispirate alla vicende di una coppia di cittadini che dalla metropoli ha deciso di trasferirsi in una casa situata tra i vigneti dell’Alto Monferrato, ovvero del Basso Piemonte». Come è evidente fin dal titolo, curioso quanto enigmatico, le storie sono dodici, cui si è aggiunta quella che, insieme al breve riferimento ad un acquarello che precede l’indice, svelerà il ruolo della teiera. Perché è vero, a volte sono i dettagli a determinare le nostre scelte.
E sono proprio i dettagli – un fiore, una pianta, un animale, uno scorcio – ad aver ispirato l’autrice che, da perfetta padrona di casa, ci accompagna alla scoperta degli abitanti – vegetali e animali – che popolano la casa, il giardino, l’orto, le vigne e il bosco lì vicino.
Attraverso una narrazione lieve, spesso ironica, ma sempre molto precisa, frutto di uno sguardo attento e rispettoso, ci fa riscoprire i ritmi della Natura, la sua grande vitalità e varietà: con lo sguardo rivolto verso l’alto e i piedi ben piantati a terra, Ilaria Beretta ci ricorda quanti doni può dispensare, ma anche quanto impegno può richiedere.
Ecco allora gennaio, i suoi uccellini in cerca di bacche e il suo profondo silenzio; febbraio e il risvegliarsi delle vigne e del bosco; marzo e un vaso che diventa il ‘condominio’ di innumerevoli esseri nascosti nella sua terra; aprile e le sue erbe spontanee, indispensabili ingredienti dei pansòti di magro; maggio e il basilico capace di sfidare persino le formiche pur di germogliare; giugno e un’ape inebriata dal profumo di una succulenta; luglio e una gatta ortolana; agosto e la legna per la stufa; settembre e il lungo viaggio di un caprifoglio; ottobre e gli equivoci del cotogno; novembre e il sogno (realizzato) di un roseto; dicembre, con il presepe e il «battito silenzioso di una Natura a riposo ma vigile» nel giardino d’inverno.
Questo libro, delicato come un acquarello ma anche vivido come una fotografia, ricco di aneddoti e di suggerimenti, convince il lettore a fermarsi un attimo e a guardarsi intorno, così da riportare alla luce tutta la generosità con cui la Natura si offre a noi, senza dimenticare che, spesso, essa stessa è riflesso dell’essere umano. (Lidia Gualdoni)
 Neri Pozza
Neri Pozza
L'educazione cattolica
«La Nuova Tribuna Letteraria»
01-09-2012
Proprio qui, e Cavalli la cita, si trova quella «poetica» generale che ha sempre ispirato l'attività di «Salvatore» (Neri Pozza). Parlando del suo maestro-collaboratore, lo scultore francese Martin, così si esprime: «Era un improvvisatore abile… Noi aiuti rovinavamo in modo irreparabile le belle capigliature abbozzate, le conchiglie, i puttini e le altre parti decorative; perché tutto doveva essere lisciato e tornito alla perfezione; ed era questo che guastava tutto… era stato il francese a insegnarmi a non tormentare troppo certe parti abbozzate, perché mantenessero la freschezza dell'improvvisazione».
Stupisce in ogni caso che L'ultimo della classe, più volte ristampato anche da altri editori, venga riproposto ora con correzioni e aggiunte da Colla come opera finalmente finita. Segno del destino? Difficile non pensare che l'espulsione, a 11 anni, dal regio ginnasio-liceo "Antonio Pigafetta", scuola d'elite, abbia si può dire marchiato, nel bene e nel male, l'esistenza del personaggio Neri Pozza. (Gianluigi Peretti)
«Il Sole 24 Ore»
25-03-2012
Mi aveva scelto quasi cercando qualcuno cui affidare il testimone, che avesse la tenacia di amarlo nonostante i suoi modi di rustego e altrettanta passione per i libri di quella che egli aveva testimoniato per oltre quarant'anni.
Non ci fu tempo per grandi confidenze, perché la vita se ne andò in un momento, ma a rileggere quel che allora scrivevo per presentare i suoi libri e che lui lasciò pubblicare, si capisce che ci intendevamo anche senza molte parole e che tanto mi compiacevo di avere per le mani pagine così intense e luminose, tanto lui continuava a scrivere esplorando una memoria sempre più chiara quanto più si allontanava nel tempo, in una dimensione quasi di favola, com'è evidente nell'apertura dell'Ultimo della classe, quando il nonno e il bambino «nelle notti di primavera del 1916 andavano a vedere le montagne illuminate dallo scoppio dei cannoni».
Ora, nel centenario della nascita, quel libro a me caro riappare con qualche variante e una seconda parte sinora inedita, che intitola la nuova edizione, L'educazione cattolica, dove quegli anni dell'adolescenza tra botteghe artigiane e prove d'artista si accendono di tormentati fervori religiosi e di intensi affetti familiari.
Neri parlava dei suoi pochi anni di scuola e anche mi interrogava preciso se mai potesse essere che un suo compagno alle elementari fosse mio parente, perché lui un De Michelis lo ricordava nitidamente. E poi si emozionava scoprendolo addirittura mio padre, perché quella famiglia protestante – mio nonno era allora pastore evangelico a Vicenza – lo aveva attratto e incuriosito.
Nell'Educazione cattolica è Martin, lo scultore francese che lo accompagna a Possagno a scoprire Canova, che lo introduce anche alla religiosità «riformata» e gli rivela l'esistenza di una chiesa metodista nello spiazzo di San Faustino.
Sono pagine quelle note e queste nuove che raccontano la storia di una formazione irregolare e proprio per questo più avventurosa e profonda e offrono un immagine vivida e turbata di un tempo molto lontano, nel quale tuttavia affondano le radici del nostro modo di essere. (Cesare De Michelis)
«www.bassanonet.it»
23-02-2012
Mentre in questi giorni Torino festeggia per la stessa ricorrenza l’editore Giulio Einaudi, i Vicentini rendono omaggio al loro concittadino illustre che ha dedicato una vita intera alla promozione della cultura – anch’egli fondatore di un’importante casa editrice –, alle lettere e all’arte, accogliendo tra i libri di casa L’educazione cattolica. Il nuovo volume è stato curato dal critico letterario Marco Cavalli e contiene una nota al testo di Giulia Basso. La pubblicazione accosta la riedizione riveduta di un famoso romanzo scritto da Pozza e un inedito che parlano insieme di giovinezza e di precetti dell’educazione, di guerre e di civiltà.
L’ultimo della classe, edito da Marsilio nel 1976, selezionato al Premio Campiello nel 1986 e ristampato nel 2000 da Mondadori per le scuole, è presentato dunque in un’edizione nuova: nel lavoro di revisione del romanzo, in fedeltà alle disposizioni lasciate da Pozza, si è tenuto conto di correzioni, aggiunte, emendamenti operati dall’autore – un corpus di note custodite da Angelo Colla, che è stato il suo segretario personale – con l’intento di restituire ai lettori non un volume rifinito, ma l’opera finita dello scrittore.
L’educazione cattolica è un inedito, anch’esso redatto secondo le indicazioni di Pozza, dove Salvatore-Neri prosegue il racconto iniziato ne L’ultimo della classe degli anni della sua formazione. Nei due romanzi il continuum della narrazione è evidente, anche se le parti possono vivere di vita autonoma, i rimandi di un testo all’altro sono presenti, e in alcune pagine compaiono dei disegni con i lati destro e sinistro invertiti che fanno intuire chiaramente la disposizione approntata per una stampa unica finale. L’arte, e il regalo, di chi ha curato oggi il testo, stanno nei tocchi elargiti facendo muovere sulla carta ancora una volta, in oltraggio solo alla morte, le «dita di legno» (come le chiama Ugo, il padre del protagonista, ricorda Cavalli) scelte appositamente per la prosa dedicata alla memoria dallo scrittore.
In entrambi i romanzi Pozza è riuscito con queste dita e con mano sapiente a fare sentire la continuità tra il grande e il piccolo, a farli prendere per mano. «Antelucano» e «baliverna», ville nobiliari e capannoni-laboratorio sono affratellati nel testo senza attrito. Il racconto del piccolo Salvatore procede a passo d’uomo in luoghi conosciuti, vicini (Monte Berico, le contrade, la campagna, il Monte Grappa, Recoaro) e in ambienti che sono stati per tanti casa e famiglia fino a un paio di generazioni fa: la strada, la scuola, l’oratorio. Seguendolo si sale sui vagoni della Vaca Mora, si percorrono gli eventi tragici del primo Novecento – l’intero racconto copre il periodo difficile che va dal 1916 al 1934 –, il viaggio scandito da un tempo narrato che non corre, che appartiene alla vita quotidiana, e si ascoltano tante storie che con la leggerezza di una conversazione a tavola nutrono, perché parlano di temi universali: il rapporto dell’uomo con la religione, con l’educazione, con la civiltà.
C’è tanta idea di colpa, più che di speranza, in questo piccolo mondo cattolico e nei piccoli e grandi eventi che gli girano intorno. La speranza Neri Pozza la affida alla giovinezza, al ragazzino eroe: è lui che riesce, muovendo in fretta mani e piedi, a uscire sano dai contagi. Affamato com’è di sapere, di bellezza e di cultura Salvatore si nutre in casa ma assaggia, e gradisce o sputa, anche il cibo di fuori – è uno scultore francese, Martin, che, fornendo altri attrezzi al ragazzino, gli dice tanto, che lo aiuta a vedere.
La sua salvezza Salvatore se la costruisce da sé, come è scritto nella seconda di copertina, «grazie a una duplice vocazione: all’artigianato artistico e alla vita laica», restando debitore solo di un grazie, non di una grazia. (Laura Vicenzi)
«Il Gazzettino»
21-02-2012
«Ho scelto il Tiziano – spiega Colla – perchè è uno dei suoi libri più belli e ispirati, in cui egli trasferisce se stesso in forma quasi autobiografica, immedesimandosi nell'artista come creatore e uomo anziano. Il libro faceva parte delle carte che Pozza mi aveva lasciato prima di morire, ed era un volume che egli stesso aveva annotato (con rilievi di tipo stilistico) dopo l'uscita da Rizzoli, mentre assisteva la moglie Lea, che sarebbe morta di lì a poco, in ospedale».
E L'educazione cattolica?
«Si tratta del suo ultimo libro, che racconta la sua formazione in una società chiusa e clericale, e i suoi primi tentativi di sfuggire a un conformismo che in qualche modo conviveva col fascismo. Ho fatto precedere questo libro con L'ultimo della classe perchè egli stesso aveva in mente questa operazione, per sviluppare alcuni personaggi, andando in questo modo a costruire un romanzo di formazione dalle Prima Comunione ai 16-17 anni».
Perchè non l'ha pubblicato lui in vita?
«Faceva spesso così: mi faceva leggere il manoscritto e poi il dattiloscritto corretto, e mi diceva: "El li tegna là, i vegnarà boni". Una volta mi spiegò perchè: siccome aveva una produttività enorme, temeva che pubblicare tanti volumi e di argomento diverso, oltre al lavoro editoriale e alle incisioni, finisse per convincere la gente che il loro livello non era eccellente. E lui alla qualità dei libri teneva sopra ogni cosa».
Come sono stati i vostri rapporti, chiediamo.
«Io ho cominciato a lavorare con lui poco più che trentenne, nel '76, dopo aver studiato all'università con Gianfranco Folena, e dal '78 all'88 sono stato un po' di tutto, redattore, segretario… Lui decideva su ogni cosa, ma era anche molto generoso, mi rendeva partecipe del processo di costruzione dei libri, delle ricerche iconografiche e biografiche. Era rigorosissimo, non concedeva nulla alle logiche di mercato, anche se fu il primo a farsi pagare i libri dagli sponsor. Mi spronava ad approfondire, a fare: quando arrivavo la mattina mi chiedeva cosa avessi letto la sera».
Mai avuto problemi con lui, che era notoriamente collerico?
«Una volta mi chiese di aiutarlo nella stesura di alcune parti del capitolo sugli editori nella grande collana sulla cultura veneta; poi si era impegnato a fare alcune lezioni all'Uniter, ma non aveva tempo, e quindi chiese a me di andare al posto suo. Io obiettai che non l'avevo mai fatto e che non mi sentivo in grado: non l'avessi mai detto! Mi fece una lavata di capo che mi lasciò annichilito. Il giorno dopo gli dissi che accettavo, e mi rispose con un ruggito».
Cosa le ha lasciato ancora di interessante?
«I diari di giornata della casa editrice, e la cosiddetta ‘colonna infame’: ogni giorno, la sera, davanti a un bicchiere di liquore che io trangugiavo per forza, ma che a lui serviva come tonico per il cuore ingrossato, scrivevamo l'elenco delle cose fatte e delle persone viste, e qualche volta le sue erano vere e proprie rasoiate. Chi poi tirava i bidoni più grossi finiva in una lista speciale, appunto la ‘colonna infame’. Molti personaggi, tra l'altro ancora viventi, non ci fanno una gran figura». (Sergio Frigo)
«Il Giornale di Vicenza»
19-02-2012
ZIA LIETA Dietro il nome di Salvatore, il protagonista de L'educazione cattolica, si nasconde il piccolo Neri, che ripercorrendo la sua infanzia nella Vicenza del primo dopoguerra, trascorsa tra la casa di Santa Caterina del signor Giovanni (il nonno) e le scorrerie in contrada con gli amici della banda di San Michele, traccia una sorta di cerchio magico all'interno del quale si staglia in maniera del tutto particolare la figura della Zia Lieta, colei che lo porterà al centro di quell'educazione cattolica che segnerà in maniera decisiva tanta parte della sua vicenda personale e artistica. Se pure stemperata dalla laica saggezza del nonno Giovanni e dall'ateismo risoluto di papà Ugo, l'influenza di questa donna appassionata e devota, capace di ogni sorta di sacrificio e di autopunizione in nome di una fede scintillante e senz'ombre, si trasformerà nel tempo in una sorta di richiamo pressante, i cui riverberi silenziosi e tenaci lo accompagneranno per il resto della sua esistenza. Il racconto di Neri Pozza ha il tocco vigoroso e immediato di chi, conoscendo la pregnanza delle parole, non ha bisogno di enfatizzarle per renderle più efficaci e vere. In questo senso le notazioni di Marco Cavalli, curatore dell'inedito, indicano con precisione la via da seguire. «La materia da cui nascono i suoi libri autobiografici – scrive Cavalli nella postfazione all'opera – era per Pozza così delicata e preziosa da spingerlo a metterla sulla pagina senza troppa ricercatezza, con la spezzatura dell'autodidatta che del comporre di vena e di getto conosce tutto, autoinganni inclusi, tipo credere che prima di scrivere di getto non sia necessario imparare a farlo. Pozza era uno sceglitore, un cernitore accurato, ma lo era nella fase iniziale e immediata dello scrivere. Revisioni, correzioni, aggiustamenti, emendamenti, per quanto a fin di bene, oltre una certa misura per lui erano sempre a rischio di funzionare al contrario, di accelerare anziché frenare il depauperamento della materia autobiografica. Come le premure dell'affetto, che oltrepassata una data soglia possono diventare manifestazioni di ostilità».
PROFUMO DI UN'EPOCA Di qui l'esigenza di una scrittura rapida, precisa, che sbalza e incide, scalpella e sgrezza, ma con misura, rigore, senza alcune forma di compiacimento o di ricercato estetismo. Il risultato è sorprendente. Tutto si compone in un movimento ampio e corale: la Zia Lieta con la sua fede ingenua e incrollabile; il monsignor parroco con la bella tonaca nera e gli occhialini a pince-nez; il padre Ugo ombroso e fiero che non si piega al fascismo e per questo perde commesse e bottega; il signor Giovanni, agnostico e pensoso, che fa del possibilismo la sua complessa filosofia di vita; lo scultore francese Martin, occhi ridenti e mani d'artista, in grado di condurre l'estro e la fantasia del giovane Neri per strade zigzaganti e libere… Un affresco, quello tratteggiato da Neri Pozza, allo stesso tempo lieve e potente, capace con poche, brevi pennellate di evocare un'atmosfera, uno sguardo, l'odore di una contrada o di un'intera città. Ecco infatti, in un balzo, irrompere gli apocalittici acquazzoni di un dopoguerra povero e affamato, quando per andare al catechismo in preparazione della prima comunione bisognava «resegare» i muri e fare penitenza ripassando minuziosamente i dieci comandamenti. Ecco l'eco delle domande incalzanti e affettuose di Zia Lieta, che chiede conto delle sette opere di misericordia corporale e spirituale. Ecco la villeggiatura a Recoraro con il signor Giovanni, tutti e due ospiti alla Locanda del Bersagliere abitata da un vecchio fattore del nonno che aveva governato il bosco e la segheria prima dell'anno della piena; ecco la virtuosa, inquieta principessa, amica di Zia Lieta, della quale diventerà poi sollecita e devota dama di compagnia.
LA POESIA DELLE COSE Il bambino protagonista de L'ultimo della classe, che nelle notti di primavera del 1916 accompagnato dal nonno saliva fino alla cima di Monte Berico per assistere allo spettacolo dell'orizzonte incendiato dalle bombe della prima guerra mondiale, è lo stesso ragazzino che dalle pagine de L'educazione cattolica ci restituisce con occhio limpido e preciso un mondo di sensazioni e sentimenti sotterranei, appena accennati, rievocati non tanto da parole o figurazioni retoriche più o meno raffinate e preziose, quanto dalle azioni concrete dei singoli personaggi, che nei loro gesti e nei loro pensieri condensano il silenzio, l'angoscia, il sorriso, l'ironia di uno stato d'animo che diventa specchio fedele di situazioni realmente sperimentate e vissute. Nessuna alzata di tono, nessun affondo veemente in queste pagine fresche e veloci. L'incedere piano della storia è infatti continuamente stemperato da uno sguardo misurato e affettuoso che sembra catturato da un'unica urgenza: la fedeltà alle persone e alle cose. In questo modo i molti personaggi che attraversano la narrazione condensano luci e le ombre di un periodo forse fra i più oscuri e difficili della nostra storia recente. Il fascismo, staccato dalla prosopopea ufficiale e calato nella vita di ogni giorno, acquista le forme grottesche di una pratica di potere che, cieca alle ragioni dell'intelligenza e della tolleranza, ricorre ai mezzi più ignobili per strappare un consenso fatalmente corrotto e minato. Una pratica di potere che in una città come Vicenza assume le connotazioni di un provincialismo occhiuto e stantio, saturo di risentimenti e striscianti delazioni. Ma anche quando le vibrazioni si fanno più fini e riflesse, e il tarlo della memoria cesella sensazioni rarefatte e struggenti, giunge sempre lo stacco sobrio dell'autore a condurre il filo della sua testimonianza entro i binari di una scrittura rigorosa, netta, senza sbavature. Ciò che resta alla fine della lettura è una sensazione di grande leggerezza. Una leggerezza che non è del contenuto, ma di una forma depurata, essenziale, capace di far lievitare l'oggetto della narrazione in una dimensione allo stesso tempo vicina e lontanissima: ciò che talvolta accade quando il richiamo della memoria è filtrato dalla grazia di un sentimento misurato e autentico. (Maurizia Veladiano)
 Neri Pozza
Neri Pozza
Tiziano
«Antiquariato»
01-05-2012
«Corriere del Veneto»
04-04-2012
Questo romanzo storico più che dalla particolarità della vita di Tiziano trae origine dalla partecipazione emotiva dello scrivente capace di immedesimarsi nella temperie del tempo e nell'interiorità del pittore percependone umori, segreti pensieri, pulsioni, estasi creativa. Parliamo di romanzo storico perché se ne rilevano tutti gli elementi: inconfutabilità degli accadimenti provati da documenti d'epoca e rielaborati liberamente dalla sensibilità dell'autore; particolarità della scrittura che mescola la forma aulica a quella dialettale; capacità di rapportare i tempi lunghi del racconto all'immediatezza del dialogo; equilibrio tra razionalità e pathos sentimentale.
La narrazione prende avvio dalle opere giovanili (1509) sino alla morte (1576). Neri Pozza sa che l'immagine pittorica in Tiziano è «istantanea emozione visiva tale da provocare una reazione morale». Lega quindi i capitoli del libro ad un fatto reale di tale potenza espressiva da ispirare la visionarietà dell'artista. Per i tre affreschi sui miracoli di S. Antonio – Scuola del Santo di Padova – immagina che Tiziano abbia visto nel sagrato della Basilica il crudele Lunardo Trissino, capitano di ventura, capace di «scannare e bruciare senza riguardi, mandando in pezzi il Leon di San Marco» vestito con una mantellina di seta bianca, la grande spada al fianco, la fronte cinta di fiori, mangiare indolentemente marasche, quasi fosse ad una festa campestre e poco dopo, con la stessa indifferenza, colpire a morte un vecchio. La stessa elegante figura ritroveremo nel Miracolo del puto che parla e il fatto di sangue si ripeterà con la stessa dissennata violenza nel Marito geloso. Anche per L'Assunta il riferimento agli Apostoli che si agitano e gridano al cielo con le braccia alzate è ripreso dall'osservazione degli «uomini di barca» nella loro fatica quotidiana e nell'affanno di difendersi dai venti turbinosi. Concepisce possibili dialoghi con l'Imperatore Carlo V e Filippo II quali tramite per dar corpo a quella mescola d'autorità ed intimo travaglio che ne caratterizza i celebri ritratti.
Scava nell'interiorità dell'animo dell'artista per delinearne il severo carattere di uomo di montagna (Tiziano era nato a Pieve di Cadore fra il 1488 e il 1490). Sfata la sua presunta avarizia dimostrandone la generosità e l'improvvida amministrazione. Parla con pudore dei rapporti con l'amata moglie Cecilia, con la sorella Orsola che gli aveva condotto la casa, del rapporto d'onore con il fratello Francesco; dell'amore per i figli Pomponio, Orazio, Lavinia; dell'iniziale percorso artistico con Giorgione; delle amicizie importanti con l'Aretino e il Sansovino; degli incontri con la poesia del Ruzzante.
Tocca tutti i punti salienti di una vita condotta in pienezza, ma soprattutto dà conto di questo amore esclusivo per l'arte che è «finta, lunatica e bella, la più raminga del mondo». Per l'Arte resisterà alla bellezza sensuale delle sue modelle, in specie la Bella Gata che gli ispireranno: Flora, Lucrezia, l'Amor Sacro e l'Amor Profano e le tante Veneri. La anteporrà alla famiglia, ai guadagni, ai divertimenti ed onori, dedicandole ogni passione sino all'ultimo giorno di vita lasciandoci nel Cristo Morto il suo testamento culturale.
Questa narrazione non è tanto biografia romanzata ma chiave di lettura per comprendere i capolavori di uno dei maggiori artisti della pittura mondiale. (Sergia Jessi)
«Il Corriere della Sera»
29-03-2012
«Il Giornale di Vicenza»
08-02-2012
Donatello in conversazione con Andrea Mantegna e Paolo Uccello, Antonello da Messina, Gentile Bellini e il fratello Giambellino, Zorzòn da Castelfranco, Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto, Vitòr Carpaccio, il Tintoretto, Paolo Caliari veronese e Andrea padovano fattosi Palladio a Vicenza avevano preso vita in una sequenza di racconti in cui l’arbitrio inventivo di Pozza si conciliava in modo perfetto con le conoscenze documentali, frutto di un lungo lavoro d’archivio e di mille letture.
NELLE STORIE VENEZIANE. Il Vecellio non mancava nel doppio album, contrappuntato dal vivace recupero lessicale di tanti venetismi antichi inabissatisi e scomparsi nel ‘veneto moderno’. Nel Processo si leggeva un brano magistrale su un suo colloquio con Pietro Aretino e Jacopo Sansovino con svelamento dell’avvenuto matrimonio con Cecilia, la giovane cadorina che aveva in casa come servente devota, diventata amante e madre di due figli (e morta di parto alla terza). Nella Putina greca c’era l’epilogo doloroso della morte in tempo di peste, nella casa-bottega al Biri Grande affacciata sulle acque lagunari, all’età – così annotata nel registro della parrocchia di San Canzian con una controversa e mai ben accertata forzatura quindicennale dell’anagrafe – di anni 103.
Ma di Tiziano c’era molto di più in sospeso nella penna di Neri Pozza, affascinato da una figura in più d’un aspetto amata fino a compenetrarvisi. C’era l’intera storia di vita del più grande e più vecchio tra i Grandi Vecchi maestri della luce e del colore nel Rinascimento veneziano. Chiamare ‘biografia romanzata’ quella pubblicata da Rizzoli nel 1976 potrebbe volgarizzare e magari svilire il lavoro di Pozza su Tiziano: ma fu vero romanzo e insieme grande biografia davvero, in una lettura ricca e piacevole che trasmetteva una mole impressionante di conoscenze sui modi e i contesti della pittura del Cinquecento.
LA NUOVA EDIZIONE. Angelo Colla ha ripreso oggi in mano il Tiziano della versione BUR Rizzoli del 1986, allora già parzialmente rivista dallo scrittore, e – con la collaborazione di Lionello Puppi, grande studioso dell’artista e a suo tempo autore nel catalogo di Neri Pozza editore – lo restituisce aggiornato a tutti i lettori che lo conoscevano e a un paio di generazioni che troverebbero l’opera solo nelle biblioteche. In copertina c’è l’Autoritratto del Museo del Prado madrileno: dipinto perfettamente espressivo dell’uomo Tiziano, della sua tecnica pittorica e della longevità magistrale nell’arte veneziana, italiana e europea, oltre che dei suoi rapporti con la più illustre committenza, quella degli imperatori d’Asburgo.
Nelle pagine ritorna – nella versione resa definitiva dalle postille che Pozza aveva messo a punto, ritrovate tra i manoscritti inediti e affidate alla cura di Puppi – l’eccezionale racconto di tutto un mondo imperniato sulla grandezza (e pure su qualche miseria) della pittura italiana nel suo momento più fulgido.
UNA VITA DI SUCCESSI. Tiziano scende dai monti di Pieve di Cadore a Venezia da ragazzino promettente. Diventa artista nelle botteghe dei Bellini, pittori ufficiali della Repubblica. Gira per le calli e prende casa in vista della Laguna. Si affida a Pietro Aretino per fare buon marketing ante litteram. Presto diventa sovrano incontrastato della pittura veneziana, occupando una scena in cui tutti gli altri finiscono per star troppo stretti. E poi viaggia: Ferrara e Mantova, Bologna e Augsburg per ritrarre l’imperatore d’Asburgo, Roma per dipingere il papa Farnese.
Personaggio tra i grandi personaggi nello scenario artistico della Serenissima, è capace di sfidare il Consiglio dei Dieci tirando di lungo nel completare l’immane affresco della Battaglia di Cadore a Palazzo Ducale; di emozionare la città con l’Assunta che ai Frari sale in cielo tra gli sguardi di Apostoli mai tanto vivi e veridici; di colorare con l’occhio e il pennello di una passione personale intensa le carnalità dei soggetti mitologici. E anche di insistere con Filippo II perché sia onorata una ‘pensione’ assegnatagli dal padre Carlo V: con ciò, e con altro del genere, guadagnandosi la fama di troppo attento alla pecunia (che però Pozza nettamente contesta...).
Ogni volta lo scrittore vicentino è lì con la sua penna e con la sua realistica immaginazione. Dipinge stati d’animo e reazioni, entusiasmi o sconforti, quasi vivendoli in proprio. Certamente andando oltre la fredda compostezza del biografo, per garantire al lettore il calore di una vissuta partecipazione. (Antonio Trentin)
«Il Giornale dell'arte»
01-02-2012
Utilizzando un’edizione rivista e corretta rinvenuta recentemente tra le carte inedite di Neri Pozza, l’editore Angelo Colla ha avuto la felice intuizione di ripubblicare quella biografia ormai classica del sommo pittore veneto, affidandone la prefazione a un decano degli studi tizianeschi, Lionello Puppi. E proprio a Puppi, protagonista assoluto di quel fervido periodo di studi su Tiziano in cui apparve la biografia di Neri Pozza, è opportuno dare la parola per tratteggiare un breve profilo del libro: ispirata nello stile al «tenore della machiavellica Vita di Castruccio Castracani, dove fatti accaduti son mescolati ad altri di fantasia per farne scaturire l’immagine di un principe ideale», ma anche alla «Storia di Carlo XII di Voltaire dove l’autonomia della libertà del racconto si prova persino programmatica», la biografia di Tiziano di Neri Pozza narra «una “dedizione totale” alla pittura in un contesto storico specifico e nel confronto col Potere raffigurato nella grettezza di Carlo V; il racconto del prezzo pagato giorno dopo giorno e anche ai più teneri affetti famigliari, dall’intransigenza dell’“entusiasmo creativo” e dalla lunga sofferenza di ridurlo a forma, emblematizzata dai dieci anni di applicazione al San Lorenzo». (F.B.)
«Tuttolibri»
28-01-2012
«Il Piccolo»
22-01-2012
Su Tiziano si è scritto tantissimo. Storici dell’arte, scrittori e biografi hanno scandagliato a fondo la figura dell’artista nato a Pieve di Cadore in una data non definita tra il 1488 e il 1450. I suoi quadri sono esposti nei principali musei del mondo: dal Louvre al British Museum, dal Metropolitan all’Accademia di Venezia. Eppure, per tutti, la figura del Vecellio rimane ancora un enigma. Che Neri Pozza, illuminato uomo di cultura nato a Vicenza nel 1912 e morto nel 1988, che è stato scrittore e editore, scultore e incisore, ha provato a mettere a fuoco in una corposa biografia terminata tra il 1973 e il 1975. Pubblicata per la prima volta nel 1976 da Rizzoli, nella collana “Gli Italiani” diretta da Indro Montanelli. E ripresa, all’inizio degli anni Ottanta, in un’edizione corretta dallo stesso autore.
Adesso quel testo viene riproposto nella sua versione originale, con una serie di postille scritte da Neri Pozza, rimaste poi impubblicate, per la cura di Lionello Puppi, professore emerito di Metodologia della storia dell’arte all’Università Ca’ Foscari di Venezia, che firma anche una densa e appassionante prefazione. In cui sottolinea, con le parole della poetessa russa Marina Cvetaeva, che «chi è vissuto una volta deve vivere per sempre». Tocca ai poeti renderlo immortale.
Neri Pozza, raffinato poeta, non si era limitato a consultare, a leggere, ad annotare con febbrile precisione tutti i testi più importanti dedicati alla vita e all’opera di Tiziano. No, lui si era spinto più in là. Provando a immaginare il grande pittore, sceso dalle montagne del Cadore, in giro per le calli della città lagunare. A zonzo per le corti d’Europa, a colloquio con personaggi come Pietro Aretino, come Jacopo Sansovino, come quel genio assoluto dell’Angelo Beolco detto Ruzzante, a contatto ravvicinato con l’imperatore Carlo V e con suo figlio Filippo II. Oppure a guardare lo splendore delle Stanze vaticane di Raffaello, della Sistina di Michelangelo, delle Fabbriche del Bramante per la Basilica di San Pietro.
E raccontando Tiziano così da vicino, Neri Pozza si era reso conto che per portare il pittore fuori dall’ombra era necessario andare al di là della sua arte. Seguirlo mentre combatteva con il Consiglio dei Dieci che lo pressava perché completasse il gigantesco lavoro di affrescatura della Battaglia di Cadore nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Spiarlo mentre dava umanissima forma agli apostoli che ammirano stupefatti l’Assunzione di Maria in cielo. Cogliere i fremiti carnali del Vecellio mentre dava forma all’Amore sacro e amor profano, a Bacco e Arianna, a Flora e Salomè. E, al tempo stesso, provare a immaginare i pensieri, gli accessi d’ira, i momenti di sconforto, la malinconia, la lotta continua per farsi pagare. Per assicurare un futuro ai figli.
Il Tiziano di Neri Pozza è un uomo che si innamora forse una sola volta nella sua vita. Della timida, fragile Cecilia venuta da Pieve fino a Venezia per occuparsi della casa abitata dal pittore con il fratello Francesco. Che diventerà in fretta la sua amante, la mamma di Pomponio, Orazio e Lavinia, e che troppo presto lo lascerà da solo. Stremata dai parti.
Ampliando nell’animo del pittore i silenzi infiniti, quella ritrosia così montanara che Vecellio si portava dentro assieme agli scenari immensi delle sue Dolomiti. E al bisogno di contemplazione che, sulla tela, diventava colore, forma, materia. Mistero creativo. (Alessandro Mezzena Lona)
 Giuseppe D'Alessandro
Giuseppe D'Alessandro
Bestiario giuridico 2
«La Gazzetta del Mezzogiorno»
09-09-2012
E così il «vaffa» detto in pubblico, nel corso di una tavola rotonda tra amministratori locali, non è reato. La presunta offesa, lanciata in risposta all'affermazione «ci si deve vergognare di essere comunisti», si è tradotta in una querela per ingiuria (art. 594 c.p.) e il processo, dopo l'assoluzione del politico in tribunale e la sua condanna in appello, è approdato in Cassazione che ha così argomentato: «Vi sono delle parole e anche frasi che, pur rappresentative di concetti osceni o a carattere sessuale, sono diventate di uso comune e hanno perso il loro carattere offensivo, prendendo il posto, nel linguaggio corrente, di altre aventi significato diverso» (Cass., Sez. V sentenza 27966/2006). Segue dettagliato elenco esplicativo, nel quale i giudici di Piazza Cavour si preoccupano di chiarire che il «vaffa» incriminato equivale alle più garbate espressioni «non infastidirmi», «non voglio prenderti in considerazione» o «lasciami in pace». A patto però, che l'inelegante alterco si svolga tra persone di pari grado (nel caso di specie, due consiglieri comunali uno dei quali anche vice-sindaco).
Occorre insomma guardare alla personalità dell'offeso e a quella di chi offende, e al contesto in cui il «vaffa» è stato pronunciato, come osserva la Cassazione in una sentenza dello scorso anno che ha invece confermato la condanna dell'insolente dall'eloquio poco raffinato: se infatti il «vaffa» e altri epiteti sono rivolti nei confronti di un insegnante in risposta ad una sua osservazione, di un vigile urbano mentre somministra una contravvenzione o in situazioni similari, «assumono carattere di spregio» e diventano penalmente rilevanti in quanto tesi ad offendere l'onore e il decoro della persona (Cass., Sez. V sentenza 30956/2010). Di contro, anche il professore che dia dell'«ignorante» a un proprio alunno è passibile di condanna per ingiuria (Cass., Sez. V sentenza 23693/2010); e se urla «io ti boccio» come ritorsione verso la madre del discente che ne aveva chiesto il trasferimento rischia di essere incriminato per minacce ex art. 612 c.p. (Cass., Sez. VI, sentenza 36700/2008).
Recentemente ha fatto molto discutere la sentenza della Cassazione che ha ritenuto fosse un reato rivolgersi a un rivale con la frase: «non hai le palle». L'ingiuria infatti metterebbe in dubbio non tanto la virilità dell'avversario quanto la sua determinazione e coerenza (Cass. sez. V sentenza 30719/2012).
E neanche i vip sfuggono alla scure della giustizia, quando eccedono nell'eloquio sboccato.
È accaduto a Giampiero Galeazzi, condannato per aver apostrofato il portiere dello stabile in cui abita chiamandolo «meridionale di m...» dandogli dell'inetto - «non sei capace neppure di guardare le pecore» - per la mancata consegna della posta (Cass., Sez. V, sentenza 36423/2011). Dare del «terrone» a qualcuno, del resto, è condotta offensiva secondo la Cassazione anche quando ci si rivolge a chi non è nato nel meridione trattandosi di un termine «odiosamente razzista» (Cass., Sez. V sentenza 42933/2011). Alcune espressioni, precisa la Corte, «hanno un carattere obiettivamente insultante» - nel caso di specie oggetto del contendere era la frase «lei per me può andare solo a fan..., terrone di merda» - nonostante il progressivo deterioramento dei codici comunicativi. Minor fortuna aveva avuto qualche anno prima Antonio Di Pietro, che aveva querelato Umberto Bossi, per averlo definito in pubblico «terrone»: il Senatùr uscì indenne dalla vicenda giudiziaria.
Il «vaffa...» peraltro è ormai entrato anche nel linguaggio politico-mediatico più gettonato, sdoganato cinque anni fa da una delle prime manifestazioni di piazza (virtuale e non) promossa con il supporto del web dal «comico-urlatore-agit-prop-tecno-demagogo» Beppe Grillo, quel V-Day (o Vaffa...-Day) che l'8 settembre 2007 accese le micce della sua campagna anti-casta.
La materia dell'improperio legalizzato è composita - tanto da ispirare un volume ad hoc scritto dall'avvocato nisseno Giuseppe D'Alessandro, Bestiario giuridico 2 - e i confini tracciati dalla giurisprudenza spesso sono sottili e impercettibili. La Corte di cassazione, in una sentenza dello scorso anno, ha ritenuto ingiuriosa l'espressione a prima vista inoffensiva «scioccarellino», condannando la signora che l'aveva proferita all'indirizzo di un bambino in presenza dei suoi amichetti (Cass., Sez. sentenza 38297/2011).
Meglio allora sarebbe rifarsi al buon senso e, perché no, auspicare una rivalutazione della nostra lingua impoverita e degradata dall'eloquio televisivo minimalista e gridato. Il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer (1788-1860), nella raccolta di aforismi L'arte di insultare, offre un campionario di offese dedicate ai temi più vari, che colpiscono elegantemente nel segno senza ricorrere al turpiloquio. Ma non tutti sono nobili e arguti pensatori. (Sergio Lorusso)
«La Repubblica»
19-08-2012
Dare del terrone a un siciliano può anche essere motivo di reato. Solo per un settentrionale, però. Se a pronunciare l'epiteto è un conterraneo, tutto si affievolisce. Esistono offese ben più gravi della parolaccia. Tra queste è da annoverare il sicilianissimo sputo. D'Alessandro cita un caso di inizio '900, quando un tizio fu mandato assolto dopo aver sputato a terra al passaggio del suo nemico. Ben diversa la situazione di un preside palermitano che alcuni anni fa sputò tre volte all'indirizzo di un'insegnante. Duramente ripreso dagli altri insegnanti esclamò: «Ma la sto profumando!» Fu naturalmente condannato ed ebbe la tracotanza di ricorrere in Cassazione, dove fu nuovamente sconfitto. (Mario Pintagro)
«Il Giornale di Sicilia»
03-02-2012
«Focus.it»
20-01-2012
Le parolacce, infatti, possono essere usate come armi che danneggiano un bene impalpabile: l’onore, ovvero il rispetto e la stima degli altri. Forse il nostro bene più prezioso, diceva San Tommaso d’Aquino: «l’insulto è peccato mortale, perché toglie a un uomo le testimonianze di onore e di venerazione che gli sono dovute. Perché una persona ama il proprio onore non meno delle sue proprietà». Non a caso, fra le innumerevoli leggi italiane ce ne sono diverse (nel mio libro ne ho censite una trentina) che puniscono proprio gli insulti.
L’avvocato D'Alessandro, che ha avuto l’idea della ricerca durante i tempi morti fra un’udienza e l’altra nei palazzi di giustizia, ha esaminato 912 sentenze emesse tra il 1890 e il 2011: un numero considerevole, anche se ben lontano dall’essere rappresentativo di tutti i processi per ingiuria, oltraggio e diffamazione che, secondo le sue stime, potrebbero essere nell’ordine di 150-200 mila lanno (il 6% del totale); di questi ne arrivano in Cassazione – l’ultimo grado di giudizio, quello che fa giurisprudenza – circa un migliaio l’anno.
Ed ecco altre curiosità che emergono dal libro di D’Alessandro.
INSULTI. I termini spregiativi citati nelle sentenze di D’Alessandro sono 612: oltre alle parolacce classiche, ce ne sono molte creative. Comprese le parolacce agìte, ovvero i gestacci, le pernacchie, gli sputi, il lancio di letame, di scarpe o di bombolette puzzolenti.
Divertente la carrellata sugli insulti, anche indiretti: un uomo è stato condannato per essersi rivolto a un pubblico ufficiale dicendogli: «Io non ho lo scolo in testa!» (= io non ho una malattia venerea in testa = io non sono una testa di cazzo, mentre tu lo sei!). I giudici, poi, puniscono anche le frasi sarcastiche: un cliente deluso è stato denunciato dal suo stesso legale per avergli inviato un vaglia intestato al celebre ed illibato ed onesto avvocato.
Passando agli insulti veri e propri, tra quelli finiti sulle carte bollate figurano anche espressioni insolite come: ammazzasentenze, atzarese (abitante di Atzara, Nuoro), buco a puzzoni, canchero, diesel fumoso, diffidato di questura, faccia di porfido, farneticazioni uterine, insabbiatore, insolvente, maneggione, manghiatone, manutengolo, minchia morta, noisette, piffero di montagna, realburinismo, superiniquinatore, testa di mattone, traffichino, trillo e frillo, vecia, verginello, zombi.
Colpisce il fatto che numerosi insulti sono di matrice storico-letteraria o ispirati dalla cronaca: Ceausescu (dittatore polacco), Cicciolina, demiurgo, degasperino, don Abbondio, don Chisciotte, don Rodrigo, dracula, Innominato, khomeinista, lewinskiana, Mata-Hari, moscovita, Pacciani, Previti, Scelba, Travet, Willy il coyote, zio Paperone. In sostanza, questi epiteti sfruttano il meccanismo dell’antonomasia: se una persona (o un personaggio fittizio) incarna un vizio, il nome di quel personaggio diventa lemblema del vizio stesso, in una equivalenza abbassante: Zio Paperone=tirchio.
A proposito dell’Innominato, D’Alessandro racconta un aneddoto divertente: nel 2000 un pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione di una denuncia ritenendo non oltraggioso questo soprannome (nei Promessi sposi l’Innominato era un malvagio che poi si convertì al cristianesimo). Ma la parte offesa impugnò il provvedimento, arrivando a chiedere una perizia sui Promessi sposi per valutare se l’Innominato fosse un personaggio negativo o positivo: richiesta che fu poi, fortunatamente, respinta. Quanto sarebbe costata una perizia del genere?
STATISTICHE. Quali sono gli insulti che più spesso sono arrivati nelle aule di tribunale? L’espressione largamente vincente è puttana (usato nel 9,6% dei casi, compresa la variante figlio di puttana, che però andrebbe classificato a parte perché non è un insulto sessista), seguita da merda (5,2% con le varianti pezzo di merda e faccia di merda), ladro (5%), coglione (4,3%), culo e troia (3,7%), bastardo (3,3%), disonesto (2,8%), stronzo (2,5%), cornuto (2,2%), bugiardo (2%). Aggregando i termini per area semantica, risultano vincenti le parole di area escrementizia (merda, cacare, fogna), seguite da quelle sulla sessualità femminile (puttana, troia, zoccola). Segno che le donne sono molto offese da questi epiteti, e non la fanno passare liscia a chi le insulta in questo modo.
D’Alessandro ha poi confrontato queste statistiche ai risultati del mio volgarometro, elaborando il giurinsultometro. Il risultato? Gli insulti a più alta carica offensiva, rilevati dal volgarometro, sono proprio quelli che più spesso spingono gli italiani a chiedere giustizia in tribunale.
CONTRADDIZIONI. Un’ultima notazione sulle sentenze. Molte sono straordinariamente efficaci ed equilibrate, ma molte altre sono, almeno apparentemente, contraddittorie. Per fare un esempio: con una sentenza la Cassazione ha condannato con l’aggravante dell’odio razziale una persona qualificandola come «sporca negra» in quanto «combina la qualità negativa al dato razziale», e «non risulta adottata in occidente alternativamente l’espressione sporco giallo, né in Africa o Cina sporco bianco». Eppure la stessa Cassazione in unaltra sentenza non aveva riconosciuto l’aggravante a un commerciante di Treviso che aveva apostrofato un Senegalese con l’espressione nero di merda. Perché queste contraddizioni? Non solo perché la percezione di un insulto può essere soggettiva (cioè dipende dal contesto, dall’epoca, dai toni utilizzati, dalla sensibilità dei parlanti e dei giudici), ma anche perché i giudici spesso non consultano gli studi linguistici sul turpiloquio, che peraltro, fino a pochi anni fa, erano pressoché inesistenti. Ora, però, non hanno più questo alibi. (Vito Tartamella)
 Roger-Pol Droit
Roger-Pol Droit
Vivere oggi con Socrate, Epicuro, Seneca e tutti gli altri
«Panorama.it»
01-02-2012
«Liberal»
21-12-2011
La dimenticanza s’è fatta vistosa da due o tre generazioni: «Tutto quello che, a prescindere dal valore effettivo, era stato trasmesso nel corso di duemilacinquecento anni si trova lasciato incolto, abbandonato dalla scuola». Grandissimo errore visto che Greci e Romani hanno costantemente alimentato l’immaginario della cultura europea. Questi Antichi che a molti paiono polverosi o superati si incontrano in ogni campo, dalla pittura al cinema, da Shakespeare a Racine, da Robespierre a Marx, e perfino nei deliri di Hitler. Questa considerazione ci porta direttamente a Nietzsche. In un suo testo ci avverte che «solo la tragedia può salvarci dal buddhismo». La pratica orientale, secondo il filosofo tedesco (oggi spesso citato, ma non così ben conosciuto nella sua interezza di pensiero), simboleggia le terre del Sol Levante, il rifiuto di soffrire, la negazione della volontà di vivere, l’accesso sognato a un mondo senza conflitti, pacificato, privo di dolore così come di passioni. Un universo nel quale non abitiamo, ovviamente. «La tragedia – spiega Roger-Pol Droit – diventa invece sinonimo di Occidente, di disagio accettato, di vita conquistatrice, di conflitti patiti, di guerre e di forze antagonistiche che accettano sia di soffrire sia di gioire. Vi sono solo queste due vie. Nessun’altra». Certo, Nietzsche per alcuni aspetti è discutibilissimo, ma la sua scelta radicalmente occidentale – e noi diremmo quella più realistica e a noi più prossima – è senza appello. E ancora: «Le emozioni pesanti della tragedia greca sono effettivamente agli antipodi degli esercizi di meditazione buddhisti. Questo perché esse ci fanno comprendere non solo che il conflitto guida il mondo, ma che esso è posto anche in noi stessi». La tragedia rimanda al teatro. Ossia al movimento, al dialogo (che etimologicamente non è da intendersi solo come il parlare tra due soggetti, anzi), al ‘tutto scorre’ di Eraclito, all’esistenza come continuo adattarsi alle mutazioni emozionali e storiche e come ricerca di un equilibrio interiore che non prescinda dal mondo. Può apparire bizzarro per qualcuno l’accostamento delle parole di Platone al teatro. Invece è sensato. Più o meno tutti sanno, o hanno orecchiato, dell’‘allegoria della caverna’. Questa caverna, sostiene Roger-Pol Droit, «è una messinscena». Definizione propriamente teatrale, quindi: «La curiosa storia di prigionieri incatenati fin dall’infanzia, che scambiano per oggetti reali le ombre proiettate, e che poi vengono liberati e portati all’aria aperta, abitandosi così alla luce e al mondo vero». Platone insegnava forse che il mondo reale è fatto solo di ombre e di riflessi, mentre il mondo vero è quello delle idee, che forniscono il modello a tutto ciò che percepiamo? No, non ci si deve fermare a questa specie di ‘fissismo’, che proprio non appartiene al pensiero di Platone. Secondo il grande ateniese l’attenzione deve essere spostata verso quel movimento che costituisce il nucleo stesso della filosofia: «Liberare il prigioniero, scioglierne i vincoli, costringerlo ad alzarsi, a camminare, a lasciare la sua posizione primitiva, a salire faticosamente verso la luce, il cielo delle idee, la visione delle cose reali». Quel che conta è mettersi in cammino, anche se più tardi si dovrà tornare nel buio della caverna. Il movimento continua, dunque. Per Platone, ma non solo per lui, la contemplazione è solo una sosta, non uno status eterno o desiderabile in quanto tale.
Sempre a proposito di teatro, Platone nelle sue opere non indica mai con esattezza chi ha ragione e chi ha torto, a parte visibili simpatie per questo piuttosto che quel protagonista dei dialoghi. Ecco allora il teatro delle idee, sintesi del movimento del pensiero: «Sempre punti di vista molteplici, molteplici dimensioni che si rispondono. Dialogo dell’anima con se stessa, teatro riflessivo nel palcoscenico della mente. Pensiero mai come blocco omogeneo, compatto, massiccio, immobile». Magari è azzardato quel che aggiungo, ma può starci, come si suole dire: Platone insegna che il pensare è qualcosa di fluido, elemento che, in una visione sociologica, siede accanto a ‘società liquida", teorizzata in questo periodo da Zygmunt Bauman, il quale ci indica appunto il movimento, la ‘fusion’, il ‘melting pot’ non solo delle razze ma anche degli orientamenti comportamentali. Parrà più chiaro a questo punto quanto sia attuale la segnaletica degli Antichi, bussola che ci aiuta, oggi dopo 2500 anni, a riconsiderare «l’esperienza del pensare come mutamento dell’essere». Greci e Romani non avevano la testa tra le nuvole, non si baloccavano con costruzioni mentali astratte. La filosofia era e doveva sempre essere ‘terapia dell’anima’. E non è un dramma – a meno che si abbracci totalmente una religione – trovarsi di fronte a grandi dilemmi. Questi fanno parte della nostra vita. Esiste anche ‘la dolcezza dell’incerto’. Il dubbio può rendere felici, sosteneva l’ateniese Pirrone, filosofo alquanto misconosciuto (scuola dello scetticismo). Il quale sosteneva che noi non sappiamo per davvero che cosa sia il mondo, e nemmeno che cosa sia il bene o il male. La sospensione del giudizio, a suo avviso, potrebbe condurre alla serenità.
Roger-Pol Droit tuttavia avverte: «Scettico non designa una pura volontà intellettuale di dubitare di tutto, in maniera continuativa, sistematica ed estrema. I discepoli di questa scuola non mettono in questione, per esempio, la realtà dei loro affetti... la loro posizione non consiste nel mettere in dubbio l’esistenza delle sensazioni o nel rifiutare l’idea che esista una realtà, giacchè a loro sembra stravagante mettersi a fare supposizioni del genere». No, per Pirrone e compagni la realtà non è affatto un abbaglio, un miraggio, un’illusione, anche se, dicono, non esiste alcuna via di accesso a una conoscenza sicura della sua essenza o del suo funzionamento. Tutto questo è riassunto nel termine greco ‘aporia’, situazione priva di sbocchi, una via senza uscita. Altro avvertimento dello studioso francese: «Facile pensare a un atteggiamento psicologico esitante, quasi paralizzato, esposto in ogni caso al rischio di fissarsi e di restare immobilizzato». Semmai il ‘vicolo cieco’ per gli scettici è sinonimo di tranquillità dello spirito, è garanzia di serenità. Roger-Pol Droit prosegue nella sua analisi: «Ciò che risulta privo di una soluzione non genera necessariamente tormenti e angosce. Gli scettici constatano che a ogni argomentazione corrisponde un’argomentazione contraria di eguale forza... la conclusione che se ne deve trarre non è, come spesso si è creduto, che la verità non esiste, o che essa è inaccessibile alla nostra intelligenza... affermare che non si possa affermare nulla sarebbe evidentemente un’affermazione». Prudenza filosofica, non rinuncia tout-court alla ricerca, tenendosi distante da dichiarazioni che sono immediatamente tese a trasformarsi in dogmi. Neutro significa ‘ne-uter’, ossia né l’uno né l’altro. Un modo per distanziarsi anche da se stessi usando la ‘coperta mentale’ del dubbio. Così, dicevano nella Atene ove si confrontavano i pensieri, ci si tiene il più possibile lontani dalle ‘tempeste dell’anima’. Il termine ‘tempesta’ è tipicamente greco visto che quei nostri antenati erano navigatori e ben conoscevano le insidie, anche mortali, del mare. A questo punto ci viene in mente Ulisse, che del mare sapeva fin troppo.
Omero canta sia il conflitto sia il passare del tempo. Gli eroi che si muovono attorno alle mura di Troia o nel mare aperto sono dentro il travaglio esistenziale e ambientale. E i saggi? Fanno tutto il contrario, nel senso che cercano di sfuggire ai conflitti, fuori e dentro se stessi. Sanno che sarebbe stupido aspirare a un universo privo di turbolenze, quindi puntano a una forza che li ripari dalle tempeste. L’uomo armato e l’uomo in tunica appartengono in ogni caso alla medesima sfera mentale greca: gli uni amano il sangue, le armi, la vittoria e la gloria, gli altri tendono alla parola, alla ragione, alla serenità e alla pace del cosmo. Opposti? Solo in apparenza dato che i filosofi al posto delle lance usano le argomentazioni. «Filosofia come prosecuzione della guerra con altri mezzi; il terreno è diverso, gli scontri pure. Ma il dispositivo d’insieme rimane identico», sostiene Roger-Pol Droit, che ancora una volta insegue la costante del comportamento e della mitologia dell’antica Grecia. Ed è questo: il pensiero deve trasformare l’esistenza. O ancora: pensare diversamente significa vivere diversamente. L’Iliade e l’Odissea non sono film d’avventura o cartoons giapponesi anche se le suggestioni per così dire filmistiche sono fortissime ma la rappresentazione di un duplice movimento che ha come tracciato quello che dovrebbe condurre alla saggezza, alla pace con se stessi, all’armonia delle cose e delle persone.
Sorge a questo punto un dilemma: il tipo di felicità tratteggiato dai Greci è di tipo egoistico? La preoccupazione per il proprio sé, il tenersi distante dalle ‘tempeste’ e altre direttive cui abbiamo accennato parrebbero confortare questa tesi, come hanno ribadito storici e studiosi di grande valenza. Pierre Hadot è in disaccordo. Il modello vero della filosofia ellenica, dice, è Socrate, l’uomo che «è stato messo ai fianchi degli ateniesi dalla volontà degli dei... al fine di pungerli come un tafano». Lui stesso afferma, per la penna di Platone: «Io sono egualmente a disposizione di tutti, poveri e ricchi». Esiste, e si fa sentire sempre, la spinta al ruolo di ‘missionario’, il che significa non rivolgersi alle elites agiate e culturalmente più attrezzate. Lo stesso discorso vale per altre scuole. La teoria degli epicurei era molto conosciuta e gli adepti del capofila avevano come compito quello di ‘rivolgersi’, come scrive Hadot, «a tutti gli uomini, anche a quelli incolti, anche a quelli privi di una particolare formazione intellettuale, nonché nell’accogliere schiavi o donne, persino cortigiane, come quella Leonzia, discepola di Epicuro, raffigurata ‘in meditazione’ da un pittore». Gli stoici addirittura esortavano a denunciare certe convenzioni sociali e incitavano al ‘ritorno alla semplicità di una vita secondo natura’. Per Epitteto «il filosofo è il testimone (martys) di Dio». E Platone e Aristotele? Nessun egoismo nel loro pensiero, tanto è vero che cercavano formule politiche per il bene dell’intera polis. Altro che ripiegamento su se stessi. «I cristiani non li dimenticheranno», annota Hadot, «il modello stoico sarà ripreso dalla tradizione monastica e ascetica». Non è un caso che nel 1605 Matteo Ricci, quel religioso cattolico che andò in estremo oriente, volendo preparare i cinesi al Cristianesimo, abbia composto un Libro dei 25 paragrafi che era in gran parte la traduzione parafrasata del Manuale di Epitteto. Esiste dunque un continuurn tra pensiero greco e il modo di pensare e operare che è venuto dopo. Se solo si pensa all’influenza di Platone e di Plotino nell’esperienza mistica cristiana, qualsiasi ipotesi di cesura netta tra l’avanti e il dopo Cristo in Occidente cade in frantumi. (Pier Mario Fasanotti)
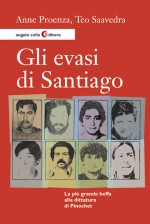 Anne Proenza, Teo Saavedra
Anne Proenza, Teo Saavedra
Gli evasi di Santiago
«wuz.it»
04-11-2011
Il libro della giornalista Anne Proenza e del musicista Teo Saavedra, rifugiato politico in Francia dal 1977, prende l’avvio nel 1986, dopo un fallito attentato alla vita di Pinochet. E ci racconta una storia non nota, della fuga di quarantanove detenuti politici dalla prigione pubblica di Santiago durante la notte del 29 gennaio 1990. Una beffa per il regime. Una storia grandiosa di coraggio e tenacia, di forza di volontà e di idealismo, di tempra interiore e sì, anche di intelligenza.
Una fuga attraverso un tunnel scavato dai prigionieri. Parte da una delle celle, sbuca in superficie a 60 metri di distanza, oltre il muro della prigione, oltre la galleria di una nuova stazione della metropolitana, nei pressi di una stazione più vecchia. Di per sé non è una storia originale: di quante fughe abbiamo letto, quante ne abbiamo visto al cinema? Una delle pellicole che i prigionieri di Santiago guardano è La grande fuga con Steve McQueen - e non serve solo come passatempo. Eppure, come riescono Proenza e Saavedra a rendere il loro libro così appassionante, un vero e proprio page-turner? Gli evasi di Santiago è una combinazione perfetta di romanzo d’avventura e di storia vera (tanto più drammatica per questo), con personaggi vivi che impariamo a conoscere (loro, le loro famiglie, le loro donne) e con una decisa connotazione politica che è una condanna degli abusi di qualunque dittatura. In più, la tensione è fortissima - anche se sappiamo che l’evasione avrà successo.
Se il racconto della fuga dovesse seguire una sequenza temporale lineare, risulterebbe monotono e claustrofobico. Invece ogni capitolo ha, come titolo, una data e il luogo dell’azione (per dare un’idea, uno è “Ottobre 1989. Prigione pubblica di Santiago, tunnel, quarantacinque metri”), e il tempo si sposta, avanti e indietro, tra il 1986 e il 1990 inoltrato. Conosciamo i carcerati, la loro lotta per ottenere il riconoscimento di prigionieri politici con celle separate da quelle dei delinquenti comuni, ascoltiamo le discussioni prima della decisione per un piano di fuga: un’azione è meglio dell’attesa passiva, anche se fosse soltanto per mostrare una caparbia opposizione. È stupefacente leggere di come Manuel, Miguel, Hugo e gli altri abbiano risolto i problemi pratici dell’impresa dello scavo del tunnel, dell’aerazione mano a mano che si spingevano più avanti nel cunicolo soffocante, di come trasportare indietro la terra rimossa e soprattutto di dove metterla. Un’impresa eroica, i disegni illustrativi ci lasciano ammirati. E poi, di chi fidarsi? Tutti hanno già provato la tortura e sanno che resistere può andare al di là delle forze umane. Inframmezzati ai capitoli degli scavi, degli incontri dei prigionieri con i famigliari (nasce un amore, uno di loro diventerà padre), ci sono i capitoli del dopo-fuga con il giudice che ha l’incarico di indagare sulle responsabilità della fuga ed è sottoposto a pressioni e ricatti, anche se il regime di Pinochet è prossimo alla fine.
Un libro da leggere, con la tensione di un thriller. Con qualcosa di più che in un thriller. (Marilia Piccone)
 Giuliano Corà
Giuliano Corà
Ti voglio bene maestro!
«Il Giornale di Vicenza»
02-12-2011
La lunga esperienza di Corà all’interno della scuola elementare si dispiega in una sorta d’incalzante amarcord impegnato nella ricomposizione di un’avventura umana e professionale dal sapore deliziosamente fané. E tuttavia, sotto tanto garbo e finezza espressiva, scorre il fil rouge dell’ironia, quasi l’autore volesse prendere le distanze da una materia che tenta continuamente di risucchiarlo nelle sue spire avvolgenti e tenerissime. Una materia ricca di fantasia, candore, attenzione, qua e là attraversata da richieste d’affetto spesso nascoste dietro misteriose ritrosie o crepitanti impennate d’orgoglio.
Ciò che emerge in filigrana è il senso di un rapporto maestro-allievo allo stesso tempo intenso e cruciale. Ecco allora che la vivacità di Silvia, la pensosa fierezza di Roberto, la riservatezza di Franco, l’inquietudine di Lucy, la genialità di Guglielmo, la passione per il disegno di Ilaria diventano i colorati, suggestivi tasselli di un puzzle che il maestro Giuliano Corà dispone con finezza sul pentagramma di una narrazione tanto piacevole quanto densa di piste sotterranee e deviazioni impreviste. Pagina dopo pagina i ricordi assumono la forma di un diario autobiografico tra le cui pieghe la complessa vicenda di un insegnante di lungo corso si fonde e s’intreccia con quella dei suoi piccoli alunni, che hanno saputo regalargli il senso di una storia viva e profonda, fatta di conoscenza, affetto e rispetto reciproco.
Una storia che in qualche caso ha il sapore di una fiaba inquieta e beffarda, anche per via di quel vento capriccioso che talvolta scuote gli alberi e colpisce con le sue raffiche gelide e distanti la fiduciosa attesa di bambini che non sempre si sentono amati e compresi... Ma poi le stelle tornano a brillare, i grilli a cantare, le rane a saltare... Che cosa è accaduto? È accaduto che il maestro si è seduto lì, accanto a loro. Un piccolo gesto, una parola, un sorriso e tutto si è magicamente ricomposto nel cerchio rassicurante di un’armonia condivisa e serena.
La stessa che accompagna tante pagine di questo breve racconto capace di mettere insieme intelligenza, buonsenso e alcuni principi della più recente psicopedagogia con il profumo antico di una scrittura scintillante e colta. (Maurizia Veladiano)
«L'Indice dei libri del mese»
01-12-2011
Un atteggiamento non dissimile da quello del poeta Caproni quando fingeva, secondo il racconto di Cerami, di rischiare il licenziamento da parte del direttore a causa della propria ignoranza. L’immagine di uno dei più grandi poeti contemporanei italiani (ma per i suoi allievi era solo ‘il maestro’), disperato per il fatto di non saper misurare la lavagna della classe, è veramente illuminante: un bambino si alza, suggerisce di moltiplicare la base per altezza, prende in mano la situazione e soccorre l’insegnante. Ecco il ribaltamento creativo del ruolo, così gravido di ricadute positive nel processo dell’apprendimento e che (al contrario di quello che potrebbe sembrare) va nella direzione di un rafforzamento del ruolo e dell’autorevolezza di chi insegna.
Corà usa gli stessi espedienti che non appartengono a nessun codice pedagogico e sarebbero il motivo della disapprovazione di più di una direzione didattica. Nel bellissimo libro Caproni maestro, a cui è impossibile non pensare leggendo il volume di Corà, si racconta che il maestro-poeta portava in classe il trenino Rivarossi, felice come un bambino, e distribuiva dolcetti come premio. Corà rincorre lo stesso principio per cui piacere di stare in classe e gioco costituiscono i requisiti per il superamento di ogni difficoltà. Del resto, racconta l’autore parlando di sé nel capitolo It’s a long way to Tipperary, anche il percorso che ha portato il maestro in cattedra è stato accidentato e non lineare, e ogni errore è comunque interessante e pieno di senso.
Altre le insensatezze che l’autore addita all’attenzione del lettore: l’effetto soporifero dei collegi docenti, l’abbandono di Lucy, la bambina ghanese in attesa della certificazione alla quale vengono sottratte attenzione e risorse: «Nessuno avrà del tempo per lei e lei continuerà a riempire i quaderni di stupidaggini e a immusonirsi sempre dí più. Ma in fondo chissenefrega di Lucy: ‘Che ’i torna a casa sua a magnar banane’, direbbero in quel comune della provincia di Vicenza dove qualche tempo fa hanno negato la mensa ai figli dei poveracci che non potevano pagarsela, e dove poi hanno inserito il dialetto veneto tra le lingue che si possono usare ín Consiglio comunale. Così sí fa cultura».
Meno amara e più divertente, nel quadro complessivo della nuova ingerenza genitoriale nel sistema scolastico, la classificazione dei genitori inventata dall’autore: accanto al GN (genitore normale), c’è il GGM (genitore Giuseppe e Maria), il genitore convinto di aver prodotto il miglior bambino del creato: «Spesso la prima visita del GGM avviene il primo giorno di scuola, all’uscita. Rimira la creatura, e poi l’abbraccia, ma con quel delicato e timoroso rispetto che naturalmente si riserva a ciò che ci è superiore. Poi vi fissa. Non vi chiede niente – ancora non vi conosce, non si fida – ma tuttavia vi scruta: cerca nel vostro sguardo il bagliore dell’avvenuta illuminazione. Non trovandolo se ne va, Bambinello per mano: spesso gli uomini sono ottusi di fronte al Divino, ci vuol pazienza».
Ma forse il capitolo più toccante è quello contrassegnato dalla tessera ‘St’ di stella e intitolato Il vagabondo del Dharma: vi si racconta la storia di Vitale, che salta fuori da una pizzeria e riconosce il suo maestro dopo tanti anni: a partire da quell’incontro si snoda una lunga amicizia fatta di lettere, chiacchiere, libri. Difficile immaginare qualcosa di più bello di questo frutto tardivo di un lavoro-non lavoro, che forse un’arte non è e non gode di nessun riconoscimento economico e sociale, ma sicuramente ha una funzione e un senso nel mondo degli umani. (Monica Bardi)
«stilos.it»
10-11-2011
Quello di Giuliano Corà, maestro anticonformista, approdato all’insegnamento per vie lunghe e tortuose – un lavoro che, come si diceva un tempo, è più una “missione” o un’arte – è un libro che, da maestra, consiglierei agli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola (ma anche a tutti i genitori). A tutti quelli capaci sopportare venti o venticinque «affarini urlanti che ti tormentano continuamente con i bisogni più assurdi», ma che, per i mille problemi che affliggono la scuola italiana, non sono immuni da sentimenti di delusione e di stanchezza, o che si sentono demotivati, incapaci di entrare in classe con l’entusiasmo necessario, la lettura di Ti voglio bene maestro! sarà in grado di infondere una dose di ottimismo o, almeno, una visione meno nera del futuro.
Si sa che i primi anni di scuola sono fra i più determinanti, dal punto di vista formativo: possono segnare una strada piuttosto che un’altra e da essa dipenderà forse il futuro del bambino. Un ruolo importante, anzi, fondamentale, dunque, quello dell’insegnante, che viene però spesso sottovalutato, persino dai diretti interessati. È vero, con le colleghe e i colleghi si parla, ci si confronta, capita spesso che ci si lamenti delle cose che non vanno, della burocrazia che ha complicato tutto, degli alunni che sono cambiati, delle famiglie che, passando da un estremo all’altro, o si intromettono troppo nella vita scolastica del figlio, o se ne disinteressano completamente. Poi, però, quando si chiude la porta della classe, è con loro che si ha a che fare, con gli alunni: uno diverso dall’altro, per carattere, indole, capacità di apprendimento e di comunicazione. Con alcuni di essi si instaura un rapporto affettivo molto forte, con altri, invece, si ha la netta sensazione di non essere riusciti a fare del nostro meglio o, addirittura, di averli “persi”, di aver fallito. E ci si sente soli.
Ma le diciotto storie di alunni, insegnanti, dirigenti e genitori, che vengono raccontate dal maestro Giuliano con ironia e una nota di nostalgia – una nostalgia che comincia dalle vecchie figurine dell’alfabeto che illustrano le pagine del libro – riguardano categorie in cui, con il sorriso sulle labbra, non sarà difficile riconoscersi o riconoscere qualcuno con cui abbiamo avuto a che fare. Sono, ad esempio, ‘i genitori Giuseppe e Maria’, che credono di aver messo al mondo la reincarnazione di Gesù Bambino; la bambina straniera che a causa dei tagli della riforma è costretta a ‘fare da sola’; l’insegnante che, a un certo punto, decide di diventare Dirigente; bambini molto dotati, apparentemente distratti, che invece sono in grado di svolgere due attività contemporaneamente; bambini insicuri, bisognosi di conforto e di incoraggiamento… Pagine divertenti anche sulla disciplina, sui voti, sugli scambi di merendine e sorpresine, situazioni che offrono un punto di vista certamente non molto usuale sulla vita di ogni giorno in classe.
Ti voglio bene maestro!, però, ci fa anche riflettere su come «insegnare è, prima di tutto, ascoltare le domande dei bambini, scoprire che la loro curiosità è la tua stessa curiosità, e che il brivido della ricerca e della scoperta è comune. Insegnare è imparare. È rendersi conto, cioè, che sì, quella cosa la sapevi, credevi di saperla, ma che mai l’avevi davvero capita come nel momento in cui l’hai smontata e ricostruita per poterla spiegare con chiarezza, e quasi ti par di non stare in cattedra ma sui banchi, e sei felice, come se qualche maestro l’avesse finalmente spiegata a te [...] Poche cose ti fanno sentire profondamente ‘umano’ come il rapporto che si instaura tra chi vuol sapere e chi quel sapere vuole trasmetterlo. Poche cose come un insegnamento così vissuto ti danno il senso, o per lo meno la speranza, di aver speso bene la tua esistenza». (Lidia Gualdoni)
«W la scuola! La scuola così come la vivono maestri come Giuliano Corà !»
03-11-2011
 Alexandre Jollien
Alexandre Jollien
Il filosofo nudo
«Giornale di Brescia»
30-12-2011
Pensieri sgranati in un diario quotidiano di cui Alexandre Jollien è «Il filosofo nudo» che si confronta con la vita e i suoi misteri, le sue palizzate e le sue barriere, i suoi oscuri sentimenti e le sue fulminanti apologie. E chi meglio di lui, che il dolore lo conosce perfettamente e ci convive giorno dopo giorno, costretto su una sedia a rotelle dopo diciassette anni trascorsi in un centro specializzato a seguito di un grave handicap cerebrale-motorio, può valutare l’esistenza e le sue tribolazioni? E magari chiedersi con sgomento: «Da cosa diavolo dipende la mia, la nostra felicità?». Questo giovane filosofo, nato in Svizzera nel 1975, che ha scritto libri come Elogio della debolezza, Il mestiere di uomo e Cara filosofia, ha trovato in Seneca, Meister Eckhart, Nietzsche, Kierkegaard, Platone e Socrate, Sant’Agostino e tanti altri pensatori, il raccordo con la vita vincendo la sua condizione in nome di una grande passione umana: la verità filosofica come ideologia dello spirito.
Lei scrive: «Non si vincono le passioni con la lotta, ma aprendosi alla vita e all’accoglienza». Cosa l’aiuta ad essere così saggio?
Per me non sono tanto lo studio, la riflessione e le idee che mi aiutano a vincere le passioni, ma piuttosto un’arte di vivere «filosofica», che ho assimilato completamente e che mi aiuta a contenere la vita entro gli argini di un’umanità consapevole e serena. Ho trovato un aiuto formidabile nella meditazione zen, che consiste nel guardare passare i pensieri divertenti o no, senza identificarsi in essi. Il nostro destino dipende sovente dal fatto di prendere troppo sul serio le nostre idee.
Quanto è importante per lei credere nelle parole?
Le parole permettono di identificare e di cercare ciò che non va nella nostra lingua, e di scegliere quello che non va nella nostra vita. Molto spesso le parole possono trasformarsi in prigione, ridurre le sensazioni. Ma le parole aiutano a superare i mali, a entrare in contatto con gli altri, a capire che non siamo soli.
Lei definisce «maestri» i suoi bambini. Ma siamo in grado di comprenderne il messaggio, travolti come siamo da un ritmo di vita stressante e avvilente?
Quando guardo i miei bambini che non hanno ancora perduto la spontaneità, ma non hanno conoscenza del calcolo esistenziale che ogni adulto compie quotidianamente, provo una felicità che genera molte altre sensazioni. In questo senso la vita è un invito a ritrovare la fiducia che è alla base della nostra esistenza.
La felicità che dice di possedere grazie alla sua famiglia, per lei è una conquista, o una dimensione naturale favorita dall’amore corrisposto?
La fortuna non è una conquista, né si può partire alla conquista della fortuna. Nel caso di una famiglia si tratta piuttosto di scoprire le bellezze di essere amati e di amare. In questo senso è un dono gratuito ed è difficile accoglierlo in maniera giusta, per colui che è abituato a conquistare tutto.
Lei confessa di provare invidia per la normalità degli altri, in confronto alla sua situazione fisica. La sua grande mente non riesce a colmare grazie alla superiorità intellettuale anche le restrizioni fisiche?
Dentro la gelosia e la voglia si nasco. nde sovente l’illusione che la vita è meglio altrove e che sarebbe più facile in un corpo in piena salute. È un’illusione non sempre razionale e giustamente non è il discorso razionale che può guarirla, ma piuttosto l’esperienza della meditazione che può mostrarci che possiamo scoprire la gioia e il benessere dentro un corpo che è il nostro.
Che cos’è per lei l’amore incondizionato?
L’amore incondizionato ai miei occhi è il non giudicare. È un amore che non esige niente dall’altro, ma, paradossalmente, vuole il meglio per l’altro. Penso che tutto possa naturalmente nascere da un legame che noi abbiamo con il nostro prossimo. È come l’allargarsi di un cerchio nell’acqua che si estende all’infinito verso l’umanità.
Non crede che dovremmo tutti imparare a convivere con le nostre difficoltà? Lei nonostante questo diario ribelle, ci è riuscito magnificamente. Può svelare anche a noi la formula magica che ha sperimentato lei?
Per prima cosa bisogna sapere che non ci sono formule magiche e che qualunque cosa si faccia, ci sarà sofferenza. Per me due fatti sono d’aiuto: la pratica della meditazione, e l’attorniarsi di amici nel bene come si dice sempre. Approfondire questi due elementi mi aiuta giorno dopo giorno, anche senza – lo ripeto – trovare una soluzione radicale.
I grandi pensatori come Platone, Aristotele, Rousseau, Kant, Hegel... riescono sempre a consolare chi si rivolge a loro?
Questo dipende dai percorsi e dalla personalità di ognuno di noi. Da parte mia scopro che la gioia e il benessere dell’amore incondizionato si manifestano al di là delle parole e in una pratica quotidiana. La lettura dei grandi filosofi mi ha dato la capacità di comprendere meglio gli altri. La pratica dello zen mi aiuta a non giudicare gli altri, e a cessare di idealizzarli per vivere pienamente. (Francesco Mannoni)
«www.stradanove.net»
20-10-2011
Qualcuno definirebbe la passione come ciò che, in me, è più forte di me. Spinoza conferma: «Siamo agitati dalle cause esterne in vari modi e […] come le onde del mare, agitate da venti contrari, fluttuiamo, inconsapevoli della nostra sorte e del nostro destino». Ma è meglio abbandonarsi ad esse o lottare per eliminarle? Svuotarsi interiormente dedicandosi ad esercizi spirituali o cercare di comprendere i nostri eccessi?
Il filosofo di origine svizzera Alexandre Jollien, colpito fin dalla nascita da un handicap cerebrale-motorio, spinto dalla gelosia e dall’invidia per il corpo di giovani belli e sani che, con apparente facilità si adattano alla vita, ha cercato di rispondere a queste e ad altre domande sulle passioni: stimolato dalla prescrizione del medico a scrivere un trattato, ha accettato questa sfida ed ha tenuto un diario, attento a «citare poco, il meno possibile. E indagare, ricercare, incontrare». Il risultato è Il filosofo nudo. Piccolo trattato sulle passioni, un volume che, oltre a mostrarci l’autore coraggiosamente 'nudo' di fronte a se stesso e agli altri, consegna alle pagine le scoperte quotidiane, frutto di una lucida analisi di stesso, di scambi di vedute con internauti e dell’ascolto continuo degli altri.
L’autore riesce così a disegnare la traccia di un possibile percorso che può portare al 'distacco' da quei comportamenti e stati d’animo per lui dolorosi. È facile prendere coscienza del fatto che le passioni che si manifestano nella vita sociale, nel lavoro e in famiglia sono spesso fonte di sofferenza, ma più difficile è trovare il rimedio. Jollien, non nascondendo le difficoltà, le contraddizioni e i continui passi falsi, suggerisce allora la duplice via dei precetti filosofici occidentali e della pratica degli esercizi spirituali uniti alla meditazione zen. Ricco di stimoli, di esempi tratti dalla vita quotidiana che rendono la lettura più vicina all’esperienza del lettore, e di massime ricorrenti – come “concentrarsi sul qui ed ora” oppure “fare il bene e mantenersi nella gioia” – Il filosofo nudo costituisce un altro tassello verso la costruzione di una personalità libera dai turbamenti, capace di trasformare le difficoltà in occasioni di cambiamento e di miglioramento. E ancora una volta la filosofia non è qualcosa di distante o una disciplina per pochi eletti ma, secondo la definizione di Epicuro, diventa più concretamente «un’attività che, per mezzo di discorsi e ragionamenti, ci procura la vita felice». (Lidia Gualdoni)
 Laetitia Barlerin
Laetitia Barlerin
Storie incredibili di animali fuori dal comune
«Il Giornale di Vicenza»
11-11-2011
CANGURA SALVATRICE. Un temporale spazza i campi australiani a 130 chilometri da Melbourne. Un agricoltore esce all’alba per vedere come va. Si stacca un ramo e lui finisce a terra, svenuto in 10 centimetri di pioggia e fango, a faccia in giù. Da casa moglie e figlio, pochi minuti dopo, sentono rumori e un guaito insistente. Quando escono vedono una cangura battere i piedi seduta sulle zampe posteriori, vicino all’uomo ancora senza conoscenza ma con il volto e le spalle rivoltati all’insù. Lei ha un nome: è Lulù, qualche anno prima raccolta ferita dalla famiglia Richards, curata e guarita, rimasta semidomestica un po’ e poi sempre aggiratasi in zona. Quando arrivano i soccorsi Lisbeth e il figlio Luke sono convinti che Lulù abbia salvato ‘papà’ Leonard, girandogli il capo e richiamando l’attenzione. Tre mesi dopo la cangura viene insignita della croce al merito della Società per la prevenzione della crudeltà contro gli animali.
BATTESIMO... CON L’ORSO. Tra i bambini berlinesi che hanno oggi quattro anni o poco più, ben 541 portano lo stesso nome: Knut. È il nome di un cucciolo di orsa bianca nato afine 2006 allo zoo di Berlino, abbandonato anzi minacciato dalla madre, allevato dal guardiano Thomas (davanti a 500 giornalisti, il giorno del debutto pubblico) prima con un biberon di latte ogni due ore e poi con pappe di cibo per gatti e fegato di merluzzo. Dai suoi 800 grammi iniziali Knut cresce su un’irreale polemica scatenata dal quotidiano popolare Bild (meglio sopprimerlo che farlo allevare da un ‘mammo’ avrebbe chiesto, ma non era vero, un iperanimalista). Della mobilitazione popolare, una vera e propria knutmania che diventa marchio commerciale, restano le registrazioni dei neonati all’anagrafe. Poi la passione passa presto: quando la «morbida palla di pelliccia bianca» diventa un orsetto di 50 chili, Knut finisce nel dimenticatoio. Fino a quando muore nel marzo di quest’anno.
MEIN LIEBE PEDALÒ. In un laghetto alla periferia di Münster è diventata famosa una cigna nera... innamorata di un bianco pedalò a forma (naturalmente) di cigno. Bianco. Tanto grande è l’amore, non corrisposto, da trattenere la cigna al freddo invernale della Bassa Sassonia mentre fratelli e sorelle cercano altri tepori. Che cosa trovi in lui la nera Petra, oltre alle gigantesche dimensioni, non si sa. Allo zoo della città tedesca, dopo averla ricoverata al caldo (complice proprio la barca figurata, richiamo per la cattura), hanno provato a darle un compagno in penne e ossa, ma lei spasima solo per lui, il pedalò. Che tampina anche quando i gitanti lo noleggiano per un’escursione sul lago. C’entra l’imprinting di una lontana visione neonatale, probabilmente: ma arriverà mai il principe giusto fattosi cigno normale?
PIPISTRELLO WONDERBRA. Sala di fisica di un università americana. Jenny, studentessa di 19 anni, sente insistenti vibrazioni in zona reggiseno. Sarà il telefonino in modalità silenziosa appeso al collo e scivolato dentro? Macché: pende normalmente fuori dalla camicia. Sbirciare e armeggiare per capire di che cosa si tratta? Chissà quanto sghignazzerebbero i compagni. Passano due ore di fastidio e ansia, poi suona la campanella. Corsa in bagno, slacciamento di abiti e... grande urlo. Tra le coppe indossate in fretta per correre a lezione si era fermato, e risvegliato, un pipistrello che il giorno prima svolazzava tra la biancheria stesa a asciugare.
CANE SAPIENTE. Soggetto tipico dei vecchi circhi, il cane sapiente. Ma Rico, un border collie che vive in Germania, lo è davvero: riconosce e associa un paio di centinaia di parole e oggetti, come sanno fare solo rari eben addestrati pappagalli, scimpanzé o delfini. Obbedi- sce solo alla padrona e all’istituto di antropologia evoluzionistica di Lipsia l’hanno studiato in rapporto alle teorie sulla formazione del linguaggio umano. Non solo individua e raccoglie gli oggetti di cui sente il nome, ma se il nome pronunciato non corrisponde a un oggetto che conosce già porta alla padrona l’unico altro oggetto estraneo presente nell’area di ricerca. (Antonio Trentin)
«Il Venerdì di Repubblica»
14-10-2011
Britney Spears e Lady Gaga li stressano. La musica classica, invece, può offrire loro un dolce momento di relax. Un massaggio in una spa in genere è gradito, non tutti però amano sentirsi addosso le mani di un estraneo. E lo psicologo? Aiuta. Ma la cosa che toglie loro ogni stress è stare più tempo possibile con i propri padroni, tra giochi e carezze. Veterinaria e giornalista, da anni Laetitia Barlerin conduce in Francia diverse trasmissioni radiofoniche e televisive per dare consigli e notizie utili su come comportarsi con gli amici a quattro zampe. Il più famoso dei suoi programmi si chiama Vos animaux, va in onda sull'emittente radiofonica Rmc, e spesso racconta Storie incredibili di animali fuori dal comune. Che, poi, è il titolo del libro che Barlerin ha pubblicato anche in Italia per Angelo Colla Editore.
Nel volume, così come nel suo programma alla radio, la veterinaria non si limita però a raccontare le storie. Come quella di Mimine, gatta francese che ha percorso 620 chilometri, da Bordeaux a Treveray, per ritrovare la famiglia che l'aveva distrattamente abbandonata nel corso di un trasloco. Oppure quella di Belle, bastardina statunitense di tre anni, che è riuscita ad avvisare l'ospedale con il cellulare del suo padrone, svenuto a causa di un coma diabetico. Tutte le vicende narrate nel libro, molte al limite del verosimile, servono infatti a Barlerin a dispensare regole e spiegazioni per far vivere al meglio i nostri «compagni di vita». Partendo da un presupposto fondamentale: «Nessuno amico a quattro zampe è un essere soprannaturale. Ognuno di loro, però, è un animale capace di provare le nostre stesse emozioni».
Nel suo libro si legge di cani e gatti che amano e soffrono come gli esseri umani. E proprio così?
Questi animali sono mossi da istinti che li rendono molto simili a noi. Tra le tante storie che racconto, c'è quella di Mkombozi, una cagna kenyota che salva un neonato abbandonato, raccogliendolo in una foresta e portandolo alla sua padrona. La vicenda ha fatto il giro del mondo, ma in fondo l'animale ha seguito l'istinto alla protezione del branco, che poi non è così lontano dal nostro senso della famiglia. Del resto, con i cani e i gatti, si fanno troppo spesso gli stessi errori commessi con i figli.
Vale a dire?
Li lasciamo troppo spesso soli. Padroni che lavorano tutto il giorno, e che quindi sono fuori casa anche dieci ore, non dovrebbero prendere un animale a quattro zampe, al massimo un pesciolino rosso. Adottare un cane o un gatto significa essere responsabili del suo benessere e non solo farlo giocare nei weekend. C'è bisogno di una continua interazione tra animale e padrone. Se resta solo per troppe ore, un cane si annoia, distrugge tutto in casa, abbaia ed entra in depressione. Ha bisogno di uscire e di fare moto tutti i giorni. Il gatto, invece, si deprime, si ingrassa e diventa una tigre che attacca il suo padrone la sera quando torna.
Un dog sitter, oppure il vicino di casa gentile, possono aiutare?
Qualcuno che nel corso della giornata porti a spasso un cane è sempre prezioso. Anche la casa, poi, ha la sua importanza. Il gatto, per esempio, è molto legato al suo ambiente: può vivere in un appartamento a condizione di avere spazi differenti per mangiare, fare i bisogni, riposarsi e giocare. È sbagliato concedergli una sola stanza: due sono il minimo, tre o quattro l'ideale. Poi bisogna ricordarsi che l'habitat domestico può essere un luogo pieno di pericoli.
Addirittura?
Per un gatto la vasca da bagno piena d'acqua può diventare un killer, perché, se ci cade dentro, affoga. Anche i fili elettrici non protetti possono essere mortali. Non bisogna poi sottovalutare le piante che teniamo sul balcone: alcune possono essere tossiche. Per fortuna però gli animali, tranne che da cuccioli, sono piuttosto sospettosi e bastano pochi accorgimenti per evitare i pericoli.
Per quanto riguarda il cibo, meglio le crocchette industriali o vanno bene anche i classici avanzi della cena?
Le crocchette sono pratiche, economiche ed equilibrate: l'importante è che siano di alta qualità. Preparare un cibo ben bilanciato prevede una conoscenza nutrizionale che non tutti i padroni possiedono. Bisogna poi ricordarsi che i gatti dovrebbero fare dai 10 ai 15 micropasti durante la giornata. I cani, invece, devono mangiare una o due volte al giorno e sempre dopo di noi. Per loro il cibo ha un valore sociale: se vuole essere rispettato e rendere più tranquillo il suo animale, il capobranco, cioè il padrone, deve servirsi prima del gregario.
E qui tocchiamo dinamiche che non tutti sanno gestire al meglio, tanto che molti finiscono col portare il loro amico a quattro zampe dallo psicologo. Un'esagerazione?
I cani con problemi di comportamento hanno bisogno di aiuto. Ma non è detto che, se un animale è ansioso o irascibile, la colpa sia sempre del padrone. Il contesto dove è cresciuto è importante. E poi alcuni problemi possono essere connaturati all'animale.
Vada per lo psicologo. Però in molti, per farsi perdonare delle lunghe assenze, sono anche disposti a pagare ai loro «amici» costosissimi massaggi in una spa. Non è un po' troppo?
Come nell'uomo, i massaggi possono dar sollievo a dolori provocati, per esempio, dall'artrite. Allora perché non farli? Se però un cane ama poco lasciarsi toccare da estranei, un centro benessere può diventare il suo inferno. E poi il massaggio più utile è sempre la carezza, che aiuta la produzione di endorfine, che danno benessere e piacere.
Nel suo libro, lei dice anche che, per far rilassare Il nostro animale, Mozart è meglio della musica pop...
Un gruppo di etologi inglesi ha dimostrato che anche cani e gatti hanno le loro playlist. Britney Spears, Lady Gaga e, in generale, la musica pop li stressano e basta. Se poi i cani ascoltano l'heavy metal, si agitano e abbaiano. In generale, si può dire che gli animali preferiscono la musica dolce, specialmente quella classica, che prevede il suono del pianoforte.
Animali e bebè possono convivere?
Certamente. Gli animali possono avere delle inquietudini per i cambiamenti, quindi le fasi più critiche sono quelle subito prima e subito dopo il parto. Ma, salvo in rari casi, le nascite non portano sconvolgimenti nell'animale, se si conserva la cuccia al cane e si rassicura, con l'affetto, il gatto. Per proteggere il bebè basta seguire cinque semplici regole: non lasciare mai soli un bambino e il pet, salvo che per pochi istanti; sverminare l'animale ogni tre mesi e dargli l'antipulci una volta al mese; evitare che l'animale lecchi il viso del bebè e disinfettare giochi e biberon; non sgridare l'animale davanti a un bambino e viceversa; se poi il cane si agita e ringhia in presenza del bambino, o se cerca di proteggerlo, chiamate subito il veterinario.
Che dire ai tanti che oggi adottano un animale domestico sul web?
Che un cane o un gatto non sono dvd da acquistare su internet. Bisogna vederli ed entrare in contatto con loro, prima di accoglierli in famiglia. Bisogna avere tempo per loro. In cambio, diventeranno nostri amici per la vita. (Emiliano Coraretti)
 Nicoletta Bazzano
Nicoletta Bazzano
Donna Italia
«Il Cittadino»
15-03-2012
Un'allegoria che è divenuta il fondamento dell'identità collettiva di una nazione e di un Paese così come si è formata sin dalla tarda antichità sino ai nostri giorni che solo nel corso degli ultimi decenni ha preso a venire meno fino a «confondersi nel rutilante caleidoscopio delle immagini simboliche della cultura di massa e progressivamente sbiadirsi fino quasi a scomparire». Dalle prime immagini risalenti al I secolo avanti Cristo, quando i socii italici di Roma ne utilizzarono l'immagine nel corso della loro rivolta contro la Repubblica contrapponendola alla dea Minerva simbolo della dominante, alla successiva adozione in età augustea con l'adozione della cinta turrita, legato al culto di Cibele personificazione della Grande Madre Terra, che abbinata alla cornucopia serviva a dare l'idea della grande ricchezza e abbondanza di un territorio indissolubilmente legato a Roma.
Dall'emarginazione in età medievale, quando anche la stessa nozione di Italia divenne confusa, sino alla riscoperta nel corso del XIV secolo con la nuova specularità tra Roma e l'Italia abbandonata nel corso dei secoli precedenti che ritrova nuova linfa grazie alla vicenda politica di Cola di Rienzo e all'esaltazione degli umanisti, non ultimo Petrarca, esaltatore dei valori di una ‘italianità’ abbinata ai progetti egemonici di Roberto d'Angiò prima e di Giovanni Visconti poi. Un'Italia che nel corso dei primi secoli dell'età moderna verrà sempre più considerata quale madre delle arti, delle scienze e della bellezza, modello inarrivabile, meta di quel grand tour formativo degli aristocratici europei che vi giungono per completare la loro educazione e che vede a cavallo tra Cinque e Seicento la sua immagine stilizzata raggiungere quella forma definitiva destinata a sopravvivere sino ai nostri giorni.
Un'icona solo in un secondo tempo destinata ad assurgere a personificazione di una comunità politica, quando a partire dall'età napoleonica, grazie anche all'interessamento a fini propagandistici del primo console stesso, diviene il simbolo delle neocostituite repubbliche createsi sulla base del modello francese. I primi decenni dell'Ottocento, con la lunga fase del processo risorgimentale, divengono così nella ricostruzione dell'autrice una sorta di nuova età dell'oro per l'immagine della dea turrita, madre putativa dei combattenti per la libertà.
Breve parentesi di gloria prima di un lungo declino: relegata in un piano secondario dai Savoia, volti a esaltare le glorie della dinastia, e quasi dimenticata dai fascisti, più propensi ad esaltare le fortune di Roma, neanche il ritorno alla democrazia e la nascita della Repubblica fermeranno questo inesorabile cammino verso l'oblio. Cacciata dai centri del potere, emarginata dalla cultura che conta, questo suo ‘declino’ non tocca però l'immaginario popolare, dove sopravvive sempre nitida tra francobolli, vignette sarcastiche, canzoni in una sorta di rediviva giovinezza. (Davide Maffi)
«www.stradanove.net»
09-01-2012
È stata, nel corso del Medioevo, la donna umiliata e straziata dalla sofferenza; nel corso dell’Ottocento, durante la stagione risorgimentale e per breve tempo, Donna Italia diventa invece icona della neonata nazione italiana. Quasi evanescente nell’attuale immaginario culturale, Donna Italia sembra essere, meglio di ogni altro personaggio, capace di raccontare «quel complesso e affascinante passato politico e culturale, remoto e prossimo, nel quale radicano sia il nostro presente sia il nostro futuro».
Il testo ripercorre innanzitutto il periodo in cui Italia, nel I secolo a.C., ha visto la luce per la prima volta in forma di donna, su una moneta coniata nella cittadina di Corfinium: il suo volto è quello della rivolta di molte tribù della penisola italiana a Roma.
La constitutio di Caracalla del 212 d.C. segna per la Penisola italiana la prima delle molteplici misure che ridimensionano la sua posizione eccezionale, che verrà definitivamente perduta nel 476 d.C. con la caduta dell’Impero romano d’Occidente. Nei secoli seguenti, in cui il territorio si frantuma in diverse entità politiche, la nozione stessa di Italia appare confusa e, parallelamente, la sua allegoria femminile si presenta con estrema rarità e con nessun attributo peculiare.
Essa torna ad essere politicamente eloquente all’Inizio del Trecento, complici le turbolenze che per tutto il secolo scuotono le realtà comunali. In questo periodo, inoltre, l’Italia conserva, agli occhi dei contemporanei, un carattere speciale, in virtù della presenza di Roma, la città più importante dell’antichità e ora sede del cristianesimo occidentale. Fra le sue immagini letterarie, si ricorda quella di Dante, che la vede disperata in assenza di un imperatore che la governi, proprio come Roma che, priva del pontefice, è bisognosa dell’aiuto imperiale. Ma l’autrice fa riferimento anche ai versi del Petrarca ed al progetto egemonico di Gian Galeazzo Visconti negli ultimi decenni del Trecento.
Con il suo carico di dolore, cocente e inconsolabile, l’immagine di Italia ritorna sulla scena allorché la discesa nella penisola di Carlo VIII re di Francia dà inizio alla lunga stagione delle ‘guerre d’Italia’.
È però fra il Cinque e il Seicento che l’allegoria Italia assume le sue vesti definitive e gli attributi che diverranno canonici: il globo come trono, la cornucopia e la corona turrita illuminata da una stella. Un’immagine riscoperta durante il Rinascimento (anche grazie all’interesse per la geografia), con l’affermarsi dell’idea di unità culturale e religiosa della Penisola, garantita dalla presenza del Papato. Nell’edizione del 1603 dell’Iconologia di Cesare Ripa, un ricchissimo prontuario di immagini allegoriche di matrice classica, elencate in ordine alfabetico e descritte nei minimi particolari, è presente anche quella di Italia, destinata a comunicare a colui che la guarda un’impressione di opulenza e di autorità. E se alla fine del Seicento il mito dell’Italia accusa i primi segni di debolezza, tanto che i viaggiatori stranieri cominciano a essere più colpiti dalla miseria degli abitanti che dagli splendori artistici e architettonici che sono venuti ad ammirare, ai primi del Settecento i letterati italiani tornano a rinverdire i fasti perduti.
Gradatamente, intanto, nei primi anni dell’Ottocento, Italia riacquista i suoi tradizionali attributi, cui si aggiunge una nuova personalità: non più solo allegoria di un territorio, diventa personificazione di una comunità politica, ancora embrionale nella stagione napoleonica, ma pronta a sostenere valori liberali di partecipazione politica e a promuovere con forza l’unità politica della Penisola.
Essa appare nei versi di Manzoni, di Leopardi e di Mameli, nelle statue di Antonio Canova, di Vincenzo Vela e di Stefano Ricci o nel dipinto di Francesco Canella.
Dopo averla ignorata per decenni a vantaggio delle figure dei sovrani, a partire dal 1908, Italia ricompare sulla moneta da una lira e diviene interprete del movimento interventista nella Prima Guerra Mondiale, con la prospettiva di portare a conclusione il processo di unificazione cominciato nel Risorgimento.
Ma al termine del conflitto 1915-18, quando si afferma l’uso di elevare monumenti ai caduti, l’autentico protagonista è il soldato con al suo fianco la Vittoria: raramente ad essa si sostituisce la figura di Italia. Allo stesso modo, durante il periodo fascista, è Roma e il suo mito ad essere fonte di ispirazione e cornice culturale del sottostante nazionalismo.
La stagione politica che si inaugura dopo la liberazione del nazifascismo manifesta un aperto rifiuto dell’abuso di simboli e di retorica, soprattutto a causa della natura popolare dell’Italia nata all’indomani del referendum popolare per la scelta fra monarchia e repubblica. La sua ultima apparizione ufficiale è sulla scheda referendaria, una scelta che ha sollevato non poche obiezioni e discussioni.
Negli anni successivi la sua presenza si dirada, per essere costante solo nella vignettistica, al braccio di politici e vestita con il tricolore.
La ritroviamo in una canzone di Francesco De Gregori del 1979, Viva l’Italia, nella quale, in definitiva, prende vita una nuova versione dell’allegoria della nazione. Con il suo richiamo a valori nazionali e la sua dichiarazione d’amore verso un paese segnato dai lutti del terrorismo – conclude l’autrice –, ha contribuito a trasfondere nell’immaginario collettivo l’immagine di un’Italia che «non ha paura», «che resiste» e il profilo dolcemente materno in una società ormai orfana di padri. (Lidia Gualdoni)
«Il Sole 24 Ore»
27-11-2011
Colpisce, senza dubbio, il fatto che alla Penisola che Dante definirà «giardin dell'Impero» siano da sempre associati, nei processi di trasfigurazione allegorica, i caratteri decisamente (o: tradizionalmente) femminili che, certo, sono abituali anche per tante altre lande per via di classiche associazioni mentali (la terra è madre e nutrice) oltre che per circostanze meramente linguistiche: Italia è, in greco come in latino come in italiano, una parola grammaticalmente femminile. Ma nel caso della fanciulla turrita, queste ragioni si intrecciano inestricabilmente con quelle della storia, della politica, della letteratura. Del costume, anche.
Così, ricorda Bazzano, nella Roma imperiale «la consuetudine di rappresentare Italia con bambini in tenera età risponde anche all'esigenza di compendiare con un'immagine eloquente e sintetica un preciso provvedimento preso dall'imperatore Traiano in favore della gioventù delle città della Penisola». Anche in tal modo si sviluppa, passati i tempi della martellante propaganda augustea, l'immagine dell'Italia mater. Ma saranno soprattutto le vicende della tarda antichità e del Medioevo a conferire alla Penisola – o meglio alle sue raffigurazioni allegoriche e alle sue interpretazioni poetiche – i tratti che ne caratterizzeranno per secoli la condizione. Già «schiava di Roma» nell'iconografia e nella topica degli antichi, dopo la parentesi altomedievale in cui il suo nome è poco più che un flatus vocis privo di vera concretezza geopolitica. Nel basso Medioevo, Italia diviene la vedova abbandonata (dall'impero), il luogo della divisione politica e delle strazianti lotte intestine, insomma la derelitta entità che già fu donna di province e si è tramutata, significativamente, in bordello – con allusione metonimica a una condizione degradata e tipicamente femminile.
Da schiava a vedova, da petrarchesco «bel corpo» trafitto da «piaghe mortali» a fanciulla sedotta e abbandonata dai dominatori stranieri che ne percorrono il territorio: il percorso tracciato da Bazzano interseca naturalmente, ma solo occasionalmente, quello di chi da altre prospettive ha tracciato la storia e le avventure dell'idea civile dell'Italia. Ma l'interesse si rivolge qui prevalentemente all'interfaccia figurativa di questa idea e di queste avventure: Bazzano percorre la Galleria delle carte geografiche del Vaticano, visita la Sala del Mappamondo del Palazzo Farnese di Caprarola, approda alle grandi sintesi dell'immaginario iconografico rinascimentale, come l'Iconologia di Cesare Ripa. Qui l'Italia derelitta e prostrata del tardo Medioevo o della prima età moderna ha ripreso fattezze e dignità di regina: lo scettro in una mano, la cornucopia nell'altra, la fanciulla si è già avviata a quella temporanea riscossa figurativa che la porta, fra Sei e Settecento, a una nuova riconosciuta maternità.
«Madre delle arti», cioè culla privilegiata della cultura europea, Italia si reincarna in una rappresentazione trionfante, divenendo donna «che sconfigge il tempo e che si presenta sovrana della sua storia e del suo passato, ancora pronta ad assolvere un ruolo regale». Come accade nell'allegoria dipinta da Valentin de Boulogne a Villa Lante al Gianicolo, nel 1628. Incuriosisce il pensiero che mentre gli artisti si esercitavano in figure così vigorose, il topos culturale dell'effeminatezza molle e ambigua degli italiani dilagava nelle letteratura di mezza Europa.
Il Risorgimento, fin dalle sue premesse settecentesche, conterà su tutte le sfumature e su tutti i particolari di un'immagine ormai stratificata e multiforme. E consegnerà alla nuova nazione unificata le immagini contraddittorie di fanciulle piangenti eppur aggraziate, come quella che singhiozza sul sepolcro di Vittorio Alfieri a Santa Croce, e quelle di femmine prosperose col volto velato dalla malinconia: è la celeberrima copertina grafica della «Domenica del Corriere» del 25 maggio 1958, in cui una cittadina forse appena uscita da un provino per Cinecittà si avvia mestamente al seggio delle elezioni politiche in cima a una fila composta da impiegati, suore e operai. Corona turrita, peplo tricolore cadente su forme morbide come quelle dell'antica dea-madre Cibele. E una mestizia invincibile dipinta negli occhi: «povera Italia» è l'espressione, già in uso a quel tempo, che dev'essere affiorata alla mente di tanti lettori. (Lorenzo Tomasin)
«Giornale di Brescia»
22-09-2011
«Nel progetto egemonico della tarda repubblica del primo impero – spiega la prof. Nicoletta Bazzano, ricercatrice di Storia moderna alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, e autrice dell'originale saggio Donna Italia –, la Penisola è parte privilegiata dei domini romani, terra generosa di doni. E come madre prolifica è spesso rappresentata».
Italia, o «la terra di Italo», era una piccola parte dell'odierna Calabria, regno di un mitico sovrano. È il nome più fortunato e destinato a durare. Nell'antichità la Penisola assunse diversi nomi, che Virgilio ricorda nell'Eneide: «Enotria la terra di Bacco e degli Enotri, luogo di eterno rinnovamento; Ausonia, la terra del popolo dell'aurora; Saturnia, la terra dell'età dell'oro; Hesperia, la terra delle stelle; Dardania, la terra dei Dardanidi, i discendenti di Dardano fondatore di Troia e Vitelia, la terra dei vitelli». Nel tempo, «la terra di Italo» si ampliò fino a quando «con il nome di Italia si individuò la regione tirrenica tra la Liguria e lo Stretto di Messina. Contemporaneamente si afferma l'idea geografica, viva ancor oggi, che l'Italia corrisponda alla Penisola delimitata dall'arco alpino».
Prof. Bazzano, quali percorsi ha seguito per raccontare questa simbologia attraverso i secoli?
I percorsi sono stati diversi e, come spesso accade, non sempre lineari. Punto di partenza è stata l'immagine femminile proposta da Cesare Ripa nel 1603 nella sua Iconologia, una sorta di album di allegorie, che ebbe uno straordinario successo. A partire da questa immagine ho compiuto un percorso a ritroso, fino all'antichità classica, allorché l'immagine viene codificata, e un cammino in avanti fino ai giorni nostri. Lavorando su un elemento per sua natura sfuggente e mutevole come un simbolo ho dovuto spesso mutare rotta, saltare dalla letteratura alla pittura e alla scultura per poi tornare ancora alla letteratura, e così via, aggiustando continuamente la rotta. Secondo lei, il simbolo dell'Italia nell'immaginario collettivo è ancora efficace? Oggi la figura femminile di Italia non appare simbolicamente efficace; eppure non è casuale che in una canzone d'amore famosissima come Viva l'Italia di Francesco De Gregori appaia questa donna «con gli occhi asciutti nella notte triste»: un'immagine indelebile nell'immaginario collettivo.
La consuetudine di raffigurare l'Italia con bambini in braccio cosa vuole rappresentare?
Italia con bambini per mano o in braccio è essenzialmente immagine classica: figurazione dell'Italia madre di eroi, di cui parla il poeta Virgilio. Fino alla prima età imperiale l'esercito romano era in gran parte costituito da italici e proprio grazie al coraggio di questi Roma riesce a ingrandire i suoi domini. Successivamente Italia non è più rappresentata con bambini. E forse anche questo particolare contribuisce a rendere questa figura meno facile da amare rispetto ad altri simboli della nazione, come il Tricolore o la maglia azzurra della Nazionale di calcio.
Come è stato alimentato da questi simboli il sentimento di Patria?
Nell'età risorgimentale l'immagine femminile di Italia ha contribuito enormemente a suscitare e a coltivare l'idea di Patria: si pensi all'effetto che ebbe sui contemporanei la scultura di Italia piangente sul sepolcro di Vittorio Alfieri, capolavoro di Antonio Canova nella Basilica fiorentina di Santa Croce; o, per fare un altro esempio, alla manzoniana «antica, gentil donna pugnace», che non può sedere al convito delle nazioni europee. Subito dopo l'Unità però tale figura sbiadisce: le vengono preferite le immagini dei padri della patria - Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini, Garibaldi. Inoltre, una precisa scelta politica della dinastia regnante, i Savoia, tende a privilegiare nella propaganda l'immagine realistica dei sovrani, piuttosto che un'allegoria. L'immagine del sovrano doveva divenire familiare ai sudditi attraverso la propaganda.
La sua figura opulenta è sinonimo di prosperità?
Sicuramente la morbidezza delle forme così come gli attributi che donna Italia reca con sé, prima fra tutti la cornucopia traboccante, vuole indicare la ricchezza del suolo della Penisola, la sua generosità. Una ricchezza ottenuta anche con l'aiuto della buona sorte, simboleggiata dalla stella che le risplende sulla fronte: lo «stellone» d'Italia.
Quali sentimenti ispira ancora oggi questo straordinario simbolo, a 150 anni dall'Unità?
La figura femminile di Italia oggi è poco conosciuta e quindi poco amata: impossibile paragonare Italia turrita con la Marianne francese, per esempio. Italia ha una storia che, apparentemente, sembra complessa. Invece è solo stratificata e raffinata, come la nostra secolare cultura, ed è appassionante come le mille diverse vicende storiche che si sono dipanate sulla Penisola: scrivere su «donna Italia» per me ha significato ripercorrere, con una guida speciale, il nostro passato politico e culturale, senza il quale non può esistere alcun futuro, soprattutto in una stagione complessa come l'attuale.
Nel corso dei secoli, la bellissima «donna Italia» dal fascino immutato, è stata insidiata da numerosi conquistatori, ma con il passare del tempo, ha subìto anche l'umiliazione della dimenticanza, come durante il Ventennio fascista, che le preferì una virilità maschia e potente.
La retorica del Ventennio ha molto nuociuto alle successive sorti di Italia quale simbolo della nazione. La ridondanza della retorica di regime durante il fascismo e gli accenti insistiti su un'idea nazionalistica, caratterizzata dall'aggressività verso le altre nazioni, tesa alla realizzazione di un impero di prestigio pari a quello creato da Roma, hanno promosso nel dopoguerra un'eccessiva sobrietà simbolica e un insistito disinteresse per le celebrazioni nazionali. Per molto tempo nell'Italia repubblicana solo la Nazionale di calcio è apparsa in grado di suscitare emozioni patriottiche. Solo – in anni vicini a noi – il presidente della Repubblica Ciampi ha voluto con grande forza restituire dignità al sentimento patriottico, sganciandolo da ogni seduzione di tipo nazionalistico deteriore: il tricolore, che in occasione delle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità è tornato a sventolare ai balconi delle case e nei luoghi più diversi, segna il rinverdirsi di un sentimento nazionale, che per molto tempo è stato trascurato e che oggi si manifesta anche in reazione a forze politiche, come la Lega, che dimostrano forti spinte secessionistiche. (Andrea Grillini)
 Simonetta Greggio
Simonetta Greggio
Dolce Vita 1959-1979
«wuz.it»
06-10-2011
C’è una domanda che serve da filo conduttore nello scorrere degli anni, che affiora esplicita solo a metà libro ma che ci invita a rivedere tutto il passato, fino al presente del 2010, quando don Emanuele sta morendo. “Quand’è che siamo diventati ciechi e sordi?”, chiede il principe. Quand’è che la gente per bene ha fatto come le tre scimmiette che si tappano occhi, orecchie e bocca, per non vedere, non sentire, non parlare? Il presente dei crimini grandi e piccoli, delle leggi ad personam, delle truffe, degli investimenti all’estero, dei buffoni ignoranti e incapaci e delle puttane che sono simbolo di potere e successo, delle notizie in prima pagina che sbandierano squallidi scenari di volgarità, si spiega solo alla luce di un passato che si è voluto ignorare o divulgare sotto falsa prospettiva.
È il ‘caso Montesi’ che dà inizio ad una storia di menzogne e interessi perseguiti senza scrupoli? Nell’aprile del 1953 la ventunenne Wilma Montesi era stata ritrovata morta sulla spiaggia di Torvajanica. Una spiegazione ridicola per la sua morte: ‘sincope dovuta ad un pediluvio’. Quando su un giornale comparve una vignetta satirica in cui l’allusione ad un noto esponente di Democrazia Cristiana era chiarissima, giornalista e direttore del giornale furono querelati.
La narrazione procede a salti nel passato, illuminando scene diverse - elezioni di Pontefici (con retroscene) e ‘incidenti’ sospetti come il caso Mattei, Franca Rame violentata (1973) e Franca Viola che denuncia il suo violentatore rifiutando il matrimonio (1965), gli scandali della marchesa Casati e l’assassinio di Pasolini. La nascita delle Brigate Rosse. Il sequestro dell’avvocato Sossi. Piazza Fontana, 12 dicembre 1969. La loggia P2. Il massacro del Circeo. L’apparire di un nuovo termine nel vocabolario italiano, ‘gambizzare’. Dies irae, 16 marzo 1978, il rapimento di Aldo Moro e quello che c’è dietro il rifiuto di patteggiare. Inframmezzati ai ricordi della storia pubblica d’Italia ci sono quelli della storia privata di don Emanuele, l’amore per la giovane e candida moglie Paola che si toglie la vita (stesso nome della fanciulla simbolo dell’innocenza che chiude il film La dolce vita) e i giochi con persone di entrambi i sessi. Ritornando però sempre al presente, al 2010 - e sembra che Dante abbia appena scritto i versi «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!» Il passato conduce inesorabile al presente, così come dalla domanda iniziale - quando siamo diventati ciechi e sordi? - ne scaturisce ora un’altra: “Dove sono gli eroi, mio Dio? Per quale ideale si può ancora vivere - o morire?”
Si esce turbati dalla lettura del romanzo di Simonetta Greggio, come si uscirebbe turbati dopo aver visto un crudo film realista con un accumulo di fatti su cui non si fanno riflessioni. Tocca a chi legge o a chi vede indugiare e pensare e addossarsi colpe e responsabilità. Una ricca appendice con bibliografia, filmografia e riferimenti musicali accompagna questo libro-romanzo-saggio-storia romanzata degli anni che, come quelli dell’ultimo Gattopardo, sarebbero dovuti essere un balzo verso un avvenire migliore. Dipende da che cosa si intenda per migliore. E per chi sia migliore. (Marilia Piccone)
«Elle»
01-09-2011
Che accoglienza ti aspetti per Dolce Vita in Italia?
Non lo, non so davvero che cosa aspettarmi, di libri sul nostro Paese in Italia ne sono stati scritti tanti, e tanti sono i film, alcuni davvero ottimi. Questo libro l'ho scritto come un ‘dovere’: con i miei amici francesi tante volte abbiamo parlato dell'Italia, e se loro ne conoscono spesso alcuni fatti storici – le BR, Moro, Pasolini – il più delle volte non sanno mettere questi fatti in relazione tra loro. Scrivendo Dolce Vita mi sono accorta che nemmeno io stessa avevo ragionato su cose che mi sembravano scontate, e altre ne ho scoperte con la mia documentalista, Nicoletta Pacetti. Per farla breve, non lo so: i miei fratelli mi dicono che «quelli che sanno non compreranno Dolce Vita, e quelli che non sanno non avranno voglia di sapere». Insomma, sarà una sorpresa.
I tuoi libri precedenti sono centrati sui sentimenti privati, questo affronta la storia e la politica in modo diretto. Perché questa scelta?
Dolce Vita è una delle mie numerose facce. Quando si scrive da tanto, quando si legge moltissimo, non si scrivono e non si leggono solo un certo tipo di cose. lo divoro romanzi, ma leggo anche filosofia, storia, sociologia, biografie... Perfino libri di cucina. Vivi in Francia da quando hai 20 anni e scrivi in francese. Ci racconti come e perché hai deciso di partire?
La mia vita di adolescente e di giovane donna è stato travagliata. Sono scappato di casa a 17 anni, mi sono sposata a 18, mi sono iscritta alla facoltà di lettere, ho chiesto l'annullamento del matrimonio... Dell'Italia adoravo Roma, che però mi stava stretta, e di Milano non avevo voglia. Vicino ma lontano c'era Parigi. Poi tutto è venuto da sè: i primi articoli in francese, i primi libri di viaggio, il primo romanzo...
Scrivere è stato un sogno duro da raggiungere?
Sì, è stato difficile. Molto. Non avevo fiducia in me stessa. Quando si amano Nabokov, Stendhal, Fitzgerald, Dostoevskii è difficile aggiungere anche una sola pagina ai capolavori. Ma poi c'è stato un momento nella mia vita in cui non avevo più nulla da perdere, avendo già perso tutto: l'ho fatto. Disperatamente. Ed è andato bene, subito: per il primo libro ho firmato il contratto con Stock dopo averne scritte solo cento pagine. Un sogno per uno scrittore debuttante.
Stai già lavorando a un altro libro?
Sto sempre lavorando a un altro libro...
(Cristina De Stefano)
 Steven D. Hales
Steven D. Hales
Il gatto e la filosofia
«Famiglia Cristiana»
31-07-2011
Se pensate che dai gatti non si possa imparare nulla; se siete incuriositi da quello che succede nella testolina di questi animali sornioni; se ritenete che l'uomo non c'entri nulla con la filosofia... allora questo libro, originale e più rigoroso di quanto si possa immaginare, fa al caso vostro. Dall'osservazione della loro vita con un gatto, un gruppo di filosofi propone riflessioni che vanno dall'etica all'estetica, alle scienze. (Francesca Melani)
 Pierre Brunet
Pierre Brunet
JAB
«Il Secolo XIX»
08-07-2011
Trovatella abbandonata a tre anni dai genitori spagnoli sulla spiaggia di Tangeri, Julia viene allevata dalla marocchina Najwa, poverissima, che per poterla sfamare acconsente a farla combattere sul ring quando ha appena dodici anni. Questa passione per la boxe le cambierà la vita. Emigrata a Parigi, fra mille avventure e disavventure, diventerà una campionessa. L'autore, oggi cinquantenne, si dedica da anni ad attività umanitarie in giro per il mondo, ma da giovane ha praticato molto le arti marziali, interessandosi anche alla boxe.
Brunet, come ha avuto l'idea di dedicare un romanzo a una boxeuse?
Io sono innanzitutto un appassionato di sport da combattimento. E poi, ma solo poi, uno scrittore. Le arti marziali mi hanno formato più di qualsiasi altra esperienza. Da tempo volevo scrivere un libro su questo stile di vita, ma a darmi l'avvio è stata una personalità travolgente, trovata su un sito internet di boxe. Parlo di Mia St. John, affascinante campionessa mondiale che era stata sposata, aveva un figlio, era divorziata e le si attribuivano relazioni sia con uomini che con donne.
Come la sua protagonista: quindi l'ha presa a modello?
Sì, perché ho pensato che aveva una vita infinitamente più ricca di esperienze della maggior parte delle persone. Ha vissuto come una donna e in un certo senso anche come un uomo. E poi ha affrontato la violenza sul ring. E la sessualità nella vita. Un personaggio così, pensavo, mi consentirà di esprimere al massimo la violenza del mondo, che si cristallizza nella violenza del ring.
Cosa pensa dell'ammissione della boxe femminile alle Olimpiadi di Londra?
E uno sbocco naturale della riappropriazione, da parte delle donne, della loro natura originale. La boxe femminile è molto più esigente di quella maschile, perché non ammette la mediocrità: vedere due cattive pugilatrici che si distruggono è uno spettacolo insopportabile. Ma al suo miglior livello, come quello della boxeuse francese Myriam Lamare, che conosco bene, assume un'intensità eccezionale.
Julia vive, si può dire, in funzione del corpo.
Si tratta soprattutto di un'ossessione personale: il corpo come luogo dove s'incarna il meglio dell'umano, ma anche il peggio, ossia la violenza e la barbarie. Più che una questione di perfezione del corpo, si tratta di percezione attraverso il corpo: si conosce, si ama, si ferisce, prima di tutto con il corpo. Ma io credo che non ci sia vera conoscenza, vera esperienza, se non nell'unione tra corpo e spirito.
Nel romanzo, Julia dice di essere forte grazie alla preghiera e alla quemadura. Che cos'è?
In spagnolo significa bruciatura, è una sensazione forte, intensamente reale, che s'incarna in lei: abbandonata da bambina, per sentire di essere al mondo ha bisogno che la realtà le si confermi attraverso emozioni estreme.
In una vita spregiudicata come quella di Julia, è tuttavia importante la preghiera.
La preghiera è l'espressione vivente del mistero che noi chiamiamo Dio. Mentre la religione è un fenomeno più legato all'identità e alla cultura, la fede è la coscienza intima del mistero insondabile che ciascuno porta in sé, mistero delle origini, del senso della vita, di cosa ci attende.
Il romanzo riguarda anche il tema dell'immigrazione, di costante attualità.
Noi europei dovremmo ricordarci di aver subito, in passato, violenze, barbarie e disperazione, e quindi dovremmo metterci nei panni degli altri, perché gli altri siamo noi, e tutto quello che li riguarda ci coinvolge. (Daniela Pizzagalli)
 Nicole Avril
Nicole Avril
Io, Dora Maar
«Il sole 24 ore»
25-09-2011
Ma quali erano i colpi giusti? In quel gioco sadomasochista si riassumeva perfettamente l'orientamento verso la vita di quella geniale fotografa, intima dei surrealisti e dell'estrema Sinistra. A questa bellezza austera, colta e intelligente, Nicole Avril dedica un commosso monologo, in cui, identificandosi con la musa di Picasso ricostruisce la sua storia dolorosa e densa. Una sfida vinta, malgrado qualche sbavatura e qualche eccesso di interpretazione.
Le unghie delle magnifiche mani di Dora, ricorda un amico dell'artista, Brassaï, erano laccate di rosso. La venticinquenne si arrese senza resistere a Pablo, affascinato dalla scura limpidezza del suo sguardo e dalla note gorgheggianti della sua voce. In quel periodo Picasso si trovava in bilico tra il naufragio del suo matrimonio con un'aristocratica danzatrice dei balletti russi, Olga, e il declino della sua recente relazione con la modesta Marie-Thérèse, che lo amava pur detestando i suoi quadri. Allergico a ogni tipo di rottura, in cui vedeva un preavviso della morte, il pittore era riluttante a troncare definitivamente. Sistemata Marie-Thérèse in un sobborgo, si dedicò alla nuova relazione. Dora stimolava il suo impulso di domarla e di distruggerla, il che non gli impediva di subissare l'altra di lettere infiammate.
Malgrado il successo e le innumerevoli avventure, Picasso era spesso devastato da un'intollerabile sensazione di disastro, in cui la vanità della vita, il terrore di malattie immaginarie e la sensazione di perdere l'ispirazione si mescolavano dolorosamente. La sofferenza scatenata in lui dalla Guerra civile spagnola esacerbò quella ferita interiore. Nel nuovo, grande studio di rue des Grands-Augustins, trovatogli da Dora, Pablo dipinse Guernica, in ricordo della strage perpetrata dai franchisti in quell'anno, 1937.
Per Picasso, le donne si dividevano in due categorie, «dee e pezze da piedi», e godeva sommamente a farle precipitare da una categoria all'altra. «Sei troppo alta, troppo bella, troppo libera», la rimproverava, imbarazzato dalla sua statura. Per indebolirla, la convinse ad abbandonare la fotografia per la pittura, dove lui dominava indiscutibilmente il campo. In quel periodo le due rivali affiorano sovente, insieme o separate, nei quadri dello spagnolo, che si divertiva a ritrarle l'una coi vestiti dell'altra. Gli piaceva umiliare Dora, dandole continui motivi di gelosia. Una volta riuscì persino a esasperarla viziando eccessivamente una scimmietta. Poi cominciò a picchiarla fino a farla svenire. Lei resisteva con «l'adorazione regale della vittima». Divenne la celebre figura piangente di tante tele. «Dora, per me, è sempre stata una donna che piange. Sempre .... È importante, perché le donne sono macchine per soffrire». Durante la guerra, Picasso aveva visto la sua gloria crescere irresistibilmente. Dora capì che il loro tempo era finito.
Inutilmente Paul Éluard, che aveva sempre cercato di proteggerla dalla ferocia dell'uomo che idolatrava, le propose di sposarlo. La rottura con l'amato precipitò la Maar in una grave depressione. Con l'abituale crudeltà, Picasso si divertiva a farle incontrare il suo nuovo amore, la giovanissima Françoise Gilot. Un giorno la costrinse persino a dichiarare, di fronte a «quella scolaretta», che tra loro tutto era finito. Dora reagì con una dolente serie di stravaganze. «Era pazza molto prima di diventare pazza!», sentenziò Pablo. Dopo un vano tentativo di scuoterla con l'elettroshock lo psicanalista Jacques Lacan, medico di Picasso, la prese in cura e riuscì, se non a guarirla, a farla convivere con la malattia. Ormai la Maar vestiva solo di nero e alternava lunghi periodi solitari a rapide incursioni nella mondanità. Convertitasi al cattolicesimo, Dora spiegava agli amici: «Dopo Picasso c'è solo Dio». Nei rari incontri con l'amato cercava di spingerlo alla religione. «Se continuerai a vivere come hai fatto finora, ti cadrà addosso una tremenda sciagura!» Picasso dava la colpa di quegli sfoghi all'irrazionalismo dei surrealisti che, secondo lui, l'aveva spinta verso la follia. «La vita, commentava, è fatta così, elimina automaticamente i disadatti».
Quattro anni dopo la morte di Picasso, Marie-Thérèse si impiccò. Tredici anni dopo Jacqueline, l'ultima compagna, si sparò alla tempia. Dora sopravvisse a Picasso, chiusa nel suo appartamento tra le opere dell'amato, che si era divertito a dipingere sulle pareti una serie di insetti. Riassumendo il loro legame, aveva detto: «Io non sono stata l'amante di Picasso. Lui era soltanto il mio padrone». (Giuseppe Scaraffia)
«Il Piccolo»
02-09-2011
In quella foto, Dora Maar guarda verso l'obiettivo come se, in realtà, scrutasse la vertigine dell'infinito. Una mano, appoggiata sulla testa, diventa la strana cornice di quel volto intenso. Che Picasso scomporrà sulla tela in tutte le maniere possibili. Trasformando la donna che finirà per amarlo tutta la vita, anche quando lui non vorrà più saperne di lei, nel simbolo della passione e della sofferenza. Del tormento e dell'estasi.
Era il 1936 quando Pablo Picasso vide per la prima volta Dora Maar. Lui aveva 54 anni, il mondo si divideva nel giudicare la sua opera: moltissimi lo consideravano l'artista che stava dettando il nuovo alfabeto della pittura contemporanea. Lei era una promettente fotografa di 25 anni. Un'anima inquieta che frequentava intellettuali di gran fascino come Georges Bataille, Paul Eluard, André Breton. E che sembrava cercare un suo centro di gravità permanente. A cui aggrapparsi per resistere alla tentazione di lasciarsi portare via dal fiume della vita.
Non potevano restare lontani, Pablo e Dora. Erano destinati ad amarsi, a distruggersi, a lasciarsi e ritrovarsi. In una danza frenetica di gioia e dolore. Che Nicole Avril, scrittrice e attrice francese che ha dedicato una biografia alla principessa Sissi, racconta in un romanzo intenso e bellissimo: Io, Dora Maar, tradotto da Marco Cavalli.
«L'ho visto alla prima del film Il delitto di Monsieur Lange. Io ero fotografa di scena. Impossibile non notare il suo sguardo. Occhi assassini, scuri e spalancati». Parte da lì il flusso di coscienza di Dora Maar. La confessione senza pudori e senza segreti che squaderna davanti agli occhi del lettore il mondo intimo di una donna affascinante e intelligente. E anche se Nicole Avril avverte «questo libro è un romanzo e io non sono Dora Maar», pagina dopo pagina diventa davvero difficile sottrarsi alla convinzione che sia proprio la fotografa a raccontare il divenire della passione.
Non si poteva vivere accanto a Picasso sperando che fosse «per sempre». Eppure, per Dora era impossibile abituarsi all'idea che, un giorno, il grande artista sarebbe corso dietro un'altra. Com'era successo quando stava con Olga o con Marie Thèrése. Perché lei, la Maar, sentiva dentro di sé che senza Picasso le sue giornate sarebbero state soltanto agonia. Un morire di non morire. Un viaggio solitario verso l'indifferenza per la vita.
E così andò. Perché il Minotauro, il grande artista che tutto divorava per alimentare sempre più il proprio mito, finì davvero per dimenticare quella donna che, per lui, aveva rinunciato a se stessa. E a cui lui aveva dedicato ritratti inarrivabili come quello intitolato proprio Dora Maar, che dipinse nel 1937 e che si trova sulla copertina del libro.
Impossibile resistere alla tentazione di pensare che sia proprio Dora Maar a confessarsi nelle pagine del romanzo. Perché Nicole Avril ha saputo leggere in controluce i segreti dell'anima della fotografa. Emozionandosi e regalando emozioni. (Alessandro Mezzena Lona)
«Gioia»
23-07-2011
«Il Venerdì di Repubblica»
01-07-2011
Sono i ricordi di una donna fuori dal comune, che l'autrice del libro fa parlare, ormai anziana, dopo la morte di Picasso. Erano stati presentati da Paul Eluard nel gennaio del 1936 in un caffé di Parigi. Picasso ha 55 anni ed è già Picasso. Ha lasciato una moglie con un figlio, ha appena avuto una figlia dall'amante Marie-Thérèse, fa impazzire le donne. Dora ha 29 anni, è una pittrice e fotografa stimata, ha aderito all'attività dei surrealisti, che l'apprezzano anche per il suo fascino. «Un giorno arrivò al café con i capelli sciolti che le ricadevano sul viso e sulle spalle, come quelli di un'annegata. I surrealisti gridarono di ammirazione», raccontava Marcel Jean. Il vero nome di Dora era Henriette Theodora Markovitch, nata a Parigi, cresciuta in Argentina, figlia di un architetto croato e di una francese. «Picasso giocava con il mio nome. Mi chiamava Adora, Adora adorata», si legge nel romanzo. E poi: «L'estate del 1936 fu quella della mia vita. Con che coraggio dire che non c'erano ombre, se quella era l'estate del '36?». Perché è l'anno della guerra di Spagna ma anche quello in cui lei entra nella vita di Picasso. Lui la ritrae senza sosta, e le permette di fotografarlo mentre dipinge Guernica. Un giorno nell'atelier piomba Marie-Thérèse. Le due si azzuffano, con grande divertimento di Picasso, a cui piace mettere le sue donne l'una contro l'altra. Anche con Dora esplode il suo sentimento distruttivo. «Dora era una donna che piange, era la sua natura, per questo ho iniziato a dipingerla così», dirà a Malraux. Eppure, ribatte lei dal romanzo, «La donna che piange fu felice in quel periodo». Nel '44 Picasso la lascia per una ventenne. Dora crolla, viene curata da Jacques Lacan, con la psicoanalisi e l'elettroshock. Parla Dora: «Picasso dirà che nessuno era stato così generoso con me. Dora? Potrebbe vivere più di una vita nell'ozio con tutto quello che le ho regalato». Ma Dora non vendette niente. Quando morì, a quasi novant'anni, quei quadri andarono all'asta. E gli insetti e le bestioline che Picasso aveva disegnato per lei sulle pareti erano ancora (Francesca Marani)
 Marco Cavalli
Marco Cavalli
Fogazzaro in tasca
«Avvenire»
23-06-2011
La lampadina è segno di modernità e non deve stupirci se la sua comparsa in un romanzo come Il santo, pubblicato nel 1905, assume un significato non secondario. «Una mano gli si posò sulla fronte, una lampadina elettrica lo abbagliò, un'affettuosa voce forte disse: "Come va?" [...] Allora si sovvenne, levò il termometro. La suora, dietro a lui, reggeva la lampadina elettrica cercando pure di vedere. Egli non discerneva, sulle prime, il grado. [...] Domandò all'ammalato se la luce della lampadina l'offendesse. Benedetto rispose che materialmente non l'offendeva, spiritualmente sì; gli toglieva di vedere per la finestra il cielo, la notte stellata. "Illuminatio mea" diss'egli, dolcemente». (Il santo, cap. 9.2) Antonio Fogazzaro era sensibile ai progressi della scienza e proprio il dibattito intorno alle nuove teorie dell'evoluzionismo lo avevano portato a trovare una conciliazione tra religione e scienza.
E anche il Fogazzaro in tasca di Marco Cavalli, nella sua struttura di essenziale abbecedario «dalla A di Amore alla Z di Zio», ne riprende i temi essenziali parlando di Occultismo e di Scimmie. A fianco dei dilemmi di un pensatore di fronte ai dogmi della religione, che si accompagnano sempre a quelli della scienza, come affermava nel "discorso" Per una nuova scienza del 1897, anche le cose che il progresso rinnova aprono nuovi punti interrogativi intorno all'invisibile. Lo scrittore non si tira indietro e sono proprio gli "elettrobiologisti" a fargli anticipare le problematiche delle neuroscienze. Così il Fogazzaro concludeva il citato discorso: «Vale la pena di farsi chiamar sognatori e raccoglitori di sogni, di affrontare il ridicolo per assider su basi sperimentali una psicologia spiritualista quale i pensatori più potenti del passato l'hanno tratta dal profondo della propria mente e i più grandi poeti dal profondo del proprio cuore.È forse destino che questo edificio sorga e si levi al cielo nel tempo in cui tante tristi rovine morali nell'alto e nel basso accusano di sé il materialismo scientifico, la negazione dello spirito». Negli scritti di Fogazzaro, che lascerà questo mondo proprio nel 1911, non vi sono automobili, ma la fée electricité lo accompagna anche quando Benedetto Maironi «con meraviglia» è introdotto nell'ascensore (elettrico) del commendatore che lo invita ad abbandonare Roma entro tre giorni. (Vittorio Marchis)
«Amedit»
01-06-2011
«Corriere del Veneto»
26-04-2011
 Giuseppe D'Alessandro
Giuseppe D'Alessandro
Bestiario giuridico 1
«www.carlogambesciametapolitics.blogspot.it»
07-06-2012
Ma veniamo a Bestiario giuridico 1. D’Alessandro ha saggiamente scelto la strada del castigat ridendo mores. Benché mostri di subito di (ri)conoscere una verità su cui c’è poco da scherzare. Quale? Che «entrare nel girone infernale della Giustizia italiana costituisce un tale dramma che chi ne fa esperienza non lo scorderà tanto facilmente».
A suo avviso, due sarebbero le cause di una giustizia elefantiaca e spesso ingiusta: la pessima formulazione di leggi e sentenze, nonché l’incontinenza legislativa… Quante sono le leggi in Italia? Secondo l’autore «nessuno è in grado di saperlo, nemmeno in maniera approssimata. Chi dice 250.000, chi 350.000. Nel sito governativo www.semplificazionenormativa.it si afferma che le leggi pubblicate sarebbero addirittura 430.000 ».
Inoltre, la prima causa qualitativa - quella dell’italiano approssimativo - si salda, e in maniera perversa, al «problema quantitativo». D’Alessandro pone giustamente l’accento sulla fitta selva di modifiche, a ogni livello, che di regola prolifera in maniera metastatica intorno a un qualsivoglia articolo di legge, magari all’inizio stringato. Ad esempio, scrive, «uno degli articoli più martoriati (…) è il 34 del codice di procedura penale che si occupa dei casi di incompatibilità del giudice a trattare un processo, dopo che in qualche modo gli sia “passato tra le mani”». Si tratta perciò di un articolo che «meriterebbe l’Oscar delle modifiche », dal momento che «il testo originario dell’art. 34 c.p.p. conteneva 159 parole, il testo modificato dal legislatore ne contiene 340, cioè più del doppio; il testo vigente, comprendente le 18 pronunce di incostituzionalità, ne contiene ben 2470, quasi 22 volte in più del testo originario”» . Insomma, proprio come diceva il saggio Hegel: il Diavolo è sempre nel dettaglio. Il problema però, nel caso della giustizia italiana, è quello di trovarlo il dettaglio…
Dicevamo, castigat ridendo mores. La casistica è veramente ricca e disposta per titoli molto invitanti: si va dal «Sesso e dintorni» al «Sesso senza sesso» fino alle «Liti bagatellari» (titolo, in verità, non proprio invitante…), ossia le liti di scarso rilievo, che però in sede giudiziaria si protraggono per decenni.
Una chicca da «Sesso e dintorni»: la coscia di una signora sembra essere più erotica del sedere… Infatti, se da un lato si condanna un dentista (sentenza 14 dicembre 2001), per il toccamento «subdolo e seppure fugace» della coscia di una paziente, per l’altro, la Corte di Cassazione (Sentenza 25 gennaio 2006 n. 7639) ritiene «il “toccamento dei glutei” non configurare il delitto di violenza sessuale, ma trattarsi di semplice molestia punita ai sensi dell’art. 660 del codice penale (cioè con un’ammenda o, in alternativa, con una pena detentiva molto modesta».
Nei due capitoli finali si discute di «Linguaggio e diritto» e del «Giudice che giudica se stesso». In quest’ultimo capitolo scopriamo che «a volte, i magistrati italiani piuttosto che litigare preferiscono divertirsi tra di loro con cene, gite e scampagnate. Alcuni si sollazzano anche in modi diciamo, eccentrici, come quei due liguri, sottoposti ad accertamento per aver fatto tiro al bersaglio con la rivoltella sui faldoni dei fascicoli archiviati. Forse - si chiede scherzosamente l’autore - volevano essere sicuri che quelle pratiche fossero davvero morte e sepolte, in caso contrario, meritavano il colpo di grazia».
Morale conclusiva? Di grande magnanimità, da antico Principe del Foro: «Alla fine della nostra navigazione - rileva D’Alessandro - fra le leggi strane, sentenze assurde e formule incomprensibili, giova tirare le conclusioni. Tutto male? Tutto da buttare? Giustizia allo sfascio? No, non è proprio così. Nel corso del libro si è ripetuto più volte che la giustizia è lo specchio della realtà, né più né meno. È una considerazione che conviene ribadire in chiusura. La società italiana ha grandi pregi, grandi potenzialità e immense risorse, fatte soprattutto da uomini che quotidianamente si spendono nel loro lavoro per mandare avanti uno Stato che è tra i più civili e progrediti (…). Ogni tanto qualcosa non funziona e qualcuno si prende la briga di raccontarla, come abbiamo fatto noi. Senza cattiveria e malignità, al solo scopo di far riflettere il lettore e magari anche di sollevargli il morale quando, coinvolto in prima persona in vicende giudiziarie tende a credere di essere il solo a patire le “pene dell’inferno”». (Carlo Gambescia)
«www.chronicalibri.it»
01-02-2012
Questo testo ha la caratteristica di avvolgere l’autore in un raffinato clima umoristico, che lascia sorridere di fronte a leggi e sentenze dai contenuti spesso esilaranti. Dimostrazione questa che il diritto non è una campo del sapere arido e sterile, ma piuttosto assolutamente vivo, dinamico e talvolta divertente. Tra le pagine, dunque, prendono voce numerosi esempi della creatività legislativa e giurisprudenziale italiana, tutti elencati con una precisa attenzione dell’autore nella citazione delle fonti giuridiche inserite nell’opera. Non solo, perché Giuseppe D’Alessandro riporta pure le bestialità che in campo normativo affliggono l’ordinamento europeo.
Insomma, questo Bestiario giuridico descrive quali e quanti mostri traggono vita nel panorama della creazione del diritto e della sua applicazione, lasciando intendere tra le righe tuttavia che in molti casi, di fronte alla richiesta di giustizia, il cittadino trova solo la dura ed implacabile legge.
Un libro consigliato a tutti, non solo ai cultori delle materie giuridiche, perché – parafrasando un celebre brocardo latino – il diritto è anima e struttura della società in cui viviamo. (Stefano Billi)
«The Lion»
01-11-2011
Fra i motivi della pubblicazione, diventando rilevante il detto latino «castigat ludendo mores», è un corollario che la lettura sia divertente e costituisca un’intelligente autocritica, la quale potrebbe avere, anche se è azzardato sperarlo, qualche efficacia sul Legislatore e su coloro che sono preposti all’applicazione delle norme. Il saggio è sistematico, inizia con il tema generale, La Legislazione attuale, per poi passare ad argomenti specifici, quali il sesso, il pudore, le liti bagatellari o di poco conto, per concludere con l’analisi della figura del magistrato: Il giudice giudica se stesso. I singoli episodi giustificano il sottotitolo Leggi che fanno ridere e sentenze che fanno piangere dal ridere, e la motivazione fondamentale consiste nella denuncia di leggi fatte male, peggio interpretate. Se è facile sorridere di fronte alla logica, si fa per dire, di qualche sentenza non si esclude una possibile amarezza di fronte ad alcune togate stravaganze interpretative, che, per esempio, possono avere come oggetto contrastanti decisioni in materia di adulterio oppure disinvolte giustificazioni di qualche religioso. Può essere illuminante sapere che la Cassazione non ha ritenuto probatoria la dedica sentimentale apposta su di una fotografia, mentre «è stata ritenuta prova l’avere trovato i presunti amanti a casa di una terza persona intenti a mangiare con in prossimità un letto disfatto». Per continuare, non sembra punibile «fare piedino» e tollerabile che un sacerdote guidi in stato di ebbrezza per il vino delle troppe messe officiate. Una curiosa sentenza non considera punibili le percosse coniugali: «La relazione extraconiugale della moglie rende addebitabile a quest’ultima la separazione e rende, altresì, irrilevante la condotta violenta del marito».
È un testo utile, sconcertante e, ripeto, divertente. Il Lion Giuseppe D’Alessandro, valente avvocato penalista, è relatore in numerosi convegni d’argomento giuridico e collabora con diverse riviste specializzate.
«Liberal»
17-08-2011
Gli italiani si trovano in un alto (e confuso) mare legislativo. Pare che le norme in vigore siano addirittura 430mila. La fonte è del Ministero per la semplificazione normativa, presieduto dal leghista Roberto Calderoli. Solo nel 1999 ci si è accorti che era lievemente fuori tempo «la sfida a duello» prevista dall'art. 341 del Codice Penale. E solo tre anni fa è stata abrogata la prima legge dell'Italia unita, quella «che stabilisce la formula con cui devono essere intestati tutti gli atti in nome del re». Il ministro ha fatto un falò di centinaia di leggi ridicole. Peccato che Calderoli abbia messo nel calderone abrogativo anche la legge del 4 giugno 1944 (regio decreto) che prevedeva la «soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media». E pure il decreto luogotenenziale (primo febbraio 1945) intitolato «Estensione alle donne del diritto di voto». La fretta di bruciare vecchiumi normativi ha fatto sì fosse depennato il decreto (10 agosto 1944) che aboliva la pena di morte. Per fortuna si è rimediato. È scattato un provvedimento (sulla Gezzetta Ufficiale il 14 dicembre 2009) che ha salvato ben 3236 provvedimenti legislativi che non dovevano assolutamente essere cancellati. Quando si dice ‘competenza’! Per fortuna continua a esistere quel testo irrinunciabile che si chiama Costituzione, alla faccia di chi afferma che sia una cartaccia superata.
A condurci per mano in questo guazzabuglio, degno di manzoniana memoria, è Giuseppe D'Alessandro, avvocato di Cassazione, autore di un divertente libro (ci fa ridere, ma anche piangere) intitolato Bestiario giuridico 1. D'Alessandro sostiene, con buone ragioni, che il nostro modo di legiferare è astruso, soprattutto dal dopoguerra in poi. L'uso della lingua è spesso discutibile, va oltre il tanto famigerato burocratese. L'allora ministro Sabino Cassese mise in guardia contro frasi ridicole come «gli sportelli impresenziati» (nella circolare del Ministero dell'Intero del marzo 2008), la «lettera codiciata», la «nota attergata». Eppure c'è la Guida alla redazione dei testi normativi. Si sa tuttavia che gli ignoranti o i presuntuosi paiono godere, sempre, di immunità grammaticale. Piuttosto che andare da un avvocato, converrebbe consultare un linguista (divertendolo) avendo in mano una frase come questa: «somme da scomputare nella fattispecie dell'impossidenza del diritto irrefragabile». Eppure il legislatore ha l'ambizione di spiegare il più possibile. E inutilmente. Una sorta di «imbecillità esplicativa» come suggerisce l'autore del libro. Qualche esempio. Per «passeggero» si intende «una persona diversa dal conducente e dal personale di servizio». Per «porta scorrevole» si intende «una porta che può essere aperta o chiusa unicamente facendola scorrere lungo una o più guide rettilinee o quasi rettilinee». In materia marittima si sente l'esigenza di spiegare chi sia il «comandante», ossia «l'ufficiale che esercita il comando di una nave». Poi ci sono i rompicapo. Ci dovrebbero spiegare perché mai «le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole» (l'articolo del 1991). A proposito di navigazione, mai è stata abrogata una legge del 1939. In base a essa potremmo protestare con la nostra agenzia di viaggi se sulla nave da crociera non ci sono «le sputacchiere», o se il materasso e il guanciale non sono di crine di animale o di lana. L'attenzione diligenza del legislatore talvolta non esiste proprio. Nel 2006 è stato aggiunto un comma a una legge già abrogata un mese prima. È capitato di leggere anche questo: «Le disposizioni dei successivi commi si applicano sulla base di apposita istanza da presentare entro il 31 novembre». Ma quanti giorni ha questo mese?
Consoliamoci sbirciando il ridicolo nel giardino altrui. Pare che in Israele sia proibito portare orsi sulle spiagge, che in Thailandia sia vietato uscire senza mutande, che in Francia sia proibito baciarsi sulle rotaie. Restando nel Paese dei Lumi una vecchia norma, da poco abrogata, vietava alle donne di indossare i pantaloni senza l'autorizzazione del marito. Peccato che li indossano le donne poliziotte, per regolamento. In Arizona è proibito fare sesso in un'auto che abbia una gomma a terra (25 dollari di multa), nell'Illinois si punisce chi offre sigari accesi a cani e gatti. Tornando all'Italia, c'è da sorridere sulle motivazioni di alcune sentenze, in specie se riguardano il comportamento intimo. È ovvio che non si possa baciare una donna contro la sua volontà. Ma c'è anche il «bacio deviato», ossia spostato dalla «vittima» sulla guancia. Distinzione importante visto che la Suprema Corte si è occupata di questa effusione con traiettoria impropria. E se uno il bacio lo richiede? Incappa in un reato? La Corte ha detto no: «È esclusa la sussistenza del reato di molestia in un caso in cui l'agente si era limitato a chiedere, una sola volta, un bacio a una donna, dopo aver detto a quest'ultima che era una bella signora (ottobre 1994)». (Pier Mario Fasanotti)
«Panorama»
20-07-2011
«La Sicilia»
14-07-2011
«La Repubblica ed. Palermo»
10-07-2011
«Linea»
21-06-2011
 Paul Scheuermeier
Paul Scheuermeier
Il Veneto dei contadini 1921-1932
«Padova e il suo territorio»
19-03-2012
È in questo ambiente ancora arretrato – alle soglie della modernità – che, a partire dal 1919, lavoreranno i collaboratori dell'Atlante linguistico italo-svizzero (AIS, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Siidschweiz), diretto dagli svizzeri Karl Jaberg e Jakob Jud, pubblicato in 8 enormi volumi tra il 1928 e il 1940: si tratta di una documentazione capillare dei dialetti attraverso gli oggetti e le tecniche agricole, cioè le cose e le parole per dirle (comprese le varianti di pronuncia della stessa parola), in oltre 400 località italiane e svizzere di lingua italiana, dai villaggi delle Alpi a quelli delle isole maggiori. Il lavoro di inchiesta venne svolto da soli tre ricercatori – Max Leopold Wagner in Sardegna (20 località), Gerhard Rohlfs nel Mezzogiorno (80) e Paul Scheuermeier nel resto del paese, compreso il Veneto (ben 306) – che fornirono la base delle particolari carte geografiche dell'atlante, nelle quali le centinaia di punti numerati corrispondono ognuno a una località dove era stata effettuata un'inchiesta, mentre la singola carta si riferisce a un oggetto o una tecnica, resi nelle diverse parole (o nella pronuncia) dei vani dialetti.
L'importante volume Paul Scheuermeier, Il Veneto dei contadini (1921-1932), a cura di Daniela Perco, Glauco Sanga e Maria Teresa Vigolo, di cui si offre qui una rassegna centrata principalmente sul territorio padovano, raccoglie una articolata serie di scritti e fotografie dell'ultimo linguista citato, che figura perciò, e giustamente, come autore del testo, anche se esso è stato allestito a quasi 40 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1973. Paul Scheuermeier era nato a Winterthur, nel Cantone di Zurigo, nel 1888; laureato in filologia romanza a Zurigo nel 1912, aveva insegnato italiano a Berna dal 1925 al 1958. L'incontro nel 1919 con i curatori dell'atlante linguistico fu decisivo per la sua attività di indagatore e rilevatore che si protrasse fino alla primavera del 1925, percorrendo dapprima le vallate retoromanze svizzere, quindi l'intera Italia settentrionale e l'Istria fino a Fiume, e prolungando le sue interviste fino all'Italia centrale. Tra il 1930 e il 1935 egli compì cinque viaggi supplementari in Italia, in compagnia del pittore Paul Boesch (1889-1969).
Già negli anni Trenta Scheuermeier riprese l'elaborazione dei materiali tanto linguistici che iconografici (le sue fotografie e i disegni e le incisioni di Boesch), raccolti negli anni delle ‘peregrinazioni’ italiane, facendoli confluire nell'opera Bauernwerk in Italien, der italienischen und rätoromanischen Schweiz, pubblicata in due maestosi volumi (1943 e 1956), tradotta nel 1980 con il titolo Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Svizzera italiana e retoromanza: il primo volume contiene 427 disegni e 331 foto, il secondo 495 disegni (alcuni dei disegni di Boesch sono delle splendide xilografie), 542 foto e 13 carte! L'opera si pone come un fondamentale e insostituibile riepilogo, ‘figurato’ e documentario, della vita e del lavoro in agricoltura prima della definitiva scomparsa della ‘civiltà’ contadina, basata sulla famiglia e sul villaggio o paese, in seguito all'industrializzazione dell'attività primaria. Nel 1963 Scheuermeier divenne socio della fiorentina Accademia della Crusca e l'anno seguente fu insignito della laurea honoris causa dell'Università di Berna, alla quale legò la mole dei suoi scritti inediti, assieme ad alcune migliaia di foto; morì a Berna nel 1973.
Dopo la traduzione del Lavoro dei contadini, dal ricco e prezioso giacimento di Berna (almeno 2000 disegni di Boesch e oltre 5000 foto di Rohlfs, Wagner e Scheuermeier) si sono ottenuti numerosi volumi, a partire dal catalogo della mostra di Roma nel 1981 Fotografia e ricerca sul lavoro contadino in Italia (1919-1935), centrati sul materiale riguardante singole regioni italiane.
Il ricco apparato scientifico del Veneto dei contadini allestito dai curatori Perco, Sanga e Vigolo – con apporti dello storico dell'agricoltura D. Gasparini, e dei glottologi M. Maddalon, J. Trumper e A. Zamboni – introduce ed esalta i materiali che conferiscono al volume una complessa e articolata struttura, illuminando il ruolo di dialettologo e folklorista-etnologo svolto da Scheuermeier, ma anche di testimone della vita nel nostro Paese all'indomani della Grande guerra e prima e dopo l'avvento del fascismo.
Il Veneto dei contadini è un libro importante, ma anche affascinante, già al primo approccio, nello sfogliarne le pagine e guardarne le figure, cioè i disegni (circa 70) e le foto in grande formato (circa 150) che restituiscono un mondo scomparso, senza estetismi, ma con notevole gusto compositivo e sicuro intento sistematico, come si vede dall'immagine di copertina, che schiera frontalmente i membri di una famiglia contadina di Istrana (nel 1921) con gli attrezzi esibiti come trofei: basta vedere la adolescente che imbraccia sorridendo la forca a quattro denti! Si potrebbe dire che Scheuermeier allestisce un catalogo enciclopedico della cultura materiale del Veneto contadino, attraverso fotografie che ricordano le tavole dell'Encyclopédie di Diderot e D'Alembert, in cui forma e contenuto, estetica e tecnica si compenetrano (i teorici dell'immagine direbbero che la mise en scène corrisponde a una sorta di mise en valeur).
La messe raccolta in Veneto da Scheuermeier, e presentata nel volume, è divisa tra l'inchiesta più propriamente linguistica del 1921-22, centrata sulle interviste per l'atlante linguistico, e quella del 1930-32, dedicata a un approfondimento di tipo più etnografico, concentrato nel Miranese. Nella prima parte le fotografie sono precedute dal diario godibile e talora commovente di un viaggiatore intento a un particolare Grand Tour, con la cronaca delle giornate spossanti, dei trasferimenti, anche a piedi, da una località all'altra, e della ricerca, spesso frustrata, degli informatori attendibili, con ricchezza di particolari ambientali ed umani, di impressioni e giudizi. Seguono le schede sui singoli informatori, tra il ritratto di tipo narrativo e la scheda segnaletica di polizia, completate dalle fondamentali osservazioni linguistiche.
In appendice, grazie alla traduzione di Carla Gentili, si possono (si devono!) leggere le lettere dell'inviato speciale Scheuermeier ai ‘boss’ Jaberg e Jud con le loro risposte, che completano o riprendono il diario e contengono, tra molto altro, particolari interessanti sulle polemiche e rivalità nell'ambiente scientifico tra Italia (in particolare l'Università di Padova) e Svizzera. Ancora in appendice è riprodotta una serie di cartoline illustrate inviate da Scheuermeier e riempite di notizie, osservazioni, appunti, compresa una cartolina a Jaberg con foto ‘artistica’ del giovane Mussolini, sul retro della quale è scritto: «Padova, 13.1.22 ... nonostante oggi sia venerdì 13, ho cominciato la prima rilevazione dell'anno nuovo a Gambarare [di Mira] con un contadino padre di uno studente di medicina a Padova. Questa mattina le ho spedito le foto dal 559 al 610 [eseguite tra ottobre e dicembre 1921 a Zuel, Pozzale, Teolo, Crespadoro...). Il ritratto di questo fanatico lo può appendere accanto all'altro: gli stessi occhi! Qui continua a splendere il sole in un cielo tutto blu…».
«Partii linguista e ritornai folklorista», confessò molti anni dopo Scheuermeier. Il testo della cartolina da Padova è un campione minimo ma significativo dell'esperienza compiuta nel 1921 dal giovane Scheuermeier (e continuata per oltre dieci anni) e della testimonianza viva che ne possiamo avere grazie ai ‘reperti’ di cui è ricco il volume. Attraverso diari, lettere, cartoline si possono seguire, in una sorta di romanzo di formazione («Alla mia vita manca soltanto che qualcuno ne tragga fuori un romanzo» annotava nel novembre 1921), le avventure italiane di un cavaliere teutonico (cioè svizzero tedesco) negli anni dello scontro più duro tra socialisti e fascisti, alle prese con abitanti della pianura e della montagna venete (i primi, senza terra e senza dignità, secondo Scheuermeier, mentre per i secondi egli usa sempre parole di rispetto e di ammirazione), ma anche con professori permalosi e gelosi delle loro prerogative. La piccola guerra (documentata da Scheuermeier) tra teorici italiani della scientificità e della completezza e linguisti svizzeri praticanti l'arte del possibile finì con la pubblicazione tra le due guerre degli otto volumi dell'AIS, mentre la pubblicazione dell'ALI (Atlante Linguistico Italiano), le cui rilevazioni vennero riprese solo dopo il 1945 e prolungate fino agli anni Sessanta, non è stata ancora completata...
In una lunga lettera del gennaio 1922, sempre a Jaberg e da Padova, sono documentati tanto gli incontri («il prof. Baragioia è stato veramente amichevole e paterno») che le beghe accademiche («Crescivi, da nazionalista convinto, parla molto male della nostra cosa e ritiene di avere solo lui il monopolio sui dialetti veneti»), ma anche l'entusiasmo per il lavoro collettivo ben fatto e l'orgoglio di esserne parte, attraverso una serie di metafore: «Chi osa ancora mettere bocca, demolire, quando ormai una quantità di fatti ben ancorati parlano da soli? Noi abbiamo lavorato nell'ombra e aspettato, ma ora il tesoro comincia a rilucere e a parlare. La verità si svela e trionfa. Deve essere una gioia febbrile comporre insieme questi innumerevoli pezzetti, saggiarli, ordinarli fino a quando si connettono in una chiara, luminosa costruzione a cui il creatore conferisce una bella forma e infonde un significato profondo che illumina sia coloro che danno un primo sguardo a una terra sconosciuta e inesplorata, sia coloro che da singole impressioni confuse improvvisamente s'innalzano a una più vasta comprensione».
Nella città universitaria Scheuermeier alloggia a più riprese tra novembre 1921 e gennaio 1922, spostandosi quotidianamente nelle località delle province padovana (Campo S. Martino, Teolo), vicentina e veneziana, per intervistare lungamente (anche nove ore in un giorno!) i suoi informatori, tornando all'albergo Aquila Nera, da lui battezzato il «Quartier generale», dove l'aveva presentato il libraio Draghi, passando al caffè Pedrocchi per incontrarsi con il germanista Baragiola, frequentando i teatri (dal 9 al 12 gennaio 1922 assiste alle Smanie della villeggiatura e alle Donne gelose di Goldoni e alla Figlia di Torio di D'Annunzio), passeggiando e «assaporando piacevolmente l'atmosfera cittadina».
A dicembre, per circa una settimana, è a Teolo, all'hotel Posta; nel diario sono meticolosamente annotate le ore dei colloqui con l'informatore, mentre lo descrive nella scheda: «Gumiero Andrea, nato nel 1879 ... Da giovane ha fatto tre anni di servizio militare a Torino e poi tutta la guerra. Con aperta soddisfazione ammette di essere sempre stato “imboscato” ... È il tipo del contadino fedele. Semplice, solido, puntuale nel suo lavoro e anche con me. Nonostante sia ancora giovane e abbia abbastanza viaggiato, come tipico contadino dei casali agricoli lontani dal paese e dispersi sul territorio ha mantenuto moltissimo il più antico dialetto, ancora più arcaico di quello parlato dai vecchi nell'osteria del paese ... La sua grande esperienza del lavoro condotto nei modi tradizionali e la sua intelligenza lo hanno reso quasi sempre sicuro e pronto. L'affidabilità delle sue risposte è stata in gran parte confermata da controlli effettuati nei dintorni. Tutte le sue conoscenze pratiche provengono dalla sua esperienza diretta». A queste ‘caratteristiche’ seguono le ‘osservazioni fonetiche’ che si soffermano, tra l'altro, sulla pronuncia di e a Teolo, «specialmente quando il parlare è veloce e molto fluido», così «mentre giocano a carte, da lontano si sente ty ápa ty ápa! … un suono la cui notazione mi fa faticare molto perché è incerto, perché non lascia sempre la stessa impressione sul mio udito». Come non comprendere la difficoltà del giovane ‘inquisitore’, armato di penna e quaderno (senza registratore!), alle prese con lo stretto vernacolo euganeo nord-occidentale sparato da accaniti giocatori di briscola, che si gridano reciprocamente ciapa! in una fumosa osteria?
Alla fine del ciclo di rilevazioni, un vero tour de force giornaliero «dalle 8.30 alle 12 e dall'una e mezza alle 6», il 12 dicembre si permette una mezza giornata di vacanza, e il rendiconto che trascrive è perfetto nella sintesi descrittiva spaziotemporale, nell'associazione tra lo squarcio di paesaggio, la stagione e la luce del momento: «Rilevazione finale dalle 8.30 alle 11. Subito dopo pranzo partenza con l'informatore verso il Monte Venda. Dopo 2 ore di marcia, splendida vista sulle colline e sulla pianura tutt'intorno. Oltrepassata la collina, discesa verso Arquà e visita alla casa e alla tomba di Petrarca. Una quiete d'incanto sovrasta la villa semplice e bella, circondata da cipressi e olivi e da una vista mirabile! Il ritorno si compie nella luce dorata del tramonto e nel chiaro di luna, tra i cespugli e i sentieri che risalgono la collina e scendono a Castelnuovo. Qui ceniamo tutti insieme, i miei della locanda, il parroco e alcuni uomini di Teolo: polenta e baccalà. Verso mezzanotte a casa».
Pochi giorni dopo, nel Vicentino, è di tutt'altro umore mentre prende nota dei cambiamenti sociopolitici e dei problemi del dopoguerra: «19 dicembre ... Vengo a sapere che Piovene è un centro industriale pieno di fabbriche e di comunisti: inutile andare. Seguendo alcune indicazioni avute in treno, vado a piedi in mezz'ora fino a Velo d'Astico, luogo pieno di romanticismo dove Fogazzaro passava l'estate nella sua villa. Che delusione! Nel paese ricostruito per metà trovo ubriachi sparsi tra le rovine». Dopo il resoconto di un'escursione solitaria del camminatore svizzero, che si ritempra nella fatica fisica a contatto con la natura, ritorna lo scienziato calvinista che prova orrore per lo spreco del tempo cui deve sottostare: «20 dicembre … Sveglia alle 5. Arrivo prima delle 6 a Barcarola in corriera e di qui a piedi, sotto la luna, inizio la salita all'altipiano di Tonezza. ll pallido chiarore lunare rende visibili le nere pareti rocciose e i boschi bruciati nei dirupi scoscesi. All'alba sono all'albergo Belvedere … subito dopo arriva l'oste appena rientrato dalla caccia. Nonostante il prevedibile disagio di una rilevazione fatta all'interno di una stube d'osteria, sarà lui il mio informatore, l'ho accettato con gratitudine vista la mia disperazione. Cominciamo la rilevazione all'una e mezzo fino alle 6.30. Poi devo assistere, inerme, allo spettacolo dell'informatore che gioca a carte tutta le serata, mentre l'orologio batte le ore».
Queste e altre numerose pagine di diario o brani di lettere di Scheuermeier ai committenti dell'atlante, del quale egli riempiva giorno dopo giorno, con pazienza e competenza, alcune caselle per le grandi tavole di ‘cartografia parlata’, ci confermano nell'intuizione di uno sguardo oggettivo sulla vita italiana, non solo popolare, e di una lettura in chiave socioculturale, se non antropologica. Cosa si può aggiungere a questa disincantata riflessione del giovane ricercatore, dopo sei mesi di soggiorno italiano, nel novembre 1921, se non che il ‘genio italico’ è restato fedele a se stesso? «Ora, secondo le usanze locali, ho imparato a vivere alla giornata e a pensare, come qui è normale, che là dove c'è un muro, ci deve essere anche una fessura. Ma in fondo al mio cuore svizzero mi mandano in bestia tutte le maledette e immancabili porcherie». (Luciano Morbiato)
«Terra»
03-05-2011
La ricerca linguistica è perseguita con metodo e tecnica: il trentenne studioso svizzero dispone infatti di un questionario che sottopone per la stesura alle persone che incontra e agli informatori per sapere ad esempio il termine usato durante certi lavori in campagna. Paul Scheuermeier è acuto osservatore e non lesina opinioni quando deve giudicare il lavoro degli informatori. Di quello incontrato ad Istrana scrive: «È pieno di buona volontà e di allegria ma è superficiale, impreciso, non serio e nemmeno particolarmente intelligente. Si rende conto delle mie incertezze e si accorge della mia insoddisfazione». Ma come trova gli informatori per la sue ricerche il nostro ‘inviato’ svizzero nel Veneto post-guerra? I parroci sono le persone che spesso fanno al suo caso anche se i consigli non vanno sempre a buon fine come avvenne a Campo San Martino. La persona indicata viene descritta certamente mansueta in cui però è totale la mancanza di preparazione scolastica. Significativi anche i luoghi in cui Paul Scheuermeier annota i propri pensieri e i risultati delle giornate di lavoro: «Scrivo in una stalla tra 9 bestie principali che mi lanciano contro "boasse" e innumerevoli nipoti tra i 4 e 8 anni, che si avvicendano continuamente, rampolli dei 16 figli del 76enne informatore. Un contadino intelligente, sveglio, carattere tenace di montanaro».
Ecco quindi che il lavoro del linguista svizzero realizzato per l'Atlante linguistico italo svizzero offre nel suo insieme una straordinaria testimonianza di come è il Veneto rurale negli anni Venti. Paul Scheuermier ci mostra una realtà contadina ricca di vocaboli e parole dette in un mondo in trasformazione: la meccanizzazione dell’agricoltura è avviata attraverso i primi interventi risarcitori dello Stato alle popolazioni colpite dalla guerra. La documentazione raccolta dall’inviato svizzero è straordinaria. Il materiale è presso l’Università di Berna ma oggi è disponibile anche in italiano attraverso il libro Paul Scheuermeir, Il Veneto dei contadini 1921-1932. Saggi di studiosi, linguisti e antropologi arricchiscono il volume. Bellissime le foto dello stesso Paul Scheuermeier che parlano da sole e raccontano un mondo che non c’è più e che forse è stato troppo presto dimenticato. (Nic Perle)
«Il Gazzettino illustrato»
01-05-2011
«Il Gazzettino»
07-04-2011
È eccezionale la raccolta di testimonianze del Veneto nel primo dopoguerra prodotta da Scheuermeier, importante il suo diario (un salto a Venezia nel momento libero in cui ammira le belle veneziane), le cartoline. Un tempo ormai svanito di contadini e dialetti, di lavoro basato sulla manualità. Il libro è un’occasione storica, socio linguistica, per capire quei tempi, quel tipo di vita, i dialetti con parole o accenti molto diversi in paesi pur vicini. La ricerca era cominciata nell’ambito dell’Atlante Italo Svizzero e a Scheuermeier fu assegnato il compito di scoprire il Veneto, documentarlo, fotografarlo, sotto la guida dei maestri Jaberg e Jud. Lo fece con grande perizia, «un eroe della ricerca» come è stato definito; attentissimo osservatore, «annotò con gustosa ironia», tracciò con grande umanità i profili degli informatori. La pubblicazione, sostenuta dalla Regione Veneto e dalla Fondazione Cini, è ritenuta unanimemente illuminante. (Maria Teresa Secondi)
«Il Gazzettino»
05-04-2011
«Corriere del Veneto»
03-04-2011
L’opera fu realizzata, tra la prima e la seconda Guerra mondiale, sotto la direzione di due linguisti svizzeri, Karl Jaberg e Jakob Jud, che sguinzagliarono attraverso tutto lo stivale un’efficientissima équipe di rilevatori armati di carta e penna. Un lavoro titanico, che difficilmente – occorre dirlo – sarebbe stato portato a termine da un’analoga équipe sotto la guida italiana, e che impegnò una squadra di giovani tra i quali sarebbero emersi alcuni tra i più grandi dialettologi ed etnografi dei decenni successivi. Raccogliendo casa per casa (letteralmente: e si pensi che cosa significasse all’epoca girare da stranieri attraverso le campagne di un’Italia povera, arretrata e devastata dalla Grande Guerra) le informazioni di cui avevano bisogno, i cercatori dell’AIS si cimentarono più che in un lavoro, in un’avventura. Alcuni incontrarono anche l’amore, come capitò allo zurighese Paul Scheuermeier, nato nel 1888, che condusse parte del suo viaggio in Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto) assieme a due compagne inseparabili: la sua futura moglie e la sua macchina fotografica, con cui documentò i luoghi in cui lo spedivano i due direttori della ricerca (ai quali succederà nella direzione e nel completamento dell’impresa). Foto, disegni e appunti di Scheuermeier, rimasti archiviati a Berna, vengono finalmente pubblicati negli ultimi anni, la Fondazione Cini, la Regione e l’editore Colla hanno dato alle stampe un volume Il Veneto dei contadini 1921-1932, che raccoglie la parte migliore delle immagini e dei testi relativi alle nostre campagne.
Le foto di Scheuermeier, accompagnate dalla precisa indicazione del luogo e dell’ora in cui furono scattate, regalano a chi le guarda una vera emozione; in chi, poi, conosce i luoghi ritratti l’emozione può trasformarsi in commozione, sia che li si ricordi in una fase anteriore a quella odierna, sia che – come chi scrive – non si conosca quel mondo, quelle persone e quegli oggetti se non attraverso racconti e testimonianze indirette. È difficile spiegare perché sia tanto suggestivo ritrovarsi, grazie a una foto scattata in una stradina di Cencenighe alle tre di pomeriggio del 17 novembre 1921, davanti a una ragazza (età apparente: vent’anni, ma considerato quanto velocemente s’invecchiava allora, saranno stati quindici) che porta sulla spalla il bilanciere – thampedon, nel dialetto del luogo – con dietro il secchio di rame e davanti la sécia di lamiera. Accanto a lei, su una scala di pietra pulitissima (come pulita è la strada di sassi, sulla quale poggiano i suoi zoccoli di pelle chiodati), una zàngola (pégna), un pestello (thamaton), un càndol e un quèrcol di lamiera, un mastello per il latte o per il burro (galéda), un grosso coperchio di legno col suo cadenath, per la chiusura ermetica. Ti par di toccarli: sono cose umili, oggi perdute. Come perduto è il girello, tutto di legno, in cui si muove una bambina con la cuffia in testa, scortata dalla madre e osservata da due fratellini: Mirano, 3 ottobre 1931. E poi Arabba, dove i contadini dormono ancora nelle baracche dopo le distruzioni belliche; Cavarzere, dove si brinda davanti a un fiasco di vino. Cerea, dove due ragazze lavano i panni in un fosso: sono le nove e mezza del 3 aprile 1921. Mia nonna aveva undici anni, e viveva lì vicino. Forse quelle lenzuola sono le sue. (Lorenzo Tomasin)
 Autori Vari
Autori Vari
Otto racconti per il Millennio
«Ladomenicadivicenza.it»
19-03-2011
Il libro si apre con La mano aperta, della scrittrice cubana Zoé Valdés. L'obiettivo di sviluppo n. 1 (Eliminare la povertà estrema e la fame) viene illustrato tramite il viaggio di una reporter-documentarista cubana attraverso le strade di Port-au-Prince, capitale di Haiti. La povertà e la miseria, viste da vicino, assumono un significato nuovo e inatteso: anche nelle condizioni più estreme esiste una dignità che dà la forza di superare la fame e le violenze di ogni giorno. Una situazione, quella di Haiti, destinata drammaticamente a peggiorare di lì a due anni (il racconto fu scritto nel 2008, N.d.R.) con il terremoto abbattutosi sull'isola nel gennaio 2010.
In Scuola chiusa causa genocidio, lo svedese Björn Larsson racconta con crudo realismo le vicende di Mamadou, giovane ragazzo del Ruanda, sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia nel genocidio che, tra aprile e luglio 1994, contrappose le etnie hutu e tutsi. Mamadou, assetato di conoscenza, cerca di entrare clandestinamente in Europa: il miraggio di un'istruzione e di una vita ‘normale’ si infrangono però contro un muro di incomprensione e burocrazia. Il finale aperto offre un'amara considerazione sul destino di molte ‘gioventù negate’, private della spensieratezza, della famiglia e di un'adeguata formazione scolastica (punto centrale, quest'ultimo, dell'obiettivo n. 2).
L'uguaglianza tra uomo e donna (obiettivo n. 3) è il tema del terzo racconto, Come foglie morte, opera della bangladese Taslima Nasreen. La quindicenne Anguri vive con la madre nel piccolo villaggio bengalese di Rasulpur. La sua esistenza è irrimediabilmente segnata dalla miseria materiale e umana: nella cultura popolare di quei luoghi, la donna non può avanzare alcun diritto e alcuna aspirazione; l'unica possibilità di riscatto dalla povertà è unicamente legata al matrimonio («Se la fai sposare avrà di che mangiare e di che vestirsi»). Anguri è una ragazzina intelligente e spregiudicata, per questo mal sopporta la serena rassegnazione con cui la madre accetta l'ingiustizia; il duro confronto con la realtà e con gli abusi intellettuali e sessuali degli uomini la fanno però crescere rapidamente, spingendola ad allontanarsi dal suo piccolo villaggio. L'occasione di una rivalsa alla fine arriverà, ma a quale prezzo?
Il quarto racconto, I giorni senza sole di Moussa Konaté, affronta il tema della mortalità infantile. La storia, pur nella sua brevità, narra il disagio e la crescente frustrazione di Badji, nobile decaduto che non riesce a procurarsi il denaro necessario per curare il figlioletto malato Sibiri. Un'alternanza di orgoglio, disperazione e rabbia accompagna l'uomo nella strada verso casa: la vista del piccolo Sibiri lo farà ritornare alla consueta e sconsolata rassegnazione, nella quale «è inutile farsi domande alle quali non c'è risposta».
Hafia, protagonista della quinta novella (opera della scrittrice libanese Vénus Khoury-Ghata), è una ragazza che proviene da un villaggio del Sud del Libano, così povero che perfino le cavallette, alla sua vista, tornavano indietro. Hafia ha 16 anni e lavora come collaboratrice domestica a casa di una benestante signora di Beirut; tra loro s'instaura un buon rapporto, anche se la ragazza mantiene un atteggiamento misterioso e taciturno. Un'improvvisa gravidanza di Hafia fa precipitare la situazione: la madre della ragazza si presenta al cospetto della ‘padrona’, accusandola di avere corrotto la purezza della figlia, mentre i suoi fratelli sono disposti ad ucciderla pur di mantenere l'onore della famiglia. Un grave episodio di febbre puerperale fa riavvicinare la giovane ragazza alla sua padrona, che accetta di prendersi cura di lei: la donna scoprirà così il terribile segreto di Hafia che, sentendo in lei il peso della colpa, decide di abbandonarsi al suo destino. La tematica del quinto obiettivo (Migliorare la salute materna), si intreccia con l'uguaglianza tra uomo e donna (punto 3).
L'elaborazione di un lutto è il punto di partenza per una presa di coscienza sulla malattia ne Le zanne del lupo, di Philippe Besson. La perdita di una persona cara porta il protagonista ad abbandonare i suoi legami col passato cercando un rifugio lontano: la malattia e la sofferenza tuttavia sono mali universali, e il raggiungimento di questa consapevolezza lo porterà a vivere la condivisione del dolore sotto una nuova luce. Anche in questo caso, il punto 6 del programma (Combattere l'AIDS, la malaria e altre malattie) si ricongiunge alle tematiche dei racconti precedenti (in particolare a I giorni senza sole).
Un'insolita vena di umorismo macabro percorre il racconto di Simonetta Greggio, Tutti i cani tristi. L'ambientazione francese, a cavallo tra Parigi e la Costa Azzurra, e la caratterizzazione dei due protagonisti, Paul e Julie, si discostano notevolmente dalle altre novelle: qui si parla di due personaggi ‘vincenti’, apparentemente invulnerabili dai fantasmi del degrado e della miseria. La bizzarra sventura che vede Paul confrontarsi con i suoi cari defunti cela tuttavia, dietro il senso del grottesco, una inquietante riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente: anche la terra può non volere più i suoi figli.
L'ottavo e ultimo racconto costituisce una summa di tutti gli argomenti trattati nei capitoli precedenti. L'autore, Alain Mabanckou, gioca con l'autoreferenzialità della narrazione (l'azione si svolge durante una conferenza dove si discute degli Otto punti del programma ONU) per riportare la discussione in una scala più ampia, dal respiro internazionale. «Cosa possono fare i Paesi dell'Occidente per aiutare le popolazioni in crisi?»: questa è la domanda attorno alla quale s'impernia il dibattito. Non mancano le voci critiche: c'è infatti chi accusa la corruzione e la vulnerabilità dei potenti come cause ineluttabili dell'immobilismo economico nei paesi sottosviluppati. La conclusione lascia però al lettore uno sguardo fiducioso sul futuro: un mondo in rapida evoluzione rende ancora possibile la speranza di un nuovo sviluppo economico e umano.
La pubblicazione termina con un breve profilo biografico degli autori e con l'enunciazione per esteso degli Otto punti programmatici che costituiscono il filo conduttore dell'opera. La traduzione, a cura di Monica Capuani, restituisce a pieno la scorrevolezza narrativa dei racconti, nei quali la forma non cede alla tentazione dei virtuosismi letterari, ma conserva un solido realismo a tratti sconvolgente (in particolare nelle descrizioni delle scene di violenza).
Si tratta di un libro, in buona sostanza, che si offre alla lettura al riparo da eccessi retorici, portando il lettore ad uscire dalla sua distratta indifferenza e a non considerare più i luoghi della miseria umana come anonimi villaggi dispersi nel cuore dell'Africa o dell'Asia. (Tommaso Marcato)
 Sarah Kaminsky
Sarah Kaminsky
Adolfo Kaminsky. Una vita da falsario
«La Repubblica»
22-04-2012
La sorprendente storia di Kaminsky comincia nel furore della Seconda guerra mondiale. Nel 1942, a diciassette anni, è uno dei tanti che in Francia sono costretti a nascondersi per sfuggire alle retate dei nazisti. La sua è una famiglia di ebrei russi, emigrati in Francia all'inizio del secolo e poi espulsi nel 1917, finiti in Argentina, da dove rientreranno a Parigi all'inizio degli anni Trenta, ritrovandosi però in trappola quando i tedeschi occupano il paese. All'inizio della guerra, il giovane Adolfo ha solo un diploma di scuola elementare, ma studia la chimica da autodidatta e intanto lavora come apprendista tintore. Per procurare documenti falsi ai suoi familiari, entra in contatto con un gruppo della Resistenza ebraica, proponendo le sue competenze nel campo degli smacchiatori. E così che in poco tempo diventa «il tecnico», uno dei migliori falsari della Resistenza: «Sono nato e cresciuto nel rispetto della legge, quindi la prima volta che ho falsificato un documento, sebbene fosse per una causa giustissima, ho provato un enorme senso di colpa».
Nel laboratorio clandestino di rue des Saints Pères, mentre fuori la caccia agli ebrei si fa sempre più feroce, il giovanissimo falsario fabbrica documenti di ogni tipo. Passaporti, carte d'identità, tessere annonarie, certificati di nascita e di battesimo: «La gente da mettere in salvo era moltissima e a ciascuno dovevamo fornire più documenti per ricostruire un'intera identità. Avevamo tantissime domande ed eravamo sempre con l'acqua alla gola». Una volta, in soli tre giorni fabbricai novecento documenti per mettere in salvo trecento bambini ebrei. Impresa per cui nel dopoguerra verrà ufficialmente decorato. «Ma il merito non fu certo solo mio, eravamo in molti a darci da fare», si schermisce lui con modestia. «Conoscevo la chimica, ma anche la fotografia, la pittura, il disegno e la calligrafia. Tutto ciò mi ha permesso d'inventare nuove tecniche di falsificazione. E soprattutto ero convinto che tutto fosse possibile. Se qualcuno avevo fatto qualcosa, non c'era ragione perché io non fossi capace di rifarla. Quindi qualsiasi documento era riproducibile, anche i passaporti tedeschi».
Quella vita frenetica e clandestina naturalmente era molto rischiosa e più di una volta Kaminsky si salva per un soffio: «Il pericolo era quotidiano, ma in quanto ebreo ero più protetto facendo documenti falsi per la Resistenza che vivendo nascosto in una tintoria. Nell'azione c'è maggiore possibilità di salvarsi, anche se purtroppo in quegli anni ho perso molti amici ammirevoli. È un miracolo che sia ancora vivo. Forse ho avuto la fortuna di non commettere errori e poi sono sempre stato molto protetto. Ci sono persone che anche sotto tortura non mi hanno mai denunciato».
Alla liberazione di Parigi entra nei servizi segreti dell'esercito francese, dove continua a fare documenti falsi per gli agenti paracadutati dietro le linee tedesche. Nel dopoguerra però, quando i francesi iniziano a impantanarsi nella guerra d'Indocina, lascia l'esercito per coerenza con le sue convinzioni pacifiste. Oltretutto, in quel periodo inizia ad aiutare gli ebrei desiderosi di stabilirsi in Palestina nonostante il divieto degli inglesi: «All'inizio volevo andarci anch'io, ma rinunciai quando, con la nascita d'Israele, la religione divenne di Stato. Non sono credente e sono stato educato al di fuori di ogni religione. Per me, quindi, la fede è sempre stata solo un fatto privato». Il falsario però non smette di lavorare. Negli anni Cinquanta entra in contatto con il gruppo di Francis Jeanson che appoggia l'Fln nella lotta per l'indipendenza dell'Algeria: «Impegnarmi al fianco degli algerini è stato naturale come lo era stato difendere gli ebrei. Non ci sono razzismi cattivi e razzismi buoni. Gli uomini sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi diritti, indipendentemente dalla religione, dalla razza e dal colore della pelle».
Per sfuggire alla caccia della polizia francese, Kaminsky è costretto a nascondersi per due anni in Belgio, dove lavora giorno e notte, aiutando centinaia di militanti. «Nessuno è mai stato arrestato per via dei miei passaporti falsi, i poliziotti non li hanno mai scoperti, neanche gli svizzeri che consideravano i loro passaporti infalsificabili», dice oggi con una punta d'orgoglio. E non a caso in quegli anni la sua fama non smette di crescere. Alla sua porta bussano rivoluzionari di ogni latitudine, esuli in fuga dalle prigioni di Salazar, dissidenti della primavera di Praga. A tutti fornisce nuove identità sempre gratuitamente, dato che non ha mai voluto essere scambiato per un mercenario. Tra i tanti che gli chiesero aiuto ci fu anche Giangiacomo Feltrinelli, di cui si ricorda ancora bene: «In passato aveva aiutato l'Fln durante gli anni della guerra d'Algeria, aveva offerto finanziamenti ma anche aiutato materialmente, come quando nascose in Italia alcune militanti evase dalle prigioni francesi». Kaminsky racconta di avergli fatto dei documenti falsi e gli procurò un alloggio a Parigi da un amico pittore. Come faceva spesso con i militanti di altri paesi, insegnò all'editore italiano alcune tecniche di falsificazione perché potesse essere indipendente: «Era un buon allievo. Un uomo gentile e simpatico, ma con un carattere un po' autoritario. Infatti abbiamo anche litigato, perché pretendeva che fossi a sua completa disposizione. Ma io non potevo certo lavorare solo per lui. Finito il periodo di formazione, è ripartito per l'Italia e non l'ho mai più rivisto. Quando mi giunse la notizia della sua morte, avevo ormai smesso di fare il falsario».
Tra i molti che si avvalsero del suo talento ci fu anche Daniel Cohn-Bendit, all'epoca leader studentesco del maggio '68 espulso dalla Francia, a cui fornì un nuovo passaporto per poter rientrare a Parigi sotto falso nome: «Pur non essendo, come i miei clienti abituali, un rivoluzionario in fuga dalle dittature, l'ho aiutato lo stesso per sbeffeggiare le autorità francesi che non avevano alcun diritto di vietargli l'ingresso nel paese. Non era certo un pericolo pubblico né un terrorista». Terrorismo, una parola che a Kaminsky non piace. Proprio l'incombere della violenza lo spingerà a interrompere la sua attività e a ritirarsi in Algeria, dove resterà una decina d'anni: «Io sono sempre stato un non violento e non volevo avere nulla a che fare con il terrorismo. E invece sempre più spesso tentavano di rivolgersi a me giovani con uno spiccato gusto per le armi che non erano certo dei perseguitati politici. Così decisi di smettere».
Da allora Kaminsky non ha più fatto un solo passaporto falso. Senza rimpianti. E oggi, dopo tante avventure, si gode una vita tranquilla, guardando incredulo questi nostri tempi dove «c'è chi – i sans papiers – a causa della mancanza di documenti in regola viene trattato come uno schiavo». A loro però i suoi passaporti non servirebbero perché «con i documenti falsi non si costruisce una vita, si può solo attraversare una frontiera o nascondersi». Parola di uno che se ne intende. (Fabio Gambaro)
«Corriere della Sera»
17-09-2011
È stata lei, attrice e sceneggiatrice nata in Algeria nel 1979, quando l'attività del padre era finita da qualche anno, a costringerlo a raccontare. «Quando è nato mio figlio ho capito che avevo bisogno che quella storia, di cui io stessa avevo solo pochi indizi, diventasse nota. Dovevo costringerlo a farlo, prima che fosse troppo tardi». Così la doppia vita del falsario del bene è diventato un libro, scritto proprio da Sarah, Adolfo Kaminsky. Una vita da falsario. Sarah viene a sapere che suo padre, un uomo che ha soltanto la licenza elementare, impara l'arte della contraffazione in un negozio di tinture. Per mantenersi fa il fotografo in Francia mentre in Algeria, dove ha conosciuto sua madre, diventa maestro di strada e si occupa del reinserimento di giovani detenuti.
«Per due anni l'ho braccato – dice Sarah – scalfendo la sua naturale ritrosia, ho rintracciato i vecchi compagni ancora vivi della rete clandestina per cui lavorava, sono andata in America per incontrare anche il suo grande amore, Sarah Elizabeth, che lui avrebbe dovuto raggiungere e che non ha mai saputo perché non lo avesse fatto». Così Sarah viene a sapere che, a 18 anni, nel '43, suo padre entra nella Resistenza francese e inizia a falsificare i documenti di migliaia di ebrei («ne fabbricavo trenta all'ora», racconta), nel '47 aiuta l'emigrazione clandestina in Israele, ma anche quando tutti i suoi amici partono lui si rifiuta di raggiungerli («Avevo immaginato un Paese solidale, collettivista e soprattutto laico, e non sopportavo che il nuovo Stato scegliesse di fondarsi sulla religione e l'individualismo»), nel '57 costruisce identità fittizie per i militanti della guerra di liberazione algerina. E poi, via via, documenti falsi per gli oppositori di Franco in Spagna, di Salazar in Portogallo, dei colonnelli in Grecia, tanto che nel '67 garantiva identità false a combattenti di quindici Paesi diversi. Perché nel '44 aveva imparato una lezione: «Che la libertà può essere ottenuta anche con la determinazione e il coraggio di un pugno di uomini». (Cristina Taglietti)
«Bresciaoggi»
10-08-2011
A 17 anni Adolfo Kaminsky diventa il maggior esperto in documenti falsi della Resistenza a Parigi. Grazie a lui migliaia di ebrei riusciranno a sfuggire alle retate e centinaia di partigiani potranno continuare la loro attività nella guerra di liberazione. «Restare sveglio. Il più a lungo possibile. Lottare contro il sonno», ripete. «Il conto è presto fatto. In un'ora io fabbrico trenta falsi documenti. Se dormo un'ora, muoiono trenta persone...». Il libro è impreziosito da belle fotografie, scattate tra il 1944 e il 1960, in cui lo vediamo autoritratto in pose simpatiche o concentrato al lavoro nei suoi laboratori di rue d'Ecosse, di rue Jacob, di rue des Jeuneurs, tra presse litografiche a manovella e proiettori fotografici. Per trent'anni, unendo la passione per la chimica e l'amore per la giustizia, ha seguito il meticoloso lavoro di falsario in favore di numerose cause, anche in apparenza contraddittorie, quali l'emigrazione clandestina verso Israele dei superstiti dei campi di concentramento dal 1946 al '48, il sostegno al Fln nella Guerra d'indipendenza algerina sul finire degli anni '50, le lotte rivoluzionarie nell'America del Sud, l'opposizione alle dittature di Franco, di Salazar e dei Colonnelli greci e, infine, le guerre di decolonizzazione in Africa durante gli anni '60, sempre rifiutando di essere pagato e finanziando le proprie attività lavorando come fotografo. Nel 1971 Adolfo Kaminsky cessò la propria attività clandestina al servizio dei giusti e decise di regalarsi una nuova vita; si trasferì in Algeria e dopo qualche anno nacque la figlia Sarah. (Flavia Marani)
«www.sherwood.it»
07-05-2011
Adolfo Kaminsky, classe 1925, nasce a Buenos Aires da genitori ebrei russi. Per tutta la prima metà del Novecento la storia della sua famiglia, simile a quella di molte altre famiglie ebree dell'Europa dell'Est, è segnata da continui spostamenti alla ricerca di migliori condizioni di vita. Nel 1938 i Kaminsky si stabiliscono a Vire, in Normandia. Qui il tredicenne Adolfo, assunto come apprendista tintore, riceve quella formazione che, per i futuri trent'anni, lo accompagnerà nella sua carriera di falsario. Le sue azioni illegali infatti non seguono la logica del mero profitto personale, ma sono messe in moto dalla propria sensibilità verso quanti vengono privati di diritti e libertà. Ecco quindi che la sua opera non si ferma al “solo” periodo della Resistenza ma continua nel sostegno al FLN nella Guerra d'indipendenza algerina, alle lotte rivoluzionarie nell'America Latina e a tutti quei movimenti d'opposizione alle dittature sorti a metà Novecento in tutta Europa.
Inoltre il lettore ha la fortuna di instaurare un diretto contatto con il protagonista di queste straordinarie vicende, perchè Una vita da falsario non è altro che un'autobiografia sotto forma di intervista. Sarah Kaminsky, infatti, impiega due anni di ricerche “per riuscire a fare la conoscenza di Adolfo Kaminsky” che sino ad allora aveva conosciuto solo come padre. Grazie a questa caratteristica il libro non scade in “effetti speciali”, non indulge in sensazionalismi, ma narra con semplicità e partecipazione eventi tutt'altro che ordinari.
Infine va dato merito alla casa editrice Angelo Colla Editore che ha scommesso su tale titolo per avviare la propria collana di narrativa. (Luigi Emilio Pischedda)
«Il Piccolo»
07-02-2011
Una vita del genere non poteva non generare un libro. L'ha scritto la figlia stessa di questo straordinario personaggio, Sarah Kaminsky. Lo pubblica Angelo Colla, che negli ultimi anni sta svolgendo un ottimo lavoro nel recupero di storie poco approfondite, trascurate.
Kaminsky si è sempre mosso fedele alle sue convinzioni umanitarie. Ha lottato per costruire un mondo più giusto e pià libero. Già a diciassette anni è diventato uno dei punti di riferimento per la Resistenza parigina in fatto di falsificazioni di documenti. Per trent'anni, poi, ha svolto il suo lavoro di falsario al servizio di chi veniva perseguitato dai potenti di turno. E nella corsa contro il tempo per salvare vite innocenti, è sempre stato il numero uno.
«Il Giornale di Vicenza»
05-02-2011
Perché, dopo più di sessant’anni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua storia nelle parole di sua figlia Sarah?
Perché Sarah mi ha sempre fatto moltissime domande, voleva sapere tutto della mia storia. Fin da piccola ne ha sempre ascoltato frammenti e io le ho sempre detto che le avrei raccontato tutto più tardi. Poi, un giorno, Sarah ha deciso che era arrivato il momento di rispondere alle sue domande e di farne un libro. Era convinta che le persone, e in particolare la sua generazione, dovevano conoscere questa storia poiché è portatrice di speranza in un mondo in cui i valori sono denigrati.
Lei ha spesso ripetuto che la sua vita «è stata una lunga e ininterrotta resistenza»: secondo lei, raccontare la sua storia è un modo per tramandare l’opposizione alle ingiustizie? Per non dimenticare?
Sì, ed è anche un modo per tramandare che niente è impossibile, che non bisogna mai accettare le ingiustizie e i crimini e che qualche volta basta un pugno di uomini e donne coraggiosi e di grandi ideali per cambiare il corso della storia.
Dopo la seconda guerra mondiale lei ha continuato a lungo a fare il falsario perché la storia umana non le ha mai lasciato tregua. Crede che esisterà un momento storico nel quale non ci sarà più bisogno di un falsario?
Mi piacerebbe. Sogno un mondo nel quale non ci sia più bisogno di un falsario. Sogno un mondo di giustizia e umanità, senza razzismo né segregazione.
Come lei ha raccontato, «A Drancy ho scoperto gli ebrei e la loro diversità, li ho amati, mi sono amato attraverso di loro, mi sono sentito ebreo, e questa identità non mi ha più abbandonato». Cosa significa oggi essere ebrei?
Personalmente, io non ho una religione. Sono di origine ebrea e fiero di esserlo, ma prima di tutto sono soprattutto un essere umano, come gli altri. E mi sento sempre dalla parte degli oppressi.
Rimpiange qualcosa della sua vita?
No. Ho avuto la fortuna di poter salvare molte persone, migliaia di persone. Ho avuto i mezzi per farlo e le circostanze mi hanno aiutato, ma non è stato facile. Oggi la storia mi ha dato ragione sulle mie scelte politiche, ma all’epoca dovevo agire di nascosto. Ero fuori legge, sempre clandestino e sempre nell’ombra Non è stata una vita felice. Nonostante questo, se ciò si dovesse rifare, rifarei tutto esattamente nello stesso modo, perché le vite di uomini e donne che ho potuto salvare sono valse questo sacrificio.
«Il Giornale di Brescia»
28-01-2011
A parlare è Sarah Kaminsky, figlia del più geniale falsario del Novecento. Un falsario sui generis. Adolfo Kaminsky ha messo infatti la sua particolare abilità e la sua arte sempre e solo al servizio di cause nobili. Fabbricando documenti falsi ha reso possibile la fuga di migliaia di ebrei dai territori occupati dai nazisti, messo in salvo migliaia di bambini dall’Olocausto e ha permesso l’emigrazione clandestina verso Israele dei superstiti dei campi di concentramento.
E ancora: i suoi documenti hanno salvato la pelle a centinaia di oppositori delle dittature di Franco in Spagna, di Salazar in Portogallo, dei colonnelli in Grecia; hanno evitato la tortura e la morte a molti militanti nelle lotte di liberazione dell’Algeria, o in favore della decolonizzazione dell’Africa e contro l’apartheid.
Un falsario, dunque, per amore della libertà e della giustizia. Un passato che ha sempre custodito nel silenzio. «Mi ci sono voluti due anni di ricerche e una ventina d’interviste per riuscire a fare conoscenza con Adolfo Kaminsky, io che lo conoscevo solo come "papà". A volte ho dovuto servirmi dello sguardo degli altri su di lui per capire le sue scelte, la sua vita da falsario, la clandestinità, il suo impegno politico, il suo non comprendere la società e gli odi che la abitano, la sua volontà di costruire un mondo di giustizia e libertà». Da questa ricerca è nata la volontà di Sarah di mettere alle corde il padre, perché condividesse con lei un passato di cui non aveva mai voluto parlare.
Incalzato dalle insistenti domande della figlia, alla fine l’uomo ha parlato ed è stata portata a galla una vita rocambolesca, raccontata poi in Adolfo Kaminsky. Una vita da falsario una biografia che ha il ritmo e il pathos di un avvincente romanzo.
Poco più che bambino, Adolfo iniziò ad appassionarsi alla tipografia, poi lavorò come tintore, scoprendo così la sua inclinazione per la chimica. Nel 1944 usò per la prima volta le sue conoscenze di formule e solventi per un altro scopo che non fosse quello di tingere o smacchiare tessuti. Quando i nazisti occuparono la Francia, Adolfo aveva diciotto anni, ma ne dichiarava uno in meno, per sottrarsi al lavoro obbligatorio. Insieme con i fratelli e il padre, era stato rinchiuso a Drancy e, purché di origine ebrea, era riuscito ad evitare la deportazione sui treni per Auschwitz grazie alla nazionalità argentina.
Dopo Drancy, Adolfo entrò in clandestinità, unendosi ai gruppi della Resistenza, dove la sua abilità come chimico e tipografo venne utilizzata per la falsificazione di documenti. La sua attività, tuttavia, non si esaurì con la Seconda Guerra Mondiale, ma proseguì fino agli anni Settanta.
In trent’anni di vita da ricercato dalle polizie di mezzo mondo, a prezzo di grandi sacrifici, correndo rischi per la sua incolumità, ha falsificato con straordinaria precisione un numero incredibile di passaporti, carte d’identità, permessi di soggiorno e di lavoro. Senza mai voler essere pagato.
«A modo mio – ha confidato Kaminsky alla figlia – e con le uniche armi di cui disponevo, per quasi trent’anni ho combattuto una realtà troppo dolorosa perché si potesse subirla o stare lì a guardarla senza fare nulla, nella convinzione di avere il potere di modificare il corso delle cose, che un mondo migliore restava ancora da inventare, e che potevo dare il mio contributo. Un mondo in cui nessuno avesse bisogno di un falsario». (Laura Ogna)
«Wuz.it»
24-01-2011
Una vita da falsario è la storia della vita di quest’uomo coraggioso, raccontata da lui e messa su carta dalla figlia Sarah. Perché Sarah, la figlia avuta da un Kaminsky non più giovane, non sapeva nulla del passato paterno. Nata in Algeria dalla moglie algerina di Kaminsky, Sarah incominciò a raccogliere alcuni indizi quando la famiglia rientrò in Francia – c’era una lettera, ad esempio, in cui lo scrivente ringraziava suo padre per il lavoro di spionaggio svolto nel 1945…
Nel 1944, quando i nazisti occupavano la Francia, Adolfo aveva diciotto anni, ma ne dichiarava uno in meno per sottrarsi al lavoro obbligatorio. Insieme ai fratelli e al padre era stato rinchiuso a Drancy ed erano riusciti ad evitare la deportazione sui treni per Auschwitz grazie alla nazionalità argentina. Dopo Drancy, però, la famiglia si era smembrata e Adolfo era entrato in clandestinità unendosi alla Resistenza. Una volta risaputa la sua abilità come chimico, il passo a diventare falsario era breve.
Quante vite aveva salvato Adolfo? Quanti bambini sarebbero potuti finire nelle camere a gas per una sola svista di Adolfo?
Quello che è stupefacente nella carriera di falsario di Adolfo Kaminsky è la coerenza che la regola. Perché, alla fine della guerra, Kaminsky mise la sua abilità a servizio di tutte le cause ‘giuste’, in difesa degli oppressi, di quanti lottavano per la libertà o anche per la semplice sopravvivenza. Era logico, dunque, che sostenesse l’immigrazione clandestina in Palestina degli ebrei in fuga dall’Europa che li aveva sterminati e, più tardi, vedesse nel movimento del Fronte di Liberazione Nazionale algerino il corrispettivo della resistenza francese al nazismo. Logico che aiutasse coloro che si ribellavano alle dittature – in America Latina, in Spagna, in Portogallo, in Grecia. O quelli che volevano sganciarsi dai regimi coloniali. A prezzo di sacrifici, della sua vita famigliare, correndo rischi per la sua incolumità. Finchè – erano gli anni ’70, della banda Baader Meinhof, delle Brigate Rosse, i cui metodi di guerriglia urbana Kaminsky non approvava – accadde qualcosa che gli fece capire che era ‘bruciato’, che doveva ritirarsi.
La figura del falsario è, nell’immaginario, un personaggio negativo o, se vogliamo, è qualcuno che possiamo ammirare per le sue capacità imitative. Ben diverso è Adolfo Kaminsky, il falsario eroe che potrebbe avere un albero tra i giusti sul Monte della Rimembranza in Israele.
«Il Venerdì di Repubblica»
21-01-2011
Adolfo Kaminsky, figlio di ebrei russi esuli in Argentina e in Francia, è stato il più straordinario e geniale falsario del XX secolo. Ricercato dalle polizie di mezzo mondo. Benché abbia sempre lavorato in nome della giustizia e della libertà: aveva 18 anni nel '43, quando entrò nella Resistenza francese e falsificò i documenti di migliaia di ebrei, salvandoli dall’Olocausto; 22 anni nel '47 quando aiutò l’emigrazione clandestina in Israele, fornendo a tanti superstiti dei campi di sterminio passaporti contraffattì; 32 nel '57, quando prese a costruire identità fittizie per i militanti della guerra di liberazione algerina. E così via nel tempo: documenti falsi di ogni tipo per salvare gli oppositori di Franco in Spagna, di Salazar in Portogallo, dei colonnelli in Grecia. Ma anche i nazionalisti africani contro i regimi coloniali e i rivoluzionari latinoamericani contro le dittature militari. «Nel '67 garantivo false identità ai combattenti di quindici Paesi diversi».
Mantenendo sempre il segreto con tutti, anche con la sua famiglia. Fino agli 84 anni, nel 2009, quando sua figlia, insospettita da alcune mezze parole, non ha incominciato a tempestarlo di domande. «Nel 1967 garantivo Munenti falsi ai combattenti di quindici Paesi diversi» Ne è nato un libro che il 277 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, esce in Italia: Adolfo Kaminsky. Una vita da falsario, di Sarah Kaminsky. Storia di un eroe mosso da una convinzione di fondo: «Qualora il governo di un Paese diventi illegale e assassino», parole sue, «a garantire la legalità devono impegnarsi i singoli cittadini». Ciò che lui ha fatto tutta la vita. Rigorosamente gratis: «Per assicurarmi l’indipendenza. Per poter dire di no a qualsiasi richiesta contraria alla mia etica democratica e pacifista». Solo nei casi in cui la clandestinità gli ha impedito di mantenersi come fotografo, suo mestiere ufficiale, Kaminsky ha accettato vitto e alloggio dai committenti. Ora le trattative sono in corso perché la vita di questo fuorilegge galantuomo diventi un film. Quale attore immagina nei suoi panni? «Il più anonimo che ci sia: vivere in incognito impone di diventare insignificanti. Ho sempre cercato di essere invisibile».
Tutt’oggi Adolfo Kaminsky è schivo e restio a parlare di sé. Anche se nel '71 mollò tutto: andò a fare il fotografo in Algeria, dove sposò la mamma di Sarah ed ebbe tre figli. Per tornare a Parigi, dieci anni dopo, fuggendo dall’onda dell’integralismo islamico, a fare il maestro di strada, aiutare i giovani delinquenti a reinserirsi nel lavoro. «L’ho sempre conosciuto in quella veste» racconta la figlia. «Finché, a cena con alcuni suoi vecchi amici, è saltato fuori che aveva partecipato a delle guerre. Come militare? Lui rispondeva in modo evasivo. E neanche mamma sapeva granché. Ci sono voluti due anni di ricerche e molte persone intervistate per fare saltare fuori la verità. E convincerlo a raccontare».
A partire dalla sua infanzia errabonda di figlio di esuli ebrei: da Buenos Aires (dove Adolfo è nato nel 1925) alla Turchia alla Francia. Prima a Parigi poi, con l’imposizione delle leggi razziali, in Normandia, dove a proteggerli è l’ottima reputazione di uno zio: «In quel peregrinare fin da bambino ho capito l’importanza dei "documenti", pezzi di carta indispensabili per muoversi liberamente». Adolfo prende la licenza elementare («unico diploma conseguito in vita mia») e a scuola si appassiona del giornale studentesco, imparando i rudimenti dell’arte tipografica. Quindi è apprendista tintore: mestiere duro, sempre lì a sciacquare gli abiti nel fiume gelido d’inverno. Ma ad affascinarlo è la chimica, la decolorazione degli inchiostri; e la sera fa di nascosto i suoi esperimenti. È lì che Adolfo scopre che perfino l’inchiostro più indelebile può essere cancellato.
«La mia formazione di falsario risale a quel periodo, fra i 13 e i 17 anni» ride. «E un bel giorno un amico mi chiede se sono disposto a fabbricare prodotti pericolosi. Perché no? Faccio sostanze per corrodere le linee telefoniche o arrugginire i binari o piccoli detonatori... È il mio debutto nella Resistenza». Ma nel '43 viene rinchiuso con la famiglia a Drancy, città circondata dal filo spinato dove si selezionano gli ebrei da deportare nei campi d’Europa. I Kaminsky si salvano grazie al loro passaporto argentino: Buenos Aires si è dichiarata neutrale.
E si ritrovano a Parigi senza un soldo in tasca. In cerca di documenti falsi (privi di quel timbro rosso che li inchioda come ebrei). Chi glieli fornisce scopre che Adolfo ne sa molto più di lui in fatto di inchiostri e stampa: può essere prezioso per la Resistenza. A 18 anni inizia la sua lunga carriera di falsario. «Ho subito rivoluzionato il loro metodo di lavoro», racconta oggi. «Anziché falsificare documenti esistenti, ne fabbricavo di nuovi, ingegnandomi per mettere a punto macchinari e tecniche sempre più valide». Ad aiutarlo, quattro ragazzini come lui. «Diventò il laboratorio più efficiente di Francia: produceva anche cinquecento documenti a settimana. Tutta la zona nord, fino al Belgio e ai Paesi Bassi, ne era inondata. Passavo molte notti sveglio, lottando contro il sonno. Svenivo spesso e gli occhi mi lacrimavano. La mia era un’ossessione: in un’ora fabbricavo trenta documenti vergini; se dormivo un’ora morivano trenta persone».
Dopo la liberazione di Parigi, Kaminsky lavora per i Servizi dell’esercito francese, fornendo documenti agli agenti paracadutati dietro le linee nemiche: «Non avevo mai falsificato passaporti tedeschi. E, per dare a qualcuno una nuova identità, ci vogliono anche falsi permessi di lavoro, ricevute d’affitto, scontrini di negozi, biglietti d’autobus... Ho dovuto fare molti esperimenti». Alla fine della guerra, i Servizi tentano di usare il suo tocco magico in vista di una riconquista, con la forza, della perduta Indocina. Ma Kaminsky si dimette: «Sono sempre stato contrario alle guerre coloniali». Accetta invece di lavorare per la rete che aiuta gli ebrei sopravvissuti allo sterminio a immigrare clandestinamente in Palestina (l’Inghilterra, che ha il mandato sulla regione, limita l’accesso ai profughi). Ma quando nasce lo Stato d’Israele, nel '48, e tutti i suoi amici partono, Kaminsky si rifiuta di raggiungerli: «Ero l’unico a essere ateo e non sopportavo l’idea di uno Paese fondato sulla religione».
«A 22 anni mi ritrovai solo, senza un reddito fisso, un curriculum ufficiale. Accettavo lavoretti, come fotografo o tintore, ma era difficile reinserirsi nella vita normale. Troppi fantasmi». Nel '57, l’incontro: «Potresti ancora fabbricare documenti falsi?» «Se fosse per una buona causa». La guerra di liberazione algerina lo è, per un anticolonialista come lui. Anche se ebreo. Lavoro duro: nel frattempo i documenti sono cambiati e ormai i più ambiti sono quelli svizzeri, che nessuno riesce a riprodurre. Nessuno tranne lui. E presto vengono a cercarlo gli antifranchisti spagnoli, i democratici greci e portoghesi, gli indipendentisti dell’Angola e della Guinea, le vittime dell’apartheid, i rivoluzionari argentini, brasiliani, salvadoregni, cileni, dominicani... Quando poi, alla fine degli anni Sessanta, incomincia a sentirsi vecchio e stanco, prende a fare scuola, ad addestrare giovani di ogni nazionalità all’arte del falso per scopi nobili.
«Una vita con troppe responsabilità», commenta la figlia Sarah. «Bastava un errore per provocare una morte. E papà non pensava ad altro. Il che ha creato in lui un nucleo di dolore. Una sconfinata malinconia». Il momento più difficile, Kaminsky? «Vivere in corsa contro la morte è sempre duro. Ma la più dolorosa è stata la lotta ai tedeschi. Dopo la guerra, tutti sono diventati partigiani. Durante la guerra, eravamo davvero in pochi». (Antonella Barina)
«Lettera.com»
15-01-2011
A diciassette anni Adolfo, da sempre appassionato di chimica, lavora già come esperto di documenti falsi per la Resistenza a Parigi e continuerà per tutta la sua vita la sua attività di falsario a fianco di popoli e organizzazioni che lottano per la libertà. Collabora per l'emigrazione clandestina degli ebrei sopravvissuti al nazismo, per il sostegno del movimenti indipendentisti in Algeria, in Venezuela, in Nicaragua, in Africa, appoggia i movimenti contro la dittatura in Spagna, in Portogallo, in Grecia.
Attraverso gli scritti e i ricordi della figlia e di quanti hanno avuto contatti con lui, viene fuori il ritratto di un personaggio geniale e impavido, di un eroe che a costo di immensi sacrifici salva innumerevoli vite, portando avanti un personalissimo ideale di giustizia.
 Roberto Festorazzi
Roberto Festorazzi
Margherita Sarfatti
«L'Opinione»
11-02-2011
Questa sua ultima può essere ben definita una lunga e importante fatica se è vero che come è vero che la ricostruzione della lunga, intensa parabola della Sarfatti (Venezia 1880-Cavallasca 1961) ha dovuto fare i conti innanzitutto con la damnatio memoriae caduta su una delle protagoniste dela vicenda mussoliniana, autrice della fondamentale opera Dux, con uno scavo minuzioso e appassionato durato dieci anni. E poi con la pigrizia del politically correct di una certa storiografia che stenta a fare i conti con la fine delle ideologie e dei rancori, a cominciare dai loro. Letterata di origini ebree e veneziane, madre della più giovane medaglia d'oro della Prima guerra mondiale, amante e consigliera politica di Mussolini, Margherita Sarfatti mostra tutta la sua dimensione e statura di intelletuale mitteleuropea e di figura femminile intrigante e polimorfa, capace si di garantire al Duce gli appoggi dell'alta finanza sia, soprattutto, di fornire un'immagine rassicurante all'estero e negli ambienti delle élite culturali. La signora del salotto più esclusivo della cultura d'allora, la donna dal fascino intellettuale come poche altre, la scrittrice che offre al mondo l'immagine del Duce, plasmandone il mito come fosse una sua creatura ideale. Lasciata per altre donne, più giovani, più belle ma già in prossimità delle scelte più catastrofiche del regime, a cominciare dalle leggi razziali, la Sarfatti riuscì a sfuggire alla tragedia della guerra rifugiandosi in Argentina dove scrisse, in inglese, il memoriale autobiografico My Fault, che però non diede mai alle stampe, servendosene semmai per articoli vari. Ritrovato dal Festorazzi, quel memoriale appare come decisivo nel restituirci l'esatta figura umana e psicologica del Duce, tolta dal piedestallo della mitologia e delle demonizzazioni assolute e collocata in una dimensione più autentica. Veniamo così a sapere, grazie all'autore e alla sua scoperta, dei vizietti mussoliniani, come la sifilide contratta in gioventù, di un certo uso, sia pur temporaneo, della cocaina, della scenata minacciosa di Mussolini al Re, dopo il discorso del 3 gennaio 1925, pretendendo la firma della messa al bando dei partiti, senza ottenerla. Personaggio di statura gigantesca, come la definisce Festorazzi e, soprattutto, di non facile confronto per via degli stereotipi e delle complessità e delle contraddizioni di una protagonista di un'epoca, con ogni sua foto che rimanda a una donna cangiante, e con caratteristiche tali da renderla a volte innafferrabile.
Di certo contribuì in maniera determinante al culto mussoliniano nella sua accezione classica, intrecciata cioè al mito della romanità che fu certamente da lei instillato nel Duce, essendo una profonda conoscitrice della cività di Roma. Un'altra importante fonte storica di Roberto Festorazzi è il dossier del barone Werner von der Schulemburg, consegnato in lettura e studio dagli eredi. Si tratta di una vera chiccca documentaristica, perchè scandagliando quelle carte l'autore ha trovato le prove del ruolo svolto dalla Sarfatti nella seconda metà del 1933, lavorando dietro le quinte della scena internazionale, per favorire una successione a Hitler. Ma la storia andò in un altro modo.
Un libro da non perdere.
«Il nostro tempo»
30-01-2011
A costei – un’ebrea eccezionale per intelligenza critica e capacità operativa, tale da essere considerata unica nella sua molteplice realtà di «amante e consigliera politica di Mussolini» – Festorazzi restituisce «tutta la sua dimensione di intellettuale mitteleuropea e di figura femminile intrigante e polimorfa» che riuscì, senza bruciarsi le ali, a passare indenne tra le calamità belliche che costarono l’Olocausto alla sua razza. Festorazzi è pervenuto a questo obiettivo mediante un libro godibilissimo, di avvincente lettura (come del resto sono tutti i suoi precedenti libri), costatogli dieci anni di approfondite ricerche e di intenso lavoro di strutturazione e sistemazione del materiale raccolto.
Essenzialmente le due fonti su cui l’autore ha costruito il suo personaggio. Innanzitutto un memonale autobiografico, retrospettivo e autocritico, che la Sarfatti redasse nel 1943-44, intitolato «My Fault»: una specie di controcanto al suo «Dux» del 1925, la fortunatissima biografia mussoliniana che vendette decine di migliaia di copie in Italia e all’estero, contribuendo a edificare il piedistallo su cui si affermò la popolarità del Duce. «My Fault» appare come un documento decisivo nella misura in cui, fra l’altro, rivela aspetti ed episodi inediti della vita di Mussolini quali il precoce e temporaneo consumo di cocaina e, soprattutto, la sifilide da lui contratta in gioventù, che avrebbe provocato sconvolgimenti psichici con conseguenze irreparabili nel comportamento del futuro dittatore.
E però ancora più importante, e significativo ai fini delle capacità indagatrici dell’autore, risulta l’altra fonte archivistica finora inedita reperita da Festorazzi. Si tratta del "dossier" del barone Werner von der Schulemburg, letto e studiato, in anteprima assoluta, dall’autore per concessione degli eredi. Questo Schulemburg, appartenente ad una famiglia protestante dell’antica nobiltà tedesca, appare come uno stretto collaboratore di Margherita Sarfatti, il quale «si trovò al bivio cruciale della sua vita quando dovette decidere se collaborare con Hitler o voltare le spalle al nazionalismo, consegnandosi a un destino quanto meno incerto». Che poi si rivelerà certissimo per lui e per il ceto cui apparteneva, di una sudditanza alla volontà del dittatore nazista.
Nella parte centrale del libro c’è una disamina dettagliata degli oscuri intrighi che fra il 1930 e il ‘33, nonostante i volenterosi tentativi della Sarfatti e di Schulemburg, portarono Weimar alla catastrofe finale con l’assunzione del potere da parte di Hitler. Contemporaneamente sopravviene il sostanziale fallimento del «Patto a quattro» in cui Mussolini, su suggerimento della Sarfatti, avrebbe dovuto svolgere una funzione mediatrice tale da provocare la sostituzione di Hitler alla guida del Reich. Accanto a tutto ciò Festorazzi costruisce un cammino particolarmente interessante dedicato a tale Giuseppe Renzetti, sconosciuto a tutti, ma in realtà confidente del Duce, e quindi non a torto definito «figura (...) centrale nei rapporti tra Italia e Gerniania durante il Ventennio». Il libro prosegue in questo modo rapsodico e dopo svariate vicende che ruotano attorno a Margherita Sarfatti si conclude con la fine della protagonista il 30 ottobre 1961 nel buen retiro di Cavallasca, alle porte di Como. Ma non è finita la ricerca di Roberto Festorazzi attorno a questa straordinaria figura di donna; ci sono ancora domande che attendono risposta: in particolare dove sono finite le lettere di Mussolini, l’uomo che (sfortunatamente per lui e per l’Italia) volle sottrarsi all’influenza, sostanzialmente positiva, di questa ninfa Egeria del Novecento. Le sorprese sono dunque ancora dietro l’angolo. (Giorgio Gualenzi)
«L'Espresso»
16-12-2010
«L'unione Sarda»
05-12-2010
Chi era veramente la Sarfatti?
«Un’intellettuale polimorfa, curiosa di tutto, interessata anche a promuovere nuovi talenti letterari, da Alberto Moravia a Corrado Alvaro che portò in auge già negli anni Trenta». Quando e come iniziò il suo sodalizio con Mussolini? «Il rapporto con Mussolini nasce da una complementarietà: la Sarfatti è una donna con un’intelligenza orientata al maschile, e la sua volitività,la porta ad assumere una fisionomia caratteriale maschile che diventa complementare a Mussolini. Non fu solo l’amante del Duce, ma la donna che ha forti intuizioni sul suo percorso politico».
Una donna energica, forte, politicamente combattiva, non solo l’amante di Mussolini.
«Amante di Mussolini sì, ma anche donna ebraica che giunse ad un’apertura e ad una comprensione del cattolicesimo, scrittrice nota soprattutto per la biografia Dux, tradotta in 18 lingue, e coordinatrice di un movimento importante come Novecento: una figura in qualche modo inafferrabile e misteriosa anche per me».
Misteriosa in che senso?
«Ho cercato di descriverla, ma resta sempre qualcosa che sfugge di questa donna che in ogni sua fotografia appare una persona diversa. È una donna con molte anime e ha addosso sempre un alone di mistero, che scrive lettere in una specie di codice cifrato».
La sua presenza fu benefica per il fascismo e per il Duce?
«Sì, perché contribuì alla costruzione del mito del Duce come uomo forte del Paese. Fece sì che questa figura carismatica fosse strutturata in modo tale da entrare dopo la prima guerra mondiale nel disegno della costruzione di una nuova Europa con un equilibrio solido. Lei aiuta a strutturare la figura di Mussolini come uomo che lancia ponti verso l’Europa, la Germania pre hitleriana, la Francia, l’Inghilterra e gli stessi Stati Uniti. Era molto positiva sul piano della politica interna, ma soprattutto su quella internazionale. Era una donna mitteleuropea e quindi con ampie entrature negli ambienti ebraici e internazionali di oltre Alpe, e in questo senso la sua influenza era largamente positiva». (Francesco Mannoni)
«Il Giornale»
28-11-2010
«La Provincia di Cremona»
23-11-2010
«L'Eco di Bergamo»
22-11-2010
«Il Tempo»
13-11-2010
«L'Avvenire»
13-11-2010
«Il Secolo d'Italia»
17-10-2010
 Charles Aznavour
Charles Aznavour
A voce bassa
«Il Venerdì di Repubblica»
01-10-2010
Oggi, a 86 anni, Monsieur Aznavourian ha ancora il coraggio delle proprie idee. E di un giubbotto da motociclista in cuoio nero. Molto elegante. Vagamente retrò. Vagamente Giacomo Agostini. Riceve nel suo ufficio presso le edizioni musicali Raoul Breton. Alla parete, un grande ritratto di Sinatra. Ammucchiato ai piedi della scrivania, un annoso cane scuro dall'aria omerica e sfinita. Sospira nel sonno. Aznavour sorride, sotto i famosi occhi struggenti. È un signore dell'ironia eterea. Ribadisce quanto scritto nel libro: «Non sono mai stato davvero giovane. Perciò oggi ho l'impressione di non essere davvero vecchio».
Accidenti, chi le ha rubato la giovinezza?
Tutti e nessuno. Il corso della vita. Della storia. Ho cominciato a lavorare prestissimo. E poi sa, durante la guerra avevo vent'anni. Un piccolo armeno che i tedeschi scambiavano sempre per ebreo. I giovani li ho conosciuti più tardi. Ma scrivendo canzoni per loro. Da Johnny Hallyday a Sylvie Vartan.
E adesso difende il rap.
L'hanno paragonata a Simenon, per l'attenziona all'umanità minuta, ai marginali. Ha raccontato l'omosessualità, la droga, l'obesità quando per uno chansonnier erano ancora temi passibili di scomunica. E oggi?
Continuo. Parlerò delle campagne abbandonate, di giovani borghesi rovinati dalla crisi, perfino del maggio '68.
…
Della sua madrina Edith Piaf scrive nel libro: «Hanno detto che si drogava. Non è vero»
In casa non le ho mai visto siringhe. O polverine. Ma sa, ci sono tanti modi per drogarsi. Dal vino ai farmaci.
Un'immagine di Sinatra.
Quando c'invitò in tre al ristorante e ordinò quattro bottiglie magnum di Bordeaux Pétrus.
Roba da 25 mila bigliettoni al pezzo. Gran generoso o grande alcolizzato?
Uomo sfaccettato. Dell'italiano aveva conservato tutto. Tranne la lingua...
…
(Marco Cicala)
«Il Giornale di Vicenza»
16-09-2010
Sul tavolino accanto lo attende una pila di volumi da autografare, sono le copie di A voce bassa, il galateo o vademecum d’artista che Aznavour ha scritto con ornata secchezza e che ha trovato il suo editore italiano in Angelo Colla. Il libretto si legge d’un fiato e si indirizza ai giovani, ma chissà quanti avranno la pazienza di sfogliarlo: non un’indiscrezione fiscale o intimistica, nessun pettegolezzo salace. Il discorso è incentrato tutto sul lavoro, sul calvario richiesto da ogni immortalità terrena, sulla solitudine del grande artista internazionale che deve essere innanzitutto costruita da lui e in nessun caso maledetta. Anche a non saperlo in anticipo, si capisce che Aznavour non poteva che essere raccomandato da una sgobbona come Edith Piaf.
«Ho qualche problema di schiena ma niente di serio, ogni mattina mi sveglio alle sette e mi metto alla scrivania, ormai è un’abitudine. Mi piace lavorare, direi che mi piace l’idea stessa del lavoro, ma questo è l’oggi. Le cose starebbero altrimenti se non avessi lavorato anche quando non ne avevo voglia, fino a farmi piacere le scadenze del successo almeno quanto mi dispiacciono le fedeltà dell’insuccesso. E niente fretta, la fretta è di chi si accontenta. Ho passato la vita a scansare la facilità, prima quella di non sapere, la facilità degli ignoranti, poi la facilità che ti viene dal sapere molto, cioè dall’illusione di saperla lunga».
È arduo tentare di dare un’ impressione del modo di conversare di Aznavour. Come molti uomini per cui la reticenza è parte di una regola di bon ton, sa usare trucchi straordinari per evadere da questa regola mantenendo il contegno di chi la osserva. Sulle sue radici armene («Sono un francese di origini armene, non sono un armeno di Francia») si intrattiene senza avarizia e senza enfasi. La sua aria di responsabilità serena eppure guardinga non rende conto della febbre che scorre sotto la superficie compita delle frasi, un’eccitazione che si concerta in sempre nuovi arrangiamenti anche molto discordanti, tipo mostrarsi ottimista con i giovani (ormai una categoria merceologica più che altro) e scettico verso la loro capacità di piangere le sue stesse lacrime. «Ai giovani non ho che un consiglio da dare: leggete, leggete e ancora leggete! La musica che si nutre solo di musica fa venire il latte alle ginocchia. Io mi sono fatto l’orecchio su La Fontaine e Corneille oltre che su George Brassens e Charles Trenet. E poi non basta apprendere la musicalità del linguaggio, bisogna esercitarla. E sceglietevi i collaboratori più validi, in ogni campo: il miglior agente, il miglior addetto stampa, il miglior tecnico del suono... Non importa se sono antipatici, se hanno idee opposte alle vostre: purché siano bravi nel loro mestiere e non vi mettano i bastoni tra le ruote. Per quello ci sono i cosiddetti amici, i colleghi, i critici... È un errore cercare la popolarità ed è un errore respingerla, perché la si ottiene a rovescio... Io ricordo bene i miei esordi, come sono stato accolto, cioè respinto, dall’ambiente musicale. Allora un esordiente era guardato come una minaccia, altro che cher confrère! E il pubblico prima di concedere un applauso poteva tenerti sulla corda per un’ora intera di concerto. Ma guai a scoraggiarsi! Si accaniscono ancora di più perché li hai confermati nel loro preconcetto. Una delle mie primissime esibizioni andò proprio così. Finito il primo tempo volevo sparire dal teatro e dal mondo, non si era udito un solo battimani, tutti fermi e zitti, e io li vedevo in faccia, allora c’era luce anche in platea come se gli spettatori fossero parte dello show. Da dietro il sipario chiuso sentivo cigolare le sedie, stavano indubbiamente lasciando il teatro, se fossi riapparso lo avrei ritrovato deserto. Stringo i denti, dò il segnale di levare il sipario... C’erano tutti, e tutti in piedi. Appena riattaccai partì una di quelle ovazioni che ti rimbombano dentro anche 60 anni dopo...».
«L'Unità »
12-09-2010
A voce bassa è il libro di un uomo anziano ed esperto che si racconta per i più giovani e che li avverte delle trappole che lo showbiz riserva ai Pinocchi: «Ho scritto pensando alla gioventù che ogni giorno viene sedotta e imbrogliata, soprattutto dai mass media. Se fai credere a un ragazzo che in quattro mesi lo trasformerai in una star, lo illudi. Non c’è mestiere né arte che si impari in dieci settimane. E, per chi in quattro mesi tocca il cielo con un dito, sono pronti i parassiti che mangeranno nel suo piatto». Sapete che cosa ha capito Shahnour/Charles, quest’uomo che calpesta palcoscenici da 78 anni? «I familiari non devono diventare dei famigli. Fratelli, moglie, amici restino tali. Impresari, press agent, segretari si scelgono altrove: mai affidare il proprio destino in mani altrui». Se da un certo momento in poi il suo agente è stato un armeno, Lévon Sayan, è avvenuto, dice, solo perché su piazza era il migliore.
A voce bassa è anche il racconto vincente e malinconico dell’infanzia di un forzato autodidatta: il piccolo Shahnour, che ha esordito nel 1933 con la faccia dipinta di nero nei panni di un africano in una pièce di Erich Kàstner, conquista con i denti la licenza elementare. Da grande lo riscatteranno tre lauree honoris causa. «L’autodidatta è quello che alla fine, nel bene o nel male, riesce, esce dalla sua condizione e si innalza. Può essere il ragazzino che diventa un cervello della mafia. Può essere l’artista. Spesso è figlio di sradicati, sa quanti americani figli di immigrati ce l’hanno fatta, sa quanti maghrebini da noi in Francia ora conquistano il successo? Ma devi avere una ricetta. La mia era questa: non voglio che passi giorno senza che impari qualcosa. Non c’era sera che andassi a letto senza libro sul comodino».
Shahnour Aznavourian, come racconta nel suo libro, aveva una sorella quasi gemella, Aida, un padre estroverso e fantasioso e una madre bella che cuciva silenziosa. Era l’unica sopravvissuta al massacro dei Bagdassarian, la sua famiglia, nel genocidio degli armeni a opera dei turchi. Il figlio, parigino nato e che si sente francese fino al midollo, orgoglioso titolare di una multicolore «famiglia Benetton» (lui cristiano di rito gregoriano con moglie svedese protestante) scopre la forza di quell’ascendenza quando il terremoto squassa l’Armenia, repubblica sovietica, nel 1988, decide di portare aiuto e, dopo essere riuscito a fare ripartire 12 centrali elettriche, viene soprannominato «Charles la Luce». Da un anno e mezzo veste i nuovi panni di diplomatico per un paese che di fatto non è il suo, ma che pensa di poter servire: «Non c’è rischio di guerra tra Armenia e Svizzera» scherza. «Ma in Turchia sono popolare. Può essere utile. Per i turchi l’onore è quanto è la vita per gli ebrei: sull’onore si brinda. La Turchia vuole entrare nell’Unione Europea? Impari a rispettare gli impegni presi, riconosca il documento firmato e poi disdetto che dice che nel 1915 sugli armeni fu effettuato un genocidio. Io ho speranza, bisogna averla. (Maria Serena Palieri)
«Vivere in armonia»
01-09-2010
Un po’ istrione lo è, almeno sulla scena, quando canta le sue mille canzoni che hanno conquistato il mondo e che in Italia ha regalato a Modugno (La mamma), alla Vanoni e alla Cinquetti (La bohème), a Mina (E io tra di voi) poi ripresa da Franco Battiato, e all’amico Massimo Ranieri (proprio L'Istrione). L'ho visto cantare parecchie volte: in un concerto all'Olympia, come ospite d'onore a Sanremo, nell'81 e nel '79 e prima, nel 1972 al Festivalbar, con una canzone degli spot del Mulino bianco. Sempre cordiale, con quell’italiano che non dimentica mai la lingua francese (ma parla e canta correttamente in inglese, spagnolo, tedesco e russo), con quella statura che è quasi napoleonica ma non lo fa apparire piccolo. Oggi poi, i capelli d’argento gli conferiscono un aspetto addirittura imponente. Si dice che abbia ceduto al bisturi della vanità, facendosi rimodellare il naso, per via di una malformazione al setto nasale che lo infastidiva mentre cantava.
Certo i suoi anni li ostenta con baldanza, e non è molto diverso all’Aznavour che avevo conosciuto bene alla fine degli anni Sessanta, quando andai a intervistarlo a Parigi. Mi avvertì che viveva fuori città, forse perchè temeva che non arrivassi puntuale. Il taxi attraversò tutto il Bois de Boulogne, arrivò in una campagna florida, dove le villette erano lontane l’una dall’altra e c’era tanto verde: «Sono appena tornato da Las Vegas – mi spiegò – dove mi sono sposato» e mi presentò Ulla Thorsell, bellissima ragazza svedese che poi, nel 1970, avrebbe risposato nella chiesa armena di Parigi. Stanno insieme da quarant’anni.
Ricevette me e il fotografo che doveva realizzare il servizio come ospiti illustri. «Se qualcuno viene mandato sin qui da un altro Paese per incontrarmi, per me è una cosa importante e poi, ieri sera, nel mio camerino vi ha accompagnato Bruno Cocatrix (leggendario patron del teatro di Boulevard des Capucins, n.d.a.) cioè l’anima dell’Olympia». Fu una giornata piacevole, una flûte di Dom Perignon e tante confidenze. Colui che la Francia di Chirac avrebbe insignito della Legion d’Onore amava la musica italiana, e ammirava Mina e la Vanoni. L’Armenia lo ha proclamato eroe nazionale, in Usa lo definirono "Aznavoice" quando in classifica superò Sinatra. Ha interpretato 60 film debuttando con Sparate sul pianista di Truffaut. «Ho smesso col cinema perché di solito la lavorazione dura parecchie settimane e io ho scelto di stare in famiglia e fare il contadino».
Aznavour ha appena dato alle stampe un libro autobiografico, A bassa voce, dove racconta la propria vita senza alimentare leggende. C’è poi un progetto ambizioso, nato quasi per caso: organizzare serate-evento sulla piazza Rossa, al Partenone e sotto la Tour Eiffel. «Intanto sto preparando il mio nuovo album. Ho pronta un’ottantina di canzoni e sceglierò tra quelle le migliori». E c’è anche la possibilità che riesca finalmente a cantare con Mina. «Alla mia età si può, si deve continuare a sognare». Ha ragione Battiato quando canta: «Bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti, ma c’è voluto talento per riuscire a invecchiare senza diventare adulti». (Gigi Vesigna)
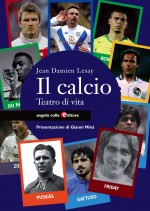 Jean Damien Lesay
Jean Damien Lesay
Il calcio. Teatro di vita
«http://calciostatistiche.typepad.com»
25-03-2014
Squadre e calciatori, famosi o sconosciuti, interpretano con le loro gesta rappresentazioni sceniche che si collocano ciascuna in determinati e precisi contesti storici e sociali. Come lettori che diventano spettatori assistiamo così a tragedie, drammi, commedie e situazioni ansiogene o assurde. Tragedia è quella che investe la Honved di Budapest, in seguito all’invasione sovietica dell’Ungheria del 1956. La forte compagine magiara si trova per fortuna in quel momento in tournèe in giro per l’Europa con i suoi ammirati campioni: tra questi Puskas, Kocis e Czibor non faranno più rientro in patria scegliendo la libertà in Spagna (il primo si accaserà al Real Madrid, gli altri al Barcellona). Di dramma (psicologico) è invece protagonista il funambolico attaccante inglese Stanley Mattews, primo calciatore insignito del titolo di baronetto dalla Regina d’Inghilterra, che battè ogni primato di longevità scendendo in campo nell’ultima gara di campionato nel 1965 a 50 anni compiuti. Una commedia vede invece come attore il calciatore russo Gazzaev che beffa il club francese del Chamois Niortais che lo acquista nel 1994 credendolo un nazionale olimpico. Si rivelerà invece per quello che è: un assai mediocre giocatore di livello dilettantistico. Colpiscono anche le storie di Joe Payne (che nel 1936 nella sua gara d’esordio in terza divisione inglese realizza 10 gol,record ancora imbattuto) e di Theo Walcott (attaccante di riserva dell’Arsenal senza esperienza in prima squadra, che viene sorprendentemente chiamato dal C. T. Eiksson a partecipare alla spedizione inglese ai Mondiali 2006). Questi accennati sono alcuni dei racconti, che l’autore ci porge con stile chiaro e fluente facendoci conoscere episodi a volte anche inediti ma sorprendenti. Ne esce quindi un libro assai divertente, nel quale il calcio coi suoi aspetti diventa spettacolo di vita. (Massimo Girgenti)
«Il Mattino»
03-10-2010
«Famiglia Cristiana»
11-07-2010
Storie dense e piene, scovate con criteri di volta in volta diversi, dove la palla è una presenza costante, ma mai davvero protagonista. Tra la palla e la vita, vince sempre la vita. Anche se, a volte, tra queste pagine si muore. (Elisa Chiari)
 Marco Cavalli
Marco Cavalli
Sette note sulla lettura
«Lettera.com»
15-01-2011
Una riflessione, questa presentata da Cavalli nel libro, che percorre in parte l'analogo sentiero di Daniel Pennac in Come un romanzo. Un sentiero fatto di lettura, e letture, in cui l'autore spazia dai ricordi della sua gioventù a quelli della sua maturità (con diverse incursioni, anche a gamba tesa, sul come il web e l'editoria commerciale hanno modificato il concetto stesso di lettura e lettori), tutti nella veste di lettore disinteressato, ovvero sviscerando, o forse confessando, tra le righe, un certo malessere nei confronti di tutto ciò che è moda, che è pensiero comune e propaganda, che è marketing e condizionamento mediatico, e ancora dogmi sociali e obiettivi rigorosamente utilitaristici. Insomma, un chiamarsi fuori dal coro di tutto ciò, sopra elencato, che trasformi il piacere della lettura in una sorta di obbligo morale, a scuola e nella vita, per coloro che vivono quello che dovrebbe essere un piacere come un'insopportabile costrizione, e che in fin dei conti vivrebbero senz'altro meglio al netto di sorrisini di circostanza, e sensi di colpa striscianti per il fatto di non essere adepti naturali dell'oggetto libro. Una riflessione nel complesso molto interessante, che sottende inoltre, neanche troppo, qualche consiglio, più o meno condivisibile, rivolto all'esercito di aspiranti scrittori che dilagano sul web e altrove, giovani e meno giovani, che bene farebbero, ancor prima che puntare a diventare famosi con un romanzo best seller, a leggere un po' di più, e un po' meglio. Va anche detto che, per quanto in generale condivisibile, il presupposto "classico uguale buono", "narrativa di genere uguale cattivo" (rispetto alla letteratura con la maiuscola) che emerge tra le righe e sopra le righe, genera la sensazione che l'autore si prodighi nella difesa di un certo tipo di letteratura, quella cosiddetta classica, trasformando così una riflessione oggettiva in un giudizio soggettivo. E questo, somiglia un po' a quel "dogma" contro cui sembrerebbe invece rivolto il libro. In ogni caso una lettura che potrebbe essere interessante per molti, dagli aspiranti scrittori alle zie di nipoti adolescenti, dagli editori ai lettori coatti, dai lettori liberi agli scrittori affermati; da sconsigliare invece, forse, ai fan di Joe R. Lansdale, o degli altri "spacciatori" di best seller, di cui è ricchissimo il mercato americano, e perciò pure il nostro. (Luigi Brasili)
«Il Gazzettino»
17-09-2010
Che siamo un popolo che legge poco lo sapevamo. Ma a parlare con la gente non ce n'è uno che non si dica rammaricato di ciò. Tutti vorrebbero leggere di più. E allora perché non lo fanno?
I motivi sono tanti, ce li illustra il critico letterario vicentino Marco Cavalli in Sette note sulla lettura. La colpa è del sistema, dice Cavalli, della scuola in primis che soffoca sul nascere il desiderio di leggere, della televisione e di Internet che semplificano e banalizzano la lettura, e dell'industria editoriale interessata a creare acquirenti ma non veri lettori, oggi in via d'estinzione.
Dall'infelice congiuntura di questi (e altri) fattori sarebbe nata una nuova razza, quella del "lettore coatto" - che è quello che si sente obbligato a leggere ma non lo fa - a cui va tutta la riprovazione (e compassione) dell'autore che si sofferma a descrivere le complesse dinamiche di (non) lettura che lo caratterizzano. E mentre di veri lettori ce n'è di un solo tipo, di lettori fasulli ce ne sono tanti oltre al coatto: il feticista, il lettore di genere e quello che procede a salti, Cavalli ce li presenta tutti.
Il vero punto debole di questo libro denso e appassionato è che è difficile, criptato ai più da un lessico ricercato, con affermazioni che spesso vanno dedotte da tre negazioni. È un libro scritto per mostrare qual è il vero modo di leggere ma che finirà per essere letto soltanto da chi ha già voglia di leggere. Col rischio poi di indurre nel vero lettore quell'autocompiacimento che caratterizza il lettore coatto. (Anna Renda)
«Il Giornale di Vicenza»
30-06-2010
Il libro Sette note sulla lettura di Marco Cavalli non parte da qui. Questa è un’immagine che troviamo un po’ più avanti, fra altri discorsi sui modi e sul senso del leggere, ma in realtà tutto ruota intorno a questo bambino silenzioso e beneducato, che quasi per caso in un’afosa giornata estiva si addentra in un territorio lussureggiante e nuovo, dove parole mai udite penzolano nel vuoto cariche di promesse e golosi richiami. Un bambino che una volta cresciuto farà della lettura, delle parole e più in generale della letteratura, un punto di riferimento costante del suo andare per il mondo.
Critico, traduttore, consulente editoriale, lettore a oltranza, Marco Cavalli, vicentino, ha l’indole eretica e provocatoria del bastian contrario. Tutti d’accordo nel dire che la lettura apre la mente, spalanca orizzonti, eleva gli animi, aiuta a colmare ogni genere di defaillance e per questo in suo onore si organizzano festival, incontri e deferenti simposi? Benissimo, accomodatevi pure da un’altra parte, perché alla tavola di Cavalli si va senza libri, e possibilmente anche senza lettori, dal momento che l’unica condizione richiesta è quel principio di libertà in base al quale si legge solo quando si ha voglia di farlo. Una gratuità difficile da scovare, sommersa da una retorica che ha ormai travolto in ugual misura il mondo reale e quello virtuale, entrambi impegnati a collocare la lettura su una specie piedestallo sapienziale dal quale sembrano discendere ogni sorta di beatitudine intellettuale e spirituale. Ed è proprio a quel piedestallo che la fionda del critico vicentino mira con irriverente, caparbia determinazione. «Da me non sentirete una parola – scrive – su che cosa ci si guadagna a leggere. Non ci si guadagna un fico secco, è questo il bello, o il guaio (fate voi). Che necessità c’è di associare un profitto alla lettura?» Niente profitto, niente pedagogia o intimazione alla lettura, dunque. Il libro di letteratura per sua natura non si impone, non pretende di essere indispensabile. «La letteratura non vive di consensi. Non è ricattatoria, non pratica alcuna forma di ritorsione e intimidazione. Soprattutto, non è disposta a vincere a qualunque costo. Basta talmente a se stessa che può astenersi da aver sul momento dei lettori, specie se per averli deve reclutarli con la forza».
Distanza e passione. Passione e distanza. Il racconto di Cavalli, perché di racconto si tratta, gira intorno a queste due coordinate. Prendere le distanze dalla lettura come affare, industria, consumo, assessorato, commercio, religione, intimazione, retorica, esperienza intellettualistica, sapienziale, fenomeno d’intrattenimento festivaliero, medicina sociale e restituirla alla sua libertà scapigliata e anarchica.
Una distanza e una passione, che finiscono con l’innescare un beffardo gioco delle parti, di cui lo stesso Marco Cavalli (classe 1968, ora in forze a quell’industria editoriale dentro la quale si aggira il simulacro affannato e ringhioso di una lettura sbrindellata e stravolta) diventa regista e sarcastico interprete. Una distanza che in lui ha il sapore di una calcolata, strenua presa di distanza. Un evidente tentativo d’incanalare la sua smodata bulimia di lettore lungo traiettorie più disimpegnate e lievi, con la voglia forse di recuperare per sé quella verginità di approccio al libro che vuoi o non vuoi l’abitudine assottiglia e disperde. «Invano tentiamo di annerire di nuovo la lavagna, di scrollarci di dosso il sapere che si ammucchia e frappone. Le polveri che servono a minare l’intelligenza provengono dal suo magazzino. Dal manierismo della lettura non si esce con altre letture ma inventando nuove relazioni di conflitto».
Può allora succedere che il lettore incantato di ieri si trasformi nel narratore disincantato di oggi. Un narratore che mettendo insieme un controgalateo della lettura ricco di annotazioni e incisi graffianti, infila qua e là fosfeni autobiografici dì notevole effetto tonale. Come per esempio il delicato ritratto di Giada, l’amica traduttrice milanese, anche lei divoratrice di libri, esperta lessicografa, rigorosa, segreta, attraversata da un filo di cristallo luminescente e tenace, alter ego di uno sguardo che su di lei sbalza e indaga quel dettaglio che a volte può davvero rivelarsi un "mondo senzaconfini". (Maurizia Veladiano)
 Françoise Frontisi-Ducroux
Françoise Frontisi-Ducroux
Trame di donne
«Il Foglio»
31-07-2010
«Avvenire»
17-06-2010
 Davide Lopez
Davide Lopez
La potenza dell'illusione: l'amore
«Pedagogika.it»
01-06-2010
Esso è strutturato in due forme di scrittura, una per aforismi, l’altra per paragrafi ampi in cui il filo del pensiero si snoda in modo più disteso. Eppure tra le due forme mi sembra di rintracciare un filo di continuità, che mi pare di rintracciare a partire dall’etimo di aforisma che nella sua derivazione da aphorismos significa "porre i termini", "limitare".
Allora, dicevamo, un filo di lettura si può rintracciare nel porre un limite, limite che si incontra nelle parti dedicate al rapporto tra legge e giustizia (si pensi al paragrafo dedicato alla sentenza di un tribunale rumeno), limite nel rapporto tra le persone, limite nelle rappresentazioni dei rapporto tra i sessi.
Proprio da quest’ultimo inizia il testo, proponendo una lettura del mito dell'androgino di Platone come elemento fondatore di un intervento degli dei per spingere gli umani, attraverso la differenza tra i sessi, a cercarsi. Ma la condanna originaria diviene punto di partenza per una riflessione sulla sessualità più ampia, tale da includere le declinazioni che assume la differenza sessuale nelle diverse epoche storiche. Insieme a questo primo aspetto mi pare centrale l’individuazione di un punto di passaggio dalla società patriarcale a quella di Gesù bambino dove «si assiste al ritorno dell’importanza prevalente del rapporto madre-bambino e, perfino, della simbiosi fusionale, quale estrema regressione di questo rapporto». Riflessione che ben si adatta a questo numero monografico della rivista dedicato alla madre e che mi pare ritorni in alcuni articoli. Merito dell’autore è quello di non cadere nel facile rimpianto dei bei tempi andati, sottolineando invece quanto in autori dei bei tempi andati fosse presente una sottovalutazione del ruolo della donna ma anche come la soluzione non consista nel ridurre la donna a madre, facendo coincidere le due figure e quindi negando la prima nella seconda.
Un altro filo che mi è sembrato di intravvedere parte dalla nozione di colpa. Ci sarebbe molto da scrivere, ma vorrei limitarmi ad un commento a partire dall’aforisma 83 a pagina 139. «Un modo perverso di asserire e affermare la propria libertà è quello di infierire contro se stessi, moltiplicando e trasformando per orgoglio narcisistico i colpi che si sono ricevuti dall’esterno in colpe sacrificali».
Il legame tra i due elementi, colpi e colpe, mi pare tenga attraverso il termine orgoglio narcisistico, che pur di eliminare la presenza del caso nell’esistenza, e quindi esporsi responsabilmente alla precarietà dell’esistenza, preferisce assumere su di sé le colpe, per mantenere l’illusione del controllo sul mondo, l’illusione di centralità.
Appare ora un nuovo nesso tra il limite che l’aforisma stabilisce e l’invito ad osare che percorre tutto il testo, un invito ad osare nel limite, nelle parole che configurano un mondo possibile, possibile per la convivenza, dove la legge non è un assoluto che soverchia, ma un invito a pensare la possibilità dei legame sociale, a stabilirne i confini per renderli pensabili, guardando a un orizzonte per prefigurare un oltre, un passaggio difficoltoso ma possibile. Il limite non come impedimento ma come confine, come orizzonte che rende possibile l’esistenza. Allora l’invito ad osare che percorre il testo è un invito all’assunzione di responsabilità, come ricerca delle risposte, come invito ad uscire: in fondo è solo mettendoci in strada che possiamo incontrare colui che è offeso o colui che ci accompagnerà nel viaggio. Non sta forse in questo desiderio il primo passo verso l’amore?
«Con un atto istantaneo di comprensione e consapevolezza si annulla tutto il mondo della colpa». Forse questo è il miglior viatico per poter osare, comprendendo ed essendo consapevoli, ma l’autore lo dice meglio di me. (Ambrogio Cozzi)
 Jean-Pierre Otte
Jean-Pierre Otte
La vita amorosa dei fiori da profumo
«Lettera.com»
15-01-2011
Un saggio insolito e particolarmente appassionato, che sotto forma di brevi storie, racconta il carattere e le tecniche di seduzione di diverse piante da fiore. Scoprirete così che la viola ha una doppia vita, che il garofano si offre solo alla farfalla mentre la lavanda con il suo profumo intenso accoglie tutti gli insetti, cosa combinano la rosa, il mughetto, il narciso.
Da leggere in giardino, o da regalare a chi vi ha appena sedotto, per confrontare e rivedere le diverse, infallibili strategie. (S.M.)
«guide.superEva.it»
07-07-2010
Acuto osservatore degli ambienti naturali e dei loro abitanti, non aveva immaginato che tutta quella materia accumulata e accatastata nella memoria in vent'anni di esplorazione del limitrofo, si sarebbe trasformata un giorno in libri.
Le spedizioni intraprese erano proprio lì, dietro l'angolo del resto, non si può andare lontano se non si è capaci di esplorare ciò che è vicino e più di ogni altra cosa è importante imparare a viaggiare in profondità. Solo in questo modo Otte è riuscito a visitare una varietà di universi, ha oltrepassato confini invalicabili, battuto ruscelli e foreste, è penetrato nelle cerchie più intime di molte specie. Da tutte queste ricognizioni rientrava ogni volta con la scoperta, fra l'altro, di un nuovo rituale amoroso che, nello stesso tempo, gli insegnava qualcosa su se stesso.
Il secondo passo è stato quello di trovare uno stile di scrittura che si adeguasse a questa materia.
Il risultato è un modo di esprimersi rigoroso, preciso, dettagliato, ma insieme molto poetico ed evocativo, capace di toccare le corde più profonde del lettore, di stimolarne i sensi. Una forma che è in grado di conferire al contenuto valore e chiarezza, ma anche una forza fertile e sensuale. E il contenuto di questo interessantissimo volumetto che chiude, come abbiamo accennato, una serie di volumi, è la vita amorosa delle piante da profumo.
Dopo alcuni tentativi di fabbricare profumi artigianali da regalare a mogli e amiche, ottenuti con un alambicco di fortuna e poi affinando sempre più le diverse tecniche estrattive, l'autore si sofferma sulla nascita dell'interesse per la vita e gli amori dei fiori da cui, un tempo, aveva creato essenze.
Nel caso della rosa canina, si sofferma sulla struttura dei gambi, coperti di spine, dei fiori, che fioriscono a bottone e che si schiudono a sottana, mostrando le sue parti intime senza pudore: il suo amante preferito è la cetonia dorata, più conosciuta come maggiolino delle rose: aggrappata ai petali, la cetonia apre ferite e squarci e spande il polline sulla parte femminile ricettiva del fiore.
E poi la viola, che come tutte le piante costrette all'immobilità dalle radici, deve saper attirare il partner, ingegnandosi in un vero e proprio gioco della seduzione. All'originalità della forma e dei colori, si aggiunge un profumo unico. Ma la cosa più sorprendente è di certo scoprire che la viola ha una doppia vita che si manifesta nelle sue due fioriture, una aperta al mondo e visibile ogni primavera, l'altra più clandestina e nascosta, sotto le foglie, durante l'estate: una nuova colonia di fiori senza petali che daranno vita a frutti e semi.
Dopo aver descritto fin nei minimi particolari la forma e le caratteristiche delle foglie e dei fiori di mughetto, Otte si sofferma sulla fecondazione che avviene grazie a insetti di piccola taglia, gli unici capaci di penetrare i piccoli fiori a forma di campanula, delicati e disposti a grappolo, di un colore bianco-neve, con impercettibili sfumature rosate. Questi piccoli insetti, mentre fecondano ogni fiore, vengono ricompensati con un alcol leggero di cui si inebriano a loro piacere.
Secco e spoglio, il caprifoglio pare in inverno quasi morto, ma dal momento in cui riprenderà vita, è l'olfatto a notarlo, prima ancora dello sguardo. Ed è nella dolcezza, nel carattere aggraziato, nell'intimità femminile dei suoi fiori che il caprifoglio rivela sua vera natura.
Solo quando cala la sera, quando le ombre si allungano, si fanno più spesse e sembrano cucirsi le une alle altre così da dar vita, come attraverso una serie di rattoppi, al mantello della notte, solo allora il profumo si diffonde in ampie scie, in folate sinuose a seconda dei capricci del vento. Questa suggestiva descrizione introduce l'arrivo dei visitatori della sera, le farfalle notturne, le sole dotate di una tromba che permette loro di penetrare nel tuo floreale, lungo e stretto, per attingervi il nettare, e, nello stesso tempo, di trasportare il polline, dai cinque stami sul pistillo.
E se l'impollinazione ha successo, il caprifoglio cessa quasi subito di emanare il proprio profumo, ritenendo ormai superfluo attirare altri pretendenti.
Sono, questi, solo alcuni esempi cui seguiranno l'ingegnosa violaciocca gialla, l'esotica vaniglia, il seducente lillà, la generosa lavanda, il garofano più selettivo, la mimosa ultrasensibile, l'enigmatica felce, il narciso pieno di sé di quali e quanti affascinanti misteri racchiuda in sé la sessualità del mondo vegetale. Una sessualità sconosciuta ai più, ma che vi invito a scoprire attraverso la lettura di questo libro.
Jean-Pierre Otte non ha semplicemente scritto un trattato di botanica ben documentato, ma ha saputo agire sull'anima e toccare il cuore parlando allo spirito.
È questa l'unica condizione per riscoprire i molti legami che l'uomo ha con la natura e per ritrovare un senso di serenità, di desiderio appagato e la consapevolezza che siamo esseri simili che esistono gli uni in funzione agli altri. (Lidia Gualdoni)
«La Gazzetta di Mantova»
14-05-2010
 Lionello Puppi
Lionello Puppi
Il re delle isole Fortunate e altre storie vere tra le "maraviglie dell'arte"
«Il Giornale dell'Arte»
01-09-2010
In compenso, in questo Il re delle Isole Fortunate lo studioso dimostra parimenti che l’esplorazione genera comunque un possesso diverso, il racconto delle mille vicende piccole, talora minime, tra aneddoto e «nuga», che il flusso grande della storia dell’arte porta morenicamente con sé, e che la insaporiscono come spezie preziose e rare. Storia è anche, forse soprattutto, narrazione. E come in un telero veneziano di quelli che Puppi molto ama il senso generale dell’insieme tende a porre in ombra la trama ricca dei mille dettagli, degli episodi marginali, degli accidenti che pullulano come controparte umanissima dell’evento potente che si mette in scena. Cosa accade, Puppi si chiede, se per una volta lo storico mette in parentesi il quadro grande e si concentra su questi dettagli, sugli accessori non superflui della storia principale e apparecchia il racconto, per il puro piacere, di queste sue indagini eccentriche e all’apparenza divaganti?
Accade, in primo luogo, che la qualità della scrittura ne esca distillata come non mai, divertita e divertente, punteggiata d’anacronismi voluttuosi, facendosi parte essenziale e decisiva, anch’essa protagonista, della narrazione stessa. E questo, come ognun sa e si trova ad auspicare inerpicandosi troppo spesso per saggi pensosi, metodologicamente (e talora ideologicamente) agguerriti ma allo stesso tempo figli di scritture desolanti, è dono lussuoso all’intelligenza del lettore. In secondo, che l’esposizione si dipani lasciando alle viste il suo backstage, quel «mestiere della ricerca» fatto di enigmi visivi affrontati affidandosi a un’indagine sulle fonti e sui documenti che a loro volta si rivelano ora lacunosi e frustranti (com’è come non è, quasi sempre si giunge a un passo dalla scoperta e il foglio cruciale manca, il documento svicola e si fa tenebroso, la fonte si fa reticente o elusiva) con il rischio, a proposito del quale Puppi continuamente mette sull’avviso, che si sia tentati di compensare la mancanza lavorando di pura fantasia, confidando in mitologie piccole e grandi, nascondendosi dietro la scenografia delle certezze in luogo di certezze non raggiunte.
La dichiarazione d’intenti Puppi l’affida, appunto, al re delle Isole Fortunate. Chi è costui? È uno dei pretendenti delusi che s’affaccia nel padovano «Sposalizio della Vergine» di Giulio Campagnola, dai tratti esplicitamente amerindi. Il meccanismo è micidiale. Perché a così pochi anni dai viaggi fortunati di Colombo (dieci, a un dipresso) una figura esotica così estranea alla pur cosmopolita cultura veneziana? Tra un’ipotesi e una conferma, tra un documento e un’intuizione, Puppi allinea la spedizione di Colombo del 1493, il suo sbarco spagnolo tre anni dopo con un carico di nativi ridotti in schiavitù, i re cattolici che si liberano dei bottino imbarazzante facendone dono alle potenze straniere, lo straniato amerindio che capita, per il tramite dell’ambasciatore Francesco Cappello, a Venezia, sino a ricevere un’ospitalità onorevole, per quanto possibile, giusto a Padova.
I propri intenti Puppi poi dipana in una sequenza di esercizi d’indagine saporosissimi, svarianti dall’invenzione di Filippo Calendario, genio fantomatico dell’architettura veneziana passato nei decenni da dogma storico a pura mitologia e a monito imperituro per tutti gli storici dell’arte, all’affaire milanese sulfureo e noir tra Orazio Vecellio figlio di Tiziano e quel geniaccio violento di Leone Leoni, dimostrazione perfetta che il commercio d’opere assume spesso tratti oscuri e indicibili, e che un’inchiesta delicata si poteva allora come ora insabbiare; dalla maledizione luttuosa che pare assediare la casa veneziana di Tiziano a Biri Grande, eliminandone ad uno ad uno gli inquilini che l’abiteranno dopo il maestro, allo strano caso dei fratelli van Veerle d’Anversa, moltiplicati e occultati in una ridda di pseudonimi che certo ne agevola i non limpidi traffici di quadri con Venezia.
Storie belle, storie che valeva la pena di raccontare, sono quelle che Puppi allinea in questa preziosa prova d’autore. Le storie dell’arte, una volta ancora, s’affiancano felici alla storia dell’arte. (Flaminio Gualdoni)
«Padova e il suo territorio»
01-06-2010
Si inizia proprio con il «re delle Isole Fortunate», il cui volto lo storico dell’arte Enrico Dal Pozzolo ha segnalato tra i personaggi affrescati da Giulio Campagnola nell’episodio dello Sposalizio della Vergine nella Scoletta padovana del Carmine (a sinistra di chi guarda, rispetto al supposto ritratto di Albrecht Dürer, l’amato maestro d’Oltralpe). Con un procedimento "indiziario", cui si attiene anche in seguito, Puppi allinea e incrocia testimonianze e cronache del primo Cinquecento, dai viaggi di Cristoforo Colombo agli Annali di Domenico Malipiero e di Marin Sanudo, per ricostruire il cammino tortuoso di un abitante dell’isola Hispaniola (ora Haiti), quasi sicuramente di rango elevato, portato (deportato) in Spagna nel 1496 dopo essere stato battezzato come Diego Colòn, donato ai sovrani Isabella e Ferdinando, che se ne disfano donandolo a Francesco Cappello, oratore della Serenissima; al suo arrivo a Venezia, il Senato decreta l’assegnazione del "selvaggio" al Capitanio della città di Padova, dopo di che se ne perdono le tracce, fatta salva quella rimasta sulla parete di un edificio sacro. «Nello sguardo, stupefatto e attonito, sgranato nel volto confidatoci da Giulio Campagnola, è impresso il lampo, come urlo strozzato, di un rimprovero senza fine» (p. 13): è il sigillo che Puppi imprime alla prima delle sue storie, I clamori e il silenzio, cui è affidata la funzione di "preludio", ma anche di campione delle storie che seguiranno, sicché il titolo antifrastico si rispecchia nella dedica che abbiamo citata (non sono fortunati i protagonisti delle storie, sono piuttosto sconfitti dalla Storia).
Nel rispetto dei "tempi" musicali, anticipati dal preludio che abbiamo riassunto, si apre quindi un primo movimento articolato in nove storie, cui segue un "interludio" (è la Breve conversazione con Palladio, nella tradizione dei Dialoghi dei morti di Luciano di Samosata e delle più recenti "interviste impossibili") e un secondo movimento con altre nove storie, sigillato da un Concertato finale. La struttura circolare del testo nel suo complesso è confermata proprio dalla lettura dell’ultima storia, divisa in due (La densità della Storia e la Fenice Nera), che torna al paesaggio di Haiti, trecento anni dopo: alla vicenda dell’indio arawak donato alla Serenissima e finito a Padova (quasi un preludio per strumento solista) succedono, nel primo la catena di rivolte e dittature, di liberatori divenuti tiranni (un "concertato per orchestra") nell’isola ormai ripopolata da schiavi africani, in sostituzione degli indigeni sterminati dai conquistadores, mentre nel secondo la tragedia individuale di un giovane haitiano, malato di nostalgia, ripropone l’assolo straziante di un amore impossibile finito in delitto tra i canali e i palazzi della Venezia di inizio Ottocento.
La varietà delle storie, già pubblicate in sedi diverse e disperse (dagli atti di convegni alle rubriche di riviste), si dispone tuttavia in un’evidente unità di disegno, senza che si percepisca sforzo, lasciando spazio, con Erasmo in Giappone, a un mirabile e svelto riepilogo di teoria del giardino, da quello claustrale a quello cortese fino a quello umanistico, per ribadire l’essenza dello «spazio assolutamente altro» del giardino (Rosario Assunto), ma anche del dialogo, come tipologia letterario-retorica, praticato da Erasmo e da Bembo (o Tasso) nel Cinquecento (giardino e dialogo forniscono insieme spazio fisico e forma logica allo scambio intellettuale). Il titolo del brano viene chiarito nel finale da funambolo che Puppi sfodera, passando dal commento del Convivium erasmiano alle vicissitudini di una statua lignea con l’effigie dell’umanista olandese, ritrovata nel tesoro di un tempio buddista giapponese dopo aver attraversato gli oceani attaccata come una polena alla prua di un veliero alla fine del XVI secolo!
Perdenti perfetti si potrebbero definire i protagonisti delle ultime storie: La statua di Napoleone racconta gli anni lontani, tra il 1809 e il 1814, dalla decisione della Camera di Commercio veneziana di erigere un monumento pubblico all’imperatore trionfante, affidato allo scultore Domenico Banti, al suo abbattimento dopo Waterloo, in odio al tiranno sconfitto, fino al recente ritrovamento del marmo celebrativo e al suo ritorno, in parte osteggiato, nelle sale del Museo Correr come oggetto d’arte: Il doppio inizia con un effetto di spaesamento per il lettore che assiste alla «seconda morte di Antonio Canova scultore» nel 1873 (più di 50 anni dopo la data del 1822, che si legge nelle biografie dello scultore di Possagno) e, subito dopo, fa la conoscenza con l’altro, appunto, cui toccò in (mala)sorte quel glorioso nome, senza essere in alcun modo parente, e quello stesso mestiere artistico, senza poter rivaleggiare con i capolavori, anche se, per legittimo diritto anagrafico, poté firmare le sue opere con quello stesso nome, che finì tuttavia per schiacciarlo: Dottor Jekyll e mister Hyde riprende una tesi di laurea (di Raffaella Gava) su Giuseppe Marino Urbani de Gheltof, nato a Padova nel 1856 e morto a Firenze (nel manicomio di Montelupo) nel 1908, dapprima geniale scopritore e, in seguito, falsario di documenti storici (in un’epoca nella quale si fabbricavano con perizia anche capolavori della pittura di "primitivi toscani" per facoltosi collezionisti, americani ma non solo): ne seguiamo gli ultimi penosi spostamenti, le visite a biblioteche e archivi, i tentativi di impossessarsi di documenti o di duplicarli e rivenderli, fino all’arresto, al ricovero, alle terapie devastanti (fisiche allora, più che chimiche) che suggeriscono al lettore di unirsi alla pietas del narratore.
Resta da accennare brevemente allo stile inconfondibile di Lionello Puppi, partendo dalla sintassi obiettivamente complicata, ma stimolante, quando non si allea a frasi parentetiche, incisi o precisazioni variamente segnati o interpuntati che hanno un effetto ritardante se non perturbante, costringendo il lettore a tornare sulle righe già percorse. E dire che per non appesantire il testo, Puppi ha eliminato le note, conservando in genere i rinvii agli autori citati: e per non aumentare il prezzo del volume ha sacrificato l’iconografia, togliendo in questo modo al lettore la facoltà di controllare storie che hanno essenzialmente a che fare con immagini! Se alcune marche lessicali, come il ritorno di parole cui Puppi è affezionato («impalcare, impalcarsi»: pp. 27. 28, 33... 178, 179), alcune costruzioni arcaizzanti («di pezzi si tratta animati»: p. 28), stanno tra il vezzo e un sigillo autoriale, a volte sembra di cogliere l’eco di una vera e propria riscrittura à-la-manière-de, come nell’arioso incipit dell’ultima storia: «Per un buon tratto, il nastro d’asfalto, approssimativo e sconnesso da crepe larghe e profonde, che congiunge Port-au-Prince a Cap-Haïtien, asseconda la costa dell’ampio golfo di Gonalves, bordata di mangrovie la cui cupa cortina talora cede, o si spezza, permettendo allo sguardo di spaziare, per un momento breve, sull’azzurro intenso e limpido d’un mare ch’è lo stesso del cielo purissimo, così da consentir di percepire la linea d’orizzonte solo là dove il guizzar d’argentate inquietudini luminose interrompe l’immobilità rovente d’una concava parete vegetale infinita» (p. 171). E certamente un omaggio alla descrizione tra lago, monti e fiume di Manzoni ma anche un accordarsi al tonificante respiro del paesaggio subtropicale prima di reimmergersi, trattenendo il fiato, nell’incubo delle tragedie umane disseminate nella Storia. (Luciano Morbiato)
«Il Giornale di Vicenza»
18-05-2010
«L'Arena»
14-05-2010
«www.drammaturgia.it»
07-05-2010
Sapientemente, per l’ennesima volta, Lionello Puppi conduce il lettore tra le ridolfiane «maraviglie dell’arte» (e non solo). Meraviglie e altre questioni, dunque, che egli, in questo volume, svela nel segno d’una felice vena narrativa appesa al gusto per l’inchiesta archivistica raffinata; caratterizzata poi, in sede esegetica, da una non comune finezza interpretativa come da un respiro culturale ampio e da un impianto saldamente storico-filologico. Un approccio storiografico documentale e multilineare declinato in modo lenticolare, anzi 'poliziesco', alla maniera del detective Abilio Quaresima. Con l’instancabile commissario P. (la calzante definizione è di Giandomenico Romanelli) implacabilmente curioso, come lui stesso dice, nel «rovistar tra le carte» (p. 150), a caccia com’è di labili tracce per restituire spessore di vita a uomini, eventi e 'casi', avventure e sventure, architetture, dipinti e sculture, committenti e artisti, collezionisti e faccendieri d’arte (e così via). Casi, dicevo, sin’ora irrisolti, delitti inclusi: si pensi all’inquietante vicenda del prediletto figlio di Palladio, Leonida, dapprima omicida e poi, forse, assassinato per vendetta (La vendetta dei Camera, pp. 85-91). Oppure casi sconosciuti, talvolta apparentemente insignificanti ma invece, a ben guardare, rivelatori se indagati con senso vivo della storia come fa Puppi.

Perciò le pagine del Re delle Isole Fortunate mettono in valore anche dettagli persino minimi. L’ispezione delle fonti fa scattare nell’investigatore la scintilla interpretativa spesso decisiva per risolvere o problematizzare correttamente i tanti enigmi. L’osservazione individuale, paziente e minuziosa, della fisicità del 'reperto', d'altronde è basilare: Freud e Holmes ci hanno insegnato come (e quanto) gli 'scarti', gli indizi impercettibili ai più, i dati apparentemente secondari possano essere spie rivelatrici del sapere indiziario. Il «buon Dio sta nei dettagli», asseriva Warburg sulla scia di Flaubert. In breve: Puppi esercita il mestiere di storico. E lo esercita a tutto tondo, capace com’è d’abbattere gli steccati disciplinari per dar vita a una storia dell’arte sempre tenacemente contestuale, mai svilita dall’egemonia dei lambicchi formali. E piace qui convocare un altro volume del medesimo studioso. Alludo a Verso Gerusalemme (1982), la cui Premessa costituisce a tutt’oggi un viatico metodologico prezioso per investigare perduti orizzonti artistico-culturali in una dimensione multidisciplinare che ambisca a una storicizzazione integrale degli oggetti indagati. È che Lionello Puppi pone la storia al servizio dell’arte. Da qui l’attenzione ricorrente al contesto, alla nozione di progetto culturale, al fondamentale capitolo della committenza; o, ancora, la capacità di far interagire piccole storie e grande Storia; storia dal 'basso' e storia dall’'alto, storia delle marginalità, storia dei prediletti vinti. Quei vinti che del Re delle Isole Fortunate sono i veri protagonisti.
Si ricordi l’avvincente interpretazione della procurata morte del talentuoso pittore Francesco dal Ponte, 'costretto' al suicidio in Venezia dall’ombra minacciosa e onnipresente della figura paterna (Lo specchio e la bacchetta, pp. 107-117). Narrazione cui segue, con coerenza narrativa, la veridica storia della scena di quella tragedia: dico l’inquietante ex residenza e officina di Tiziano al Biri Grande, poi casa del dal Ponte, da un balcone della quale il fragile tormentato Francesco, autore di un memorabile ritratto di Palladio da vecchio (fig. 1), si gettò «per frenesia» nel 1591 (La casa stregata al Biri Grande, pp. 119-124). O, ancora, si leggano le storie del pittore e accademico Filarmonico Felice Brusasorzi, l’infelicissimo uomo delle tre donne (Felice nella miseria, pp. 125-130), o dello sventurato storico Giuseppe Marino Urbani de Gheltof deceduto, dopo molto penoso vagabondare, nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino (Dottor Jekyll e mister Hyde, pp. 161-168) e finalmente in parte riabilitato, con intelligenza critica e umana pietà, dallo studioso.

Deprivare il lettore del gusto della scoperta sarebbe ingiusto. Basti proporre un’ultima 'campionatura', privilegiante il punto di vista dello storico dello spettacolo che svaria, nelle pagine che presentiamo, dalla narrazione del recupero in luogo sorprendente di un sorprendente oggetto dell’effimero quale l’effigie d’Erasmo scolpita per l’ingresso trionfale a Rotterdam nel 1549 del futuro Filippo II (Erasmo in Giappone, pp. 25-35); alla rievocazione della giostra organizzata da Bartolomeo d’Alviano a Padova nel 1515 in Pra’ della Valle (Il cavaliere dimezzato, pp. 37-43), «sì per dar solazo e piacer a tutti come exercitar et accender la gente d’arme» (così Marin Sanudo); sino alla convincente ricostruzione di un fallimento teatrale illustre (pp. 75-83, Una lunga notte per un fiasco). Dico la rivisitazione della messinscena promossa a Venezia nel carnevale 1565 dall’aristocratica Compagnia della Calza degli Accesi. Allestimento che vide impegnati l’accademico Olimpico Andrea Palladio, il medico-drammaturgo Conte da Monte (Antonio Pigatti) e il pittore Federico Zuccari in uno spettacolo ambizioso del cui esito concreto poco o male si sapeva; e che Puppi, con l’ausilio di un recuperato testimone oculare amico di Palladio, Fabio Monza, giudica a ragione «un fiasco colossale» (p. 82). Un insuccesso, dunque e persino clamoroso, la recita in laguna dell’Antigono di Conte da Monte nello spazio teatrale impalcato per l’occasione da Palladio e ubicato, con ogni probabilità, nei pressi di palazzo Foscari a San Simeon piccolo (fig. 2).
Una sconfitta artistica condita d’insulti, probabilmente procurati ad arte dall’attore protagonista, il performativo «Gobbo dell’Anguillara», per indispettire l’intellettuale autore della tragedia. Eppure quell’evento contestato (la «tragedia fu recitata male et per il Gobo furno fati di molti errori», scrive il diarista Monza) resta, stimo, una tappa cruciale per comprendere la diuturna idea di teatro palladiana, culminante nell’enigmatica scenafronte dell’Olimpico di Vicenza (fig. 3). Quell’Olimpico che Puppi elegge, nell’Interludio di questo suo libro (pp. 95-98, Breve conversazione con Palladio), a sede di un memorabile «appuntamento» virtuale tra il commissario P. e un Palladio ormai vecchio, con la fronte «solcata da qualche ruga […] dilatata dall’ampia pelata del capo» e con lo sguardo d’un «azzurro profondo». Un azzurro, aggiungo, di schietto sapore autobiografico, che abbiamo imparato a guardare sino dalla monografia dedicata dallo studioso nel 1997 alla Giovinezza di Palladio, nella quale Andrea si congedava dal lettore stropicciandosi gli occhi «a coprirne, per un lungo momento, la limpida luce d’azzurro» (p. 129). Lascio, infine, la parola a Puppi e al suo alter ego prediletto, Palladio. Quest’ultimo è «seduto all’estremità del gradone inferiore della cavea, a ridosso dell’orchestra. Il suo sguardo è concentrato sul monumentale proscenio, e sembra perplesso. […] “Ben tornato, Maestro”, lo apostrofo. Sobbalza. “Sono tuttavia di fretta”, mormora; e sembra quasi un sospiro. Non è incoraggiante, Palladio» (p. 95). Questo l’incipit di un sogno della storia che mette a colloquio il maestro patavino con il suo studioso principe, autore della più importante monografia palladiana del secolo che ci è alle spalle. E se ne ascoltano delle belle, in quel privato appuntamento. A partire da un’amara constatazione palladiana rivolta ai posteri: «“Millantatori. Nulla hanno inteso”». E ancora: «“cosa vedo intorno a me, adesso? La scancellatura, la cassatura deliberate della memoria per erigere sulle sue polveri […] stramberie senza ordine e ragione.

Concludo rammentando, con Fernando Pessoa, che le «isole fortunate, / sono terre che non hanno luogo, / dove il Re vive aspettando. / Ma se vi andiamo destando / tace la voce e solo c’è il mare». Chissà cosa ne avrebbe pensato il fratello dell’orgoglioso Re d’una delle Isole Fortunate, l’amerindo appellato abusivamente dai vincitori Diego Colón dono esotico dei sovrani di Spagna alla Serenissima che poi, nel 1497, dislocò costui a Padova. Perciò Giulio Campagnola lo vide, lo ricordò e quindi ne dipinse il volto, sparuto e diverso, tra i personaggi-cornice del suo Sposalizio della Vergine affrescato nella patavina Scoletta del Carmine. È questo il Preludio (I clamori e il silenzio, pp. 9-13) del volume di Puppi. Un volume che dà voce a storie di uomini infelici, la cui memoria è stata troppo a lungo celata, smentita e manipolata, ma che è ora finalmente resa alla luce dal tenace e suadente Uomo degli Archivi. (Stefano Mazzoni, presentazione del libro in occasione dell'Adunanza pubblica dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed arti in Padova, 7 maggio 2010).
«Il Piccolo»
05-05-2010
«Il Gazzettino»
16-03-2010
 Ulderico Munzi
Ulderico Munzi
Il Generale
«Lettera.com»
15-01-2011
«Il Giorno - Il Resto del Carlino - La Nazione»
28-02-2010
Perché una lapide con un altro nome, senza data di nascita e di morte? Perché Roatta è ingombrante anche da morto, pericoloso come una mina vagante per le cose che sapeva, e che probabilmente, almeno in parte, non sono state ancora dette: «È uno scheletro che dà fastidio e che si preferisce buttare in un ripostiglio», commenta Munzi. Il libro inizia con l’agguato in cui caddero i fratelli Carlo e Nello Rosselli, il 9 giugno 1937, in Francia. L’assassinio era stato deciso da mesi, fin dall’autunno precedente: Mario Roatta aveva spiegato a Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri e genero del Duce, che il suo servizio (il SIM) sapeva benissimo come eliminare il fondatore di Giustizia e Libertà, «un terrorista, un intellettuale pronto ad uccidere». Il destino di Carlo Rosselli era segnato. Munzi ha interrogato a questo riguardo il figlio del Generale, l’ingegner Sergio Roatta, che gli ha detto: «Mio padre è innocente, non era più il capo del SIM quando furono uccisi i fratelli Rosselli. Del resto ogni accusa è stata cancellata dai processi che si svolsero dopo la condanna all’ergastolo da parte dell’Alta Corte». L’autore ha utilizzato molte fonti. Ne esce uno spaccato affascinante, e angosciante, della realtà dell’epoca. Ad esempio quello evocato da una fonte misteriosa, un certo R., che ha raccontato di un probabile accordo stipulato nella notte tra 8 e 9 settembre 1943 tra Kesserling, comandante delle truppe tedesche, e Badoglio: il progetto era quello di offrire Roma alla Wehrmacht, in cambio della fuga dei Savoia e dei comandanti delle Forze armate... (Giovanni Serafini)
«Il Secolo d'Italia»
21-01-2010
«Il cuore di tenebra del fascismo», lo ha definito Dino Messina sul Corriere. E annota Gianfranco Fini in quarta di copertina: «Tra spionaggio, guerre e congiure, il generale Mario Roatta, uno dei protagonisti dei giorni bui del l943, torna sulla scena». Ormai del resto gli anni sono passati, ma dopo la guerra, quando lui fuggì avventurosamente in Spagna – con l’aiuto del Vaticano – per sottrarsi ai processi, vi fu un’ondata di indignazione generale. Successivamente fu amnistiato da Togliatti, nel l946, e qualche anno dopo poté ritornare a Roma indisturbato, dove morì nel l968. Pochi lo registrarono.
Munzi non racconta come visse in Italia il generale sino alla sua morte (probabilmente con la pensione di ufficiale), ma denuncia però il fatto che Roatta si era reso conto di tutto, di quell’8 settembre, dello scellerato patto di Badoglio con i tedeschi che prevedeva via libera su Roma in cambio di salvacondotto per il re, la famiglia, Badoglio e i paparazzi dello Stato maggiore, tutti in fuga dalle proprie responsabilità. Sì, Roatta sapeva questo e altro. E non è vero che non aveva emozioni, come si disse, le aveva invece, di profondo disprezzo per chi non aveva la sua stessa concezione di servitore dello Stato, ma le tenne sempre per sé, da buon agente segreto. Munzi nelle sue pagine fa spesso pensare il Roatta, riflettere, commentare, ed è chiaro che qui si va nel campo del romanzo storico. Però... però. A giudicare da tutto quello che è successo e da come sono andate le cose, risulta che Roatta la pensasse proprio così come Munzi ce lo desccrive nelle sue accurate pagine.
Ma chi è stato, quindi, questo Roatta? Uno che odiava i tedeschi, o forse solo i nazisti. Ne dette prova nei Balcani, in Croazia, quando fece di tutto per opporsi sul territorio alla Wehrmacht, giungendo anche a salvare la vita a moltissimi ebrei, non si sa se per spirito umanitario o per dispetto. Tra le più gravi accuse che pendono sul suo capo, è quello delle atrocità commesse dagli italiani in Croazia, proprio sotto il suo comando. Vero o non vero, va rilevato che quei popoli non sono molto teneri, né con sé stessi né con gli altri, come abbiamo potuto riscontrare nella recente guerra di Bosnia (l995). Chi scrive è poi figlio di un ufficiale medico italiano di stanza nel Balcani dal l940 al '43, ufficiale medico che più di una volta si è trovato a dover identificare pattuglie di italiani prese dai partigiani titini. Si, identificare, perché a tutti mancava la testa. L’altro grande capo d’accusa su Roatta è il vero o presunto omicidio dei fratelli Rosselli, Carlo e Nello, uccisi in Francia da attivisti di un movimento di estrema destra d’Oltralpe. Non sfugge a nessuno, come anche nota Ulderico Munzi, che il compito di un servizio segreto nazionale è quello di difendere lo Stato e il governo. Ora, è noto a tutti che Carlo Rosselli era una bella figura di ideologo armato, uno che avrebbe sparato a Mussolini se l’avesse incontrato per la strada, uno che cercava un pilota per bombardare Villa Torlonia, con dentro non solo Mussolini, ma anche la sua famiglia e i servitori. Quale servizio segreto non l’avrebbe fatto fuori prima che lui compisse un attentato terrorista? Tornando alla Croazia, sappiamo bene tutti che negli anni Settanta e Ottanta l’Europa, ma in particolar modo Germania e Francia, furono insanguinate da esecuzioni politiche (in tempo di pace) da parte dei servizi titini nei confronti di nazionalisti croati fuoriusciti. Cia e Kgb hanno fatto altrettanto per oltre mezzo secolo. E di cosa ci scandalizziamo? E poi, la moglie e il figlio di Roatta, a tutt’oggi, negano il coinvolgimento del loro congiunto nell’affaire Rosselli.
Ulderico Munzi insomma ha chiarito l’ultimo dubbio degli storici, sul perché Roatta sia stato lasciato in pace in tempo di epurazioni e di esecuzioni sommarie contro i fascisti: perché Palmiro Togliatti e Mosca erano aversari dei fratelli Rosselli, esponenti di un movimento, Giustizia e Libertà, non allineato con Mosca. A volte la storia è più semplice di quanto si creda. Basta solo avere il coraggio di guardarla in faccia. (Antonio Pannullo)
«Corriere della Sera»
17-01-2010
Le cose andarono così, o almeno così ce le racconta con rara efficacia Ulderico Munzi, per vent’anni, dal 1986 al 2006, giornalista al «Corriere della Sera», inviato, corrispondente da Parigi e assiduo collaboratore delle nostre pagine culturali. Cronista di razza, Ulderico Munzi ha una prosa veloce, precisa, penetrante, qualità che mette al servizio della sua passione per la storia. Ne ha dato prova nel Romanzo del Rex e in altri libri usciti da Sperling & Kupfer, lo conferma oggi in questa biografia in forma di «récit», Il Generale, dedicata a una delle figure più controverse della storia italiana: Mario Roatta. Capo del Sim nel '34, durante la guerra d’Etiopia si vantò di aver ingannato la stampa internazionale che accusava l’esercito italiano di aver usato gas vescicanti, poi fu protagonista della disfatta di Guadalajara nella guerra di Spagna. Eppure sempre agli apici delle imprese fasciste: nel ’42 al comando della II Armata in Croazia, nel ’43 della VI in Sicilia, a giugno di quell’anno capo di stato maggiore sino alla fuga da Roma con il re e Badoglio. Nel dopoguerra il processo, la condanna, la clamorosa fuga in Spagna, l’amnistia, il ritorno in Italia nel 1966 e la morte nel '68. E sepolto a Roma in una tomba sotto una lapide che porta un altro nome. Una figura ingombrante anche da morto. Munzi non giudica, racconta con passione, svela i segreti, restituendoci l’intelligenza, la freddezza e l’ ignominia di questo «cuore di tenebra» all’italiana. Da leggere. (Dino Messina)
«Il Giornale di Brescia»
05-01-2010
Uomo imprendibile, lucido e razionale, Roatta che parlava sei lingue compreso l’arabo ed era ritenuto l’artefice del delitto di Carlo e Nello Rosselli, attuò in Croazia una sorta di pulizia etnica, ma allo stesso tempo si adoperò per salvare degli ebrei. Dalla serie d’indagini che lo scrittore e giornalista Ulderico Munzi ha compiuto per poter scrivere la biografia de Il generale salta fuori un Roatta costruito come si costruisce un personaggio di romanzi che spesso hanno un carattere informativo, veritiero e verosimile.
S’è tentato di puntare il riflettore sulla maschera romanzesca del nostro eroe. Un eroe negativo secondo alcuni punti di vista. «Sono un militare dell’esercito e da militare agisco» diceva spesso per giustificare il suo comportamento. Finita la guerra, la Corte di Giustizia dell’Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo tentò di processare e condannare il Generale per proteggere i veri responsabili dell’8 settembre. Roatta conosceva i termini e gli accordi della disfatta italiana e più d’una persona aveva interesse a chiudergli la bocca. Ma lui, il 4 marzo 1945, riuscì a evadere e a rifugiarsi in Spagna. E lì restò protetto dal dittatore Francisco Franco che in realtà non amava «quel generale scintillante d’acume, dal fare irriverente e disposto a tutto». In seguito fu assolto dallo Stato italiano senza che avesse mai ammesso una colpa e si fosse pentito, e il ministro comunista Palmiro Togliatti, «nemico dei Rosselli ed ex agente dell’Nkvd sovietico», lo incluse nell’amnistia del 22 giugno 1946. Nel 1966 dalla Spagna tornò in Italia da libero cittadino. Nel 1968 morì all’età di 81 anni.
Munzi, come mai Roatta è riuscito «a sfuggire» alla storia?
Ci sono due ipotesi da fare. La prima è che l’abbiano murato vivo in una sorta di dimenticatoio. La seconda ipotesi è lo spettro dell’8 settembre. Far riemergere dall’oblio Roatta voleva dire rimettere in discussione tutto quanto si è detto sull’8 settembre. L’inquinamento politico nasce in quei momenti che avrebbero dovuto essere gloriosi, e Roatta dà fastidio perché condivideva la versione dell’accordo tra Badoglio e il comandante delle forze tedesche del Centro Sud, Kesserling.
Che cosa prevedeva l’accordo?
Il tedesco promise di far scappare i Savoia e i papaveri delle forze armate se lasciavano Roma in pasto alla Wehrmacht. Roatta sapeva questi segreti, e perciò era pericoloso.
Se Roatta avesse detto la sua verità sull’8 settembre, cosa sarebbe successo?
Si sarebbe capito che l’8 settembre non fu soltanto il crollo dell’Esercito italiano abbandonato a se stesso, ma anche l’inizio di tutto ciò che di sporco oggi c’è in Italia. Roatta sapeva quello che era accaduto veramente perché era un uomo dei servizi segreti, e sapeva anche i retroscena della flotta italiana che fu abbandonata a se stessa. Era l’unica cosa che funzionasse all’epoca anche se era stata bastonata dagli inglesi, ma era composta da navi eccezionali e Raffaele De Courten che era complice di Badoglio non dette gli ordini necessari. Se Roatta avesse parlato, avrebbe messo in crisi i Governi dell’Italia che stava rinascendo.
Come riuscì a sfuggire ai processi e al castigo?
Roatta è stato processato, ma poi i processi sono stati annullati e in seguito ha avuto l’amnistia, ma era perseguitato dagli slavi. Tito voleva Roatta per punirlo dei crimini di guerra commessi in Jugoslavia, e se l’avessero preso prima della fuga in Spagna l’avrebbero fatto fuori senza pensarci due volte. Quando rientrò in Italia erano intervenuti degli accordi con Tito, ed erano anni ormai che i comunisti chiamati lupi rossi erano caduti in letargo.
Le colpe che gli si addebitano, tutte vere a cominciare dall’assassinio dei fratelli Rosselli?
Il mio non è un libro di storia rigoroso, ma si attiene alla verità. Carlo Rosselli era un ideologo armato, un uomo d’azione pericolosissimo, il migliore tra i fuoriusciti, e pensava di bombardare Villa Torlonia. Andava alla ricerca di un pilota per compiere la sua impresa e forse l’avrebbe trovato sempre che non fosse stato già comprato dai fascisti. Ma i fascisti non erano i soli a dargli la caccia. C’erano anche i comunisti che volevano farlo fuori perché era odiato da Togliatti e dal Comintern, e suo fratello Nello che morì insieme a lui fu una vittima collaterale. Il delitto fu compiuto da uomini della Cagoule, un movimento di estrema destra, mortale nemico di ebrei e comunisti, fu una furbata. Il Sim non si sporcava le mani fino a quel punto e per questo incaricò dei sovversivi francesi di destra.
Il Sim fu fondato da Roatta?
Il Sim esisteva prima del regime e fu perfezionato da Mussolini che voleva un servizio d’informazione militare in concorrenza con gli altri servizi tra i quali l’Ovra. Il Sim si mosse con una spietatezza capillare e Roatta fu fedele esecutore della volontà del dittatore.
Perché nel libro definisce Roatta «il cuore di tenebra» dell’italianità?
Perché Roatta non aveva stati d’animo né debolezze dal punto di vista spirituale: era un uomo che cercava di uscire dal male dei sentimenti ogni volta che rischiava di caderci dentro, e amava solo la madre francese che morì in tardissima età.
Esistono documenti di Rotta ancora inediti?
Sono molto importanti ai fini della comprensione storica i suoi taccuini, posseduti da un figlio ancora vivente, Sergio Roatta, che deve avere un armadio pieno di documenti ma si rifiuta di parlare. O farà un libro molto rigoroso o distruggerà tutto. (Francesco Mannoni)
«Il Giornale di Vicenza»
21-12-2009
Ecco perché Munzi rispolvera il generale Roatta, «per la sua modernità di uomo dell’ombra, di militare intessuto di grandi qualità diplomatiche, di uomo che incarnava perfettamente una mistura di duplicità e spietatezza».
Ma che uomo era, Mario Roatta? Munzi non usa mezzi termini: uno che ne sapeva una più del diavolo, che è riuscito a tenere un basso profilo al punto «di farsi perfino dimenticare dalla storiografia, un po’ come se si fosse nascosto in una delle tante caverne insondabili della storia recente del nostro paese. Le caverne degli anni Trenta-Quaranta, dove gli storici, spesso politicizzati, esitano a penetrare».
Nessun libro era stato scritto finora su Mario Roatta, avendo agito spesso da dietro le quinte pur essendo interprete della storia. La stessa storia al giudizio della quale abilmente il generale è riuscito a sottrarsi, malgrado le vicende che lo videro protagonista di azioni spregiudicate e cruente nei massacri di militari, partigiani e civili, responsabile di operazioni come l’assassinio dei fratelli Rosselli di Giustizia e Libertà (ma la moglie Ines Mancini e il figlio Sergio smentiscono un coinvolgimento del loro congiunto in questa vicenda) e della pulizia etnica di partigiani e civili in Croazia nel 1942. Per definire l’uomo, basti ricordare che viveva costantemente con il mitra a tracolla, condannato per effetto dei suoi stessi atteggiamenti a non fidarsi di nessuno, nemmeno dei fedeli camerati.
La stagione del generale si chiude con l’8 settembre, quando scappa su una nave militare assieme a Vittorio Emanuele III e al generale Pietro Badoglio. Un personaggio, Roatta, che è riuscito abilmente a sottrarsi al giudizio, malgrado la sua figura di protagonista assoluto. Il libro di Munzi è una autentica riscoperta di un inquietante protagonista in tanti anni della storia d’Italia. (F.B.)
«La Stampa»
20-12-2009
Era un uomo spietato e contraddittorio, e soprattutto era una delle memorie del fascismo, per conto del quale aveva rifondato il Sim, il servizio segreto militare, facendone fin dal '34 una macchina ben oliata e temibilissima. Uomo dai troppi segreti, si preferì lasciarlo andare. È morto a Roma nel ’68, ormai in parte assolto e in parte amnistiato, portando parte di quei segreti con sé. E, curiosamente, è anche riuscito a sfuggire agli storici, che l’hanno in genere trascurato, come osserva Ulderico Munzi presentando al lettore il suo libro a lui dedicato. Il Generale figura stampato in una collana di narrativa, ed è in effetti un’opera a più facce. L’autore lo definisce un récit, un racconto, e non «un libro di storia». Dalle pagine emerge un uomo freddo, spietato, abilissimo. L’inquietante Generale viene messo in sce- na, fatto rivivere con gli strumenti della narrazione, analizzato nella sua psicologia attraverso Ie sue stesse parole (affidate a un’autobiografia) e quelle di coloro che lo hanno conosciuto.
Tra i testimoni c’è anche una misteriosa «fonte», di cui non si fa il nome, che, riferisce Munzi, ritiene molto probabile uno scambio tra il Maresciallo Badoglio, capo del governo, e il Feldmaresciallo Kesserling, comandante delle truppe tedesche in Italia, per garantire la fuga verso Brindisi della Corte e dei generali. In cambio la Wehrmacht ebbe in pasto la città eterna. L’autore diffida delle fonti, «fredde e talora menzognere», ma se questa persona senza volto dicesse il vero basterebbe a spiegare quanto la figura di Roatta, nei giorni dell’armistizio, fosse non solo imbarazzante, ma anche pericolosa. C’era un criminale di guerra ben peggiore di lui - osserva - e si chiamava Badoglio. Lo spunto è interessante, e c’è da auurarsi, come fa Munzi, che possa trovare lo sviluppo che merita in sede storica. (Mario Baudino)
«Il Piccolo»
21-11-2009
Ne sapeva una più del diavolo, Mario Roatta. Al punto che è riuscito a farsi dimenticare perfino dagli storici. Pochi i libri su di lui. Pochissimi gli studiosi che sono andatia ricostruire, senza fermarsi ai "si dice", la sua vita. A tirarlo a forza fuori dall’ombra ci ha pensato Ulderico Munzi, che è stato inviato speciale per la "Nazione" e per "Il Resto del Carlino", firma delle pagine culturali e corrispondente da Parigi per il "Corriere della Sera", e che adesso collabora alla "Stampa". Ma il suo libro Il Generale, pur senza discostarsi da una meticolosa ricerca storica, non è un saggio. L’autore preferisce definirlo all’inglese "novel", perché si è permesso di ripercorrere la vita di Roatta con uno stile narrativo.
E c’è di più. Per capire davvero chi era Roatta, Munzi si è basato anche sulla testimonianza di una misteriosa "fonte R.". Secondo cui, nella notte tra l’8 e il 9 settembre 1943, un accordo tra il feldmaresciallo Kesserling, comandante delle truppe tedesche, e il marescialo Badoglio, avrebbe segnato pesantemente la storia d’Italia. Perché quel patto prevedeva che Roma fosse data in pasto alla Wehrmacht in cambio di una tranquilla fuga dei Savoia e dei papaveri delle Forze Armate.
E se la "fonte R." fosse Sergio, il figlio di Roatta, che conserva tutte le carte del padre, ma non ha mai voluto parlare? Ulderico Munzi, è chiaro, non conferma. «Leggendo un vecchio libro di Ruggero Zangrandi mi è venuta la voglia di scavare nella vita di Roatta – spiega Ulderico Munzi –. Mi affascinavanon tanto l’aspetto demoniaco della sua personalità, quanto quello luciferino».
Luciferino?
«Roatta era un militare tutto d’un pezzo. Lui non credeva tanto nella Patria, ma nel dovere: la sua divisa militare valeva, per lui, quanto la sua anima».
Non assomigliava molto agli altri generali italiani?
«Era molto intelligente. Conosceva sette lingue, compreso l’arabo. Le colpe di tutti i guai dell’esercito italiano ricadono sugli alti gradi, su chi comandava. La disfatta di Caporetto non può essere di certo imputata ai poveri fanti».
Roatta finì sotto processo, Badoglio no...
«Roatta sapeva la verità. Il suo arresto fu una specie di commedia, come racconto nel libro. In realtà si consegnò. Lui avrebbe voluto parlare dell’8 settembre, di quello schifoso accordo tra Badoglio e i nazisti, ma i giudici non erano disposti ad ascoltare la sua verità. A loro interessava l’omicidio dei fratelli Rosselli e altre accuse che pendevano su di lui».
Possiamo dire: siamo figli delle schifezze accadute l’8 settembre 1943?
«Il mostro storico dell’8 settembre ha partorito, come un Alien, l’Italia di oggi. Noi siamo gli eredi di quel terribile "inciucio". E chi oggi sta nei palazzi del Potere è direttamente legato a chi allora ha permesso quella schifezza».
Roatta diede o no l’ordine di ammazzare Carlo e Nello Rosselli?
«Prima bisogna chiarire una cosa: Carlo Rosselli, con sua moglie Marion, era una sorta di Indiana Jones dei fuorusciti antifascisti italiani. Se avesse incontrato per strada Benito Mussolini, credo non avrebbe esitato a sparargli addosso. Era un uomo d’azione, un ideologo armato. E logico che il Sim, il servizio segreto militare diretto da Roatta, doveva cercare di fermarlo».
E allora?
«A Roma sapevano che Rosselli voleva noleggiare un aereo e bombardare Villa Torlonia. Non potevanon essere ucciso. Roatta ha detto, questo è certo, che il capo di "Giustiziae Libertà" doveva morire. Se l’avessero rapito sarebbe scoppiatouno scandalo internazionale».
E allora entrò in azionela Cagoule?
«Erano perfetti gli uomini della Cagoule. Una società segreta terroristica francese di estrema destra di cui faceva parte anche il futuro presidente socialista della Francia, François Mitterand. Chi avrebbe potuto trovare le connessioni con l’Italia? Non si arrivava facilmente ai veri ispiratori dell’assassinio. Così venne orchestarto quel delitto orrendo, voluto da gente come Galeazzo Ciano e Filippo Anfuso».
Perché Ciano temeva tanto Rosselli?
«In realtà, Ciano sperava di diventare il successore di Mussolini. E uno come Rosselli faceva paura. Se gli fosse stato consentito di vivere, dopo il crollo del fascismo poteva diventare lui il vero leader democratico d’Italia. Credo che Giustizia e Libertà sia quanto di meglio abbia prodotto l’antifascismo».
Ma l’ordine partì dal generale?
«Non fu Roatta ad andare in Francia a prendere contatto con gli uomini della Cagoule. E non fu lui a consegnare ai terroristi i 100 fucili mitragliatori pattuiti».
Roatta aveva sulla coscienza i campi di concentramento della "Balcania", come la chiamavano ai fascisti.
«Era un militare e ha fatto il suo mestiere. Purtroppo il "buonismo" applicato ai tempi di guerra non ha senso. Certo, io non posso approvare i gas usati dagli italiani per combattere i libici, gli etiopi. Per conquistare le colonie. E nemmeno i campi di concentramento. Però è ovvio che il colonialismo non aveva pietà: quello inglese come quello francese. Egli italiani non si differenziavano».
Le persone morivano di fame, divorate dalle zecche...
«Non c’era pietà. La purificazione etnica, allora, era uno dei cardini su cui si basava la dominazione italiana, ma anche quella tedesca, nei Balcani. La frase "Si ammazza troppo poco" ha un senso terribile: se i partigiani catturavano i soldati italiani, non andavano troppo per il sottile. Li torturavano, li ammazzavano. Per questo bisognava ammazzare di più».
Poi sono venute le foibe.
«Le foibe sono l’altra faccia della medaglia. Sono un’altra manifestazione dell’odio che si scatenò durante le guerre. E che non fece sconti a nessuno».
E il mito degli "italiani brava gente"?
«È assurdo pensareche gli italiani in Slovenia, in Croazia, potessero evitare di comportarsi da militari. Ripeto: erano in guerra. E gli ordini dicevano, chiaro e tondo, di eliminare chi si opponeva alla conquista dei Balcani».
(Alessandro Mezzena Lona)

Effetto Darwin
«guide.superEva.it»
01-10-2009
«Almanacco della Scienza»
23-09-2009
«Il Giornale di Vicenza»
11-07-2009
 Isabelle Miller
Isabelle Miller
Capolavori incompiuti
«Lettera.com»
10-12-2010
Ma questa è soltanto la storia di una delle undici opere incompiute di cui il volume ci svela le trame. Nelle altre si narra di come Giacomo Puccini affidò ad Arturo Toscanini quella Turandot che non ebbe mai il tempo di terminare, del film incompiuto ma "perfettamente concluso" di Jean Renoir e Pierre Braunberger Una gita in campagna, del trentesimo film di Marilyn Monroe Something's Got to Give di cui il pubblico può vedere soltanto un montaggio di 35 minuti, de Le preghiere esaudite di Truman Capote di cui lo stesso scrittore citò lunghi e numerosi brani ma il cui manoscritto non arrivò mai all'editore, i dipinti di Turner a cui è dedicata un'intera sala della Tate Gallery a Londra. E poi altre storie ancora, libri a cui manca la fine, una cattedrale di cui si vede benissimo il progetto mai intrapreso estendersi in un parcheggio e le colonne delle navate perdersi nei muri delle case, un album perduto che i fan conoscevano già, il cantiere perennemente aperto della Sagrada Familia. Undici capolavori che non hanno nulla in comune, undici opere diverse tra loro per trama e protagonisti, epoca e tipologia, unite da un unico fil rouge, quello di non essere mai state portate a termine e di affascinarci, proprio per questo, terribilmente. (Simonetta Degasperi)
«Avvenire»
17-09-2009
«Libero»
18-08-2009
TUTTI I "NON FINITI". Diversi possono essere i motivi per i quali l’opera resta incompiuta. Il più ovvio è la morte del suo creatore, ma non bisogna dimenticare ripensamenti, incidenti di percorso, fallimenti, grane con i propri committenti. Sembra di stare dentro la sceneggiatura de Lo stato delle cose di Wim Wenders o nei tentativi falliti, da Orson Welles e da Terry Gilliam, di catturare la follia di Don Chisciotte facendone un film che non s’ha da fare. Nell’ambito cinematografico la Miller sceglie l’epilogo di Marilyn Monroe, quell’ultimo ciak che si sarebbe dovuto girare nella primavera del 1962 dopo Gli spostati di John Houston (per inciso, fu quello il film d’addio anche per Clark Gable e Montgomey Clift), e che invece non ci fu. Ormai Marilyn era preda dei propri fantasmi, delle ossessioni e chissà cosa ancora. Di Something’s Got to Give, così si sarebbe dovuta chiamare la pellicola diretta da George Cukor, è divenuto immortale il passo d’addio, il bagno nuda in piscina e l’eroticissimo gioco con l’asciugamano. Talvolta l’incompiutezza dell’opera si spiega come un segno del destino, che forse è meglio assecondare. Nella seconda parte del XIII secolo Firenze e Siena se le danno di santa ragione in battaglia e si sfidano nella costruzione della cattedrale più bella, ricca e grande, chiamando nelle rispettive municipalità i migliori artisti e architetti. Eppure oggi se andiamo a Siena troviamo il duomo non finito, lasciato esattamente come nel 1378, quando una terribile peste devastò la città della Lupa decimando il 70% della popolazione. Fu letto come un avvertimento celeste e i lavori si fermarono per sempre. Quanto alla Sagrada Familia, il folle progetto del più utopista e visionario degli architetti moderni, Antoni Gaudí, il tempio di Barcellona è metafora assoluta dell’incompiutezza, della totale impossibilità a raggiungere l’atto finale, un edificio destinato sempre a cambiare al punto che mai nessuno potrà dire di aver visto per due volte la stessa Sagrada Familia. Gaudí ci lavorò ossessivamente dal 1883 al 1926, ucciso da un tram che non aveva sentito arrivare, come al solito immerso nei suoi pensieri. Che dire allora dei capolavori mancati: forse l’altra Commedia umana di Balzac, che avrebbe dovuto arricchire e completarne la prima versione, o l’album perduto dei Velvet Underground, che nelle intenzioni di Lou Reed e John Cale (già separati in casa, senza Nico e con Andy Warhol ormai defilatosi) avrebbe superato addirittura il folgorante debutto del disco "della banana". Magari la sfida ai limiti della scrittura, divenuta ormai una priorità per Georges Perec: dopo aver pubblicato La scomparsa, un intero romanzo senza la lettera e, e il successivo Le ripetizioni con la e unica vocale, negli ultimi mesi della sua breve vita Perec lavora a 53 giorni, ispirandosi al numero-feticcio di Stendhal, un giorno in più del tempo che ci mise a scrivere La Certosa di Parma. Oppure il capolavoro effettivamente incompiuto di Giacomo Puccini, la Turandot composta in una corsa contro il tempo – Puccini era infatti gravemente malato e sapeva che non ce l’avrebbe fatta – affidata come in un testamento all’amico Arturo Toscanini, il 4 novembre 1924 salutandolo alla Stazione di Milano e aggiungendo in fondo: «Se mi succede qualcosa, le affido la mia Turandot».
UN BRUTTO CARATTERE. Michelangelo aveva un carattere difficile pari al suo talento, mal sopportava le esigenze dei committenti qualora fosse convinto, cioè sempre, di essere nel giusto, soprattutto si considerava scultore e non pittore, quindi mal digerì il lavoro al Giudizio della Sistina. La Miller racconta la tormentata genesi degli "Schiavi" in marmo, concepiti per il monumento funebre di Giulio II, interrotti, ripresi, disconosciuti, anche se per Michelangelo sarebbero stati loro la sua grande opera. Ciò che ne resta rivela, come l’incompiuta Pietà Rondanini, un’incredibile tensione a superare l’ideale classico della scultura, per aprirsi a una modernità devastante e troppo avanti rispetto ai tempi. Chi, in conclusione, sul non finito costruì il proprio stile, fu il pittore inglese William Turner, di formazione accademica e tradizionale, letteralmente "folgorato" da un’ idea che gli Impressionisti svilupparono diversi decenni dopo. La pittura non sarebbe mai più stata questione di rappresentazione ma di luce e di approccio psicologico dello spettatore. Solo chi guarda può decidere se il quadro è finito, la realtà è ormai diluita in dettagli e frammenti. Basti visitare le sale tumeriane della Tate Modem per capire davvero che l’arte contemporanea comincia qui. (Luca Beatrice)
«Libero-news.it»
18-08-2009
«Il Giornale di Vicenza»
06-08-2009
«L'Unità »
06-08-2009
«Tuttolibri La Stampa»
05-07-2009
 François Walter
François Walter
Catastrofi
«Sincronizzando»
01-12-2012
Leggete con curiosità tutte le cronache di inondazioni, maremoti, epidemie ed eruzioni vulcaniche? Avete visto cinque volte Deep Impact e Armageddon? Attendete ogni volta non con ansia ma con curiosità mista a piacere le fatidiche date contenute nelle profezie dei Maya? Non c'è dubbio, siete, come me, dei catastrofisti. Per noi è uscito qualche tempo fa un libro di François Walter, professore dell'università di Ginevra, intitolato Catastrofi. Una storia culturale.
C'è tutto, dalle calamità naturali alle pandemie, dai disastri ecologici ai grandi incidenti industriali, dai genocidi al terrorismo. Però inquadrato in una storia delle rappresentazioni e delle giustificazioni che gli uomini hanno dato alle varie calamità: dalle spiegazioni teologiche alle argomentazioni razionali dell'Illuminismo, dal calcolo delle probabilità alla teoria dei giochi, dalla "natura che si ribella all'uomo" alla moderna "società del rischio" (studiata da fior di economisti) e "dell'incertezza" (preferita da ascotlatissimi sociologi).
Il racconto è ricco di disastri (c'è perfino un "indice delle catastrofi citate" che occupa cinque pagine) e di gustosi episodi. Uno, per esempio, spiega come l'uso dei primissimi parafulmini sia stato ferocemente contrastato in quanto il nuovo ritrovato avrebbe "fatto fuggire la saetta dalle mani dell'Eterno per passarla a quelle dell'uomo". Walter racconta la lite, anno 1780, tra i magistrati di Saint-Omer e Monsieur de Vissery de Blois-Valé affinché quest'ultimo abbattesse il parafulmine che aveva fatto innalzare sul tetto di casa. In nobiluomo vinse la causa: "Non temiamo che il Cielo veda questa iniziativa come un tentativo audace di sfidare il suo corruccio e di togliergli i mezzi per punire i nostri crimini". La stessa motivazione con la quale furono ostacolate le prime campagne di vaccinazione: evitare la catastrofe voleva dire impedire che ci giungesse imperioso dal Cielo il segnale di ravvederci, pentirci e cambiare vita (chissà cosa avrebbero detto, i devoti magistrati, dell'aviaria o della suina...).
Ma la parte più interessante è quella che riguarda i giorni nostri, dove si susseguono capitoli dai titoli deliziosi, quali Le nuove culture del rischio, Le patologie dell'iper-organizzazione, La diffusione delle paure, La crescita dell'allarmismo...
Alla fine del libro scopro che in realtà non amo molto i predicatori di catastrofi, specie se poi si avverano. Con una sola eccezione: quando a predirla sono io. Fra tutt, quella che preferisco annunciare è la catastrofe del mio ufficio. Un atteggiamento, pare, condiviso da molti italiani. Ma Walter smaschera il gioco: la rappresentazione anticipata del disastro serve non tanto a evitarlo quanto a riaffermare un certo ordine (sociale), e il fascino delle catastrofi risiede nel non averne mai fatto esperienza. Insomma, il catastrofismo da ufficio serve solo a pararci le terga mimetizzandoci all'interno di una struttura gerarchica e, se lo esercitiamo, è perchè speriamo che il disastro non avvenga mai.
Il giusto atteggiamento anti-catastrofe, dicono gli esperti, è lo sviluppo delle competenze e il potenziamento delle capacità latenti di ognuno di noi: talenti da coltivare non solo per noi stessi, ma ll'interno delle relazioni che costruiamo dove lavoriamo. Mettendo in comune e non da parte. (Mauro Broggi)
«Lettera.com»
15-01-2011
Un saggio interessantissimo che in ogni epoca racconta i simboli ed esplicita le circostanze con cui l'essere umano esprime la propria paura. E pone il punto su quanto cultura, corretta gestione del rischio e della crisi e libertà di informazione possano tenere lontani ansie e pericoli. Da leggere.
«Linea»
16-10-2009
«Almanacco della Scienza»
08-10-2009
«Il Venerdì di Repubblica»
18-06-2009
Ma nell’epoca dell’allarme sistematico, legittimità e consenso dell’autorità (politica, scientifica, mediatica) si giocano sulle capacità di prevenzione reazione in tempi sempre più brevi. Scattanti: «Per essere credibile, l’informazione dev’essere veloce nella copertura: la macchina mediatica si mobilita con immagini e commenti ancor prima di sapere quali siano la natura e l’entità della minaccia. È un automatismo. I responsabili politici e gli esperti sono chiamati alla stessa prontezza di riflessi. L’imperativo è non minimizzare, mai». A conti fatti, meglio sovravvalutare che sottostimare. «Gli esiti di quest’ingranaggio li abbiamo visti: il pericolo Sars è stato ingigantito, la crisi Mucca pazza non ne parliamo, con premi Nobel giù a prevedere centinaia di migliaia di morti che non ci sono stati. Mentre davanti, all’ultimo allarme "influenza suina"ha prevalso, fortunatamente, una certa misura», dice Walter. D’altronde nella cacofonia delle diagnosi emergenziali, dove agli specialisti, nuovi guru del millenarismo secolarizzato, senti dire tutto e il contrario, si sfarina di nuovo il mito illuministico-positivista della neutralità della scienza, i fatti spariscono nella ridda delle interpretazioni: «Quella scientifica è una lettura della realtà fra le altre. Gli esperti non amano venir relativizzati. Di fatto però lo sono. II discorso scientifico è condizionato da compatibilità politiche, interessi economici, esposizione mediatica». In tempi di apocalissi prét-àporter, ci siamo poi dimenticati della Bomba. Spenta la guerra fredda, l’atomica è diventata una sorta di giocattolone vintage. Quel Good old danger, quel «caro vecchio pericolo», come ironicamente la definito studioso tedesco Gunther Anders, che sul trauma dell’annientamento nucleare costruì una filosofia. Nota François Walter: «Gli arsenali esistono ancora. Più potenti che mai. Però la percezione comune del rischio atomico è mutata. La bomba non è più qualcosa che abbiamo fatto noi. Ma opera di Stati canaglia: Iran, Corea del Nord. L’ordigno nucleare è roba da terroristi. L’Occidente ha esternalizzato il Male. Lo ha delocalizzato: la catastrofe è un complotto del nemico». Le neopaure viaggiano alla velocità degli scambi economico-finanziari, delle migrazioni umane, dei flussi informatici, delle innovazioni tecnologiche. Basta vedere la quantità di allarmismi, catastrofismi, complottismi, millenarismi che ribollono su Internet per rafforzarsi nel sospetto che l’ansia contemporanea sia una specie di interfaccia della tecnologia che vorrebbe dominarla. Sarà un caso, ma gli psicoterapeuti specializzati in quella sindrome sempre più diffusa chiamata «attacco di panico», ti spiegano che tra i soggetti più esposti ci sono proprio quelli sicuri di sé, autocontrollati, ma governati dall’ansia da prestazione, dal terrore della vulnerabilità. La paura che li assale è fisiologicamente, chimicamente vera. Però «parainode». Perché un vero pericolo non c’è […]. (Marco Cicala)
 Milad Doueihi
Milad Doueihi
Il Paradiso terrestre
«Avvenire»
15-05-2009
 Christian de Bartillat
Christian de Bartillat
Il Sorriso
«Il Secolo XIX»
12-05-2009
«Il Venerdì di Repubblica»
17-04-2009
«L'espresso»
02-04-2009
«Famiglia Cristiana»
15-03-2009
Evitando la trappola della nostalgia (ah, i sorrisi di una volta..), ce ne offre uno, indimenticabile, del suo passato?
«Premesso che nell'inconscio custodiamo tutti il sorriso della prima persona che si è chinata sulla nostra culla, la madre, e dunque è questo l'imprinting che abbiamo del volto umano, ricordo con particolare gratitudine alcuni sorrisi ricevuti in tempi difficili, e perciò ancora più preziosi. Come quello della suorina che mi accolse in un convento del Bresciano quando, bambina ebrea, vi cercai rifugio per sfuggire alle persecuzioni razziali. Rivedo come fosse ieri quella giovane novizia che apriva il portone con un'espressione calda e luminosa negli occhi e sulle labbra. Un sorriso d'accoglienza che mi tiene ancora compagnia e di cui non trovo traccia nei volti omologati di oggi».
Ha rievocato l'Olocausto, che non risparmiò la sua famiglia: anche in quell'orrore poteva spuntare un sorriso?
«Lo so per certo: ho appena saputo che una mia zia di 19 anni, deportata ad Auschwitz, dove morì quasi subito di tifo, durante il viaggio sul vagone piombato da Mantova, sperimentò il primo innamoramento. Mi piace immaginarla sorridente, questa ragazza così vicina alla morte, ma illuminata da un'ultima, trepidante felicità. Si chiamava Ida Finzi».
Nel suo ruolo di psicoterapeuta avrà incontrato dei sorrisi speciali...
«Sempre, nel corso dell'esperienza professionale, ho visto nel sorriso la conferma che si era sulla giusta strada, il segno concreto dell'indispensabile fiducia di chi si rivolgeva a me per un aiuto. Ma qui voglio ricordare un episodio che ho inserito nel libro Nuovi nonni per nuovi nipoti, e che ha per protagonista una bambina focomelica. Bellissima, entrò nella stanza di consultazione allungandomi le manine che, al posto delle dita, avevano palline di carne. Quella vista mi turbò e non riuscii a nasconderlo: al che lei, con uno spiazzante sorriso mirato a consolarmi, se ne uscì con l'impareggiabile: "Ma poi mi crescono le unghie!". Era un segno di speranza, la forza della vita che continua, nonostante tutto. Ebbene, ogni volta che mi trovo in difficoltà e temo di perdere qualcosa (energia fisica, giovanili entusiasmi, fiducia nel domani) sorrido fra me e mi dico, come quella meravigliosa creatura, "ma tanto poi mi crescono le unghie...".
E la forza delle donne, anche quelle in miniatura: così diverse dagli uomini, a partire dal sorriso...
«Che in loro è sociale, razionale, legato ai pensieri coscienti, mentre il nostro, più complesso e sfumato, nasce dall'interno, dal grembo, da un immaginario profondamente enigmatico. Non a caso è il sorriso della Gioconda a spadroneggiare in campo artistico. Ecco perché, nei tempi bui che stiamo attraversando, dobbiamo fare appello alla nostra immaginazione creativa e alle risorse della generatività. E non mi riferisco a una maternità corporea, ma alla capacità, solo nostra, di produrre ciò che ancora non c'è. Recuperando il legame ancestrale con la natura, il tempo cosmico, il mistero, possiamo far rispuntare il sorriso sulla faccia della terra». (Luisa Sandrone)
«Avvenire»
28-02-2009
«Il Sole 24 Ore»
25-01-2009
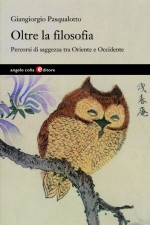 Giangiorgio Pasqualotto
Giangiorgio Pasqualotto
Oltre la filosofia
«Area»
01-09-2009
«l'Unità »
09-01-2009
«Il Giornale di Vicenza»
07-01-2009
 Elisabeth Roudinesco
Elisabeth Roudinesco
La parte oscura di noi stessi.
«il manifesto»
07-01-2009
«La Repubblica»
27-11-2008
Ogni epoca ha costruito le proprie figure della perversione? «La società ha bisogno di rappresentarsi concretamente la perversione per dare corpo e allontanare le paure legate alla parte oscura che sente dentro di sé. Non è possibile pensare una società senza la dimensione del male. Le figure dei perversi sono il capro espiatorio da additare alla comunità. Sapere che la minaccia alla società non viene da noi, ma da qualcun altro, ci tranquillizza e ci rassicura».
Il serial killer e il pedofilo sono le due figure della perversione che dominano la percezione contemporanea. In passato però cene sono state altre... «Ogni epoca si è creata la sua idea di perversione. I grandi criminali seriali sono considerati perversi fin dal Medioevo. Anche l'omosessualità è stata considerata a lungo una forma di perversione contro natura, come pure la masturbazione infantile e l'isteria femminile. Oggi però la loro percezione è cambiata e nessuno le considera più perversioni. Nella società contemporanea la perversione assoluta è incarnata dal pedofilo. La nostra società ne è ossessionata, considera la pedofilia una perversione assolutamente ingiustificabile. Più dello stupro e dell'omicidio. Da un punto di vista storico, è una novità. Il pedofilo ci fa orrore, a differenza del serial killer che ci ripugna ma ci affascina».
Come si spiega tale evoluzione? «La nostra società accorda ai bambini uno statuto senza precedenti. Valorizzando come mai in passato l'infanzia, oggi qualsiasi aggressione al corpo infantile ci sembra un gesto orribile. Il bambino non può difendersi, può essere plagiato e non può dare il suo consenso, mentre nella nostra cultura l'idea del consenso è fondamentale. Prima di Freud, i medici condannavano la sessualità dei bambini come perversa. Dopo che il fondatore della psicanalisi ha dimostrato la normalità della sessualità infantile, la società l'ha accettata, ma ha anche sentito il bisogno di proteggerla. Per questi diversi motivi la pedofilia è diventata ai nostri occhi la perversione più intollerabile».
La perversione implica solo la sfera sessuale? «Naturalmente no. I mistici, ad esempio, sono spesso stati protagonisti di forme di perversione molto radicali. Si pensi alle sofferenze che si sono imposti alcuni santi oggi molto venerati, la mortificazione della carne e la flagellazione per purificare il corpo. I rituali che ai nostri occhi appaiono come vere e proprie perversioni, all'epoca erano considerati un mezzo per avvicinarsi a Dio. Ancora oggi ci sono santoni indiani che digiunano fino a trasformarsi in veri e propri scheletri. I mistici oltretutto possono passare dalle vette del sublime agli abissi dell'abiezione. Si pensi a Gilles de Rais, su cui è stato poi costruito il mito di Barbablù. Fu un grande condottiero, animato dalla ricerca del bene, che seguì in battaglia Giovanna d'Arco. Quando questa venne mandata al rogo accusata di essere una strega perversa, egli precipitò nel pozzo delle proprie pulsioni incontrollabili, mettendosi ad ammazzare bambini. Quando la legge degli uomini s'inverte, trasformando la santa in strega, anche Gilles de Rais rovescia i propri comportamenti, diventando un orco assassino». Personaggi come Barbablù ci fanno paura però ci affascinano. Come mai? «L'orrore dei grandi perversi violenti ci ha sempre affascinato, da Barbablù a Jack lo Squartatore, fino ai più recenti serial killer cinematografici con la loro violenza piena di rituali macabri. Questi personaggi ci offrono lo spettacolo di quello che non siamo, ma che potremmo forse essere. Ci fanno paura, ma, assistendo alle loro raccapriccianti azioni, ci liberiamo dalla minaccia indefinita e oscura che sentiamo in noi. È un fascino torbido che esiste perché tutti, prima o poi, in un modo o nell'altro, ci siamo confrontati con il male. Tutti nascondiamo in noi una componente perversa».
Altri esempi di perversione? «Oggi un'altra figura percepita come profondamente perversa è quella del terrorista che schianta il suo aereo sui grattacieli di New York. In lui percepiamo una sorta di godimento del male che sta procurando. In tutt'altro ambito, anche nei casi gravi di anoressia c'è una forma di perversione, dato che in essi si manifesta una sorta di godimento della morte di sé».
Nel suo libro lei evoca anche la perversione politica. Come mai? «Accanto alla perversione individuale, esiste quella collettiva dei sistemi politici che pervertono le loro finalità. In nome del bene, questi istituiscono il male come legge. Le dittature, i fanatismi religiosi mostrano questa inversione della legge che autorizza il crimine. Il nazismo è stato il sistema che più è sprofondato nella perversione, giustificando perfino il genocidio. II rovesciamento tra male e bene è stato totale. Anche nelle democrazie contemporanee, in nome della sicurezza, della prevenzione e del controllo, si mettono in atto meccanismi che possono diventare perversi. La società di sorveglianza che pretende di controllare e prevenire tutto è una forma di perversione della democrazia». (Fabio Gambaro)
 Autori Vari
Autori Vari
Il Rinascimento italiano e l'Europa. Volume V. Le Scienze
«Rivista di storia della filosofia, LXV, 1 (2010)»
01-06-2010
L'avere assunto non l'evento scientifico (la singola scoperta, il protagonista) come interessante, ma il nesso e le dinamiche tra concezioni scientifiche e concezioni filosofiche, rende inevitabile allungare i tempi del cambiamento, riconsiderare il rapporto con le tradizioni, giudicare meno repentina ed evenemenziale la sovversione di antichi paradigmi.
Dalla lettura di molti contribuiti disposti nelle diverse sezioni del volume, emerge infatti un rapporto complicato con le tradizioni, non determinato dal semplice accumulo di informazioni, né da drastiche e unilaterali cesure. La tradizione scientifica non è solo quella greca - Euclide, Archimede, Pappo, Erone -; il paradigma contro il quale il mutamento insorge non è solo l'aristotelismo, né è l'aristotelismo tout-court; la translatio studiorum non fu un fatto filologico e non può essere ridotta a un mero revival di tradizioni. Anche se l'esito non è sempre identico, il volume nel suo complesso dà compiuta notizia della scoperta o della riscoperta dei testi antichi, della traduzione, delle castigationes e delle molteplici mediazioni che accompagnano le edizioni tra XV e XVI secolo. Dalla storia naturale alla meccanica (B.W. Ogilvie, M.O. Helbing), da Euclide ad Archimede (E. Ulivi, A. Sorci, E. Nenci), a Galeno (D. Mugnai Carrara, T. Rütten), dall'ottica geometrica alla prospettiva lineare degli artisti, umanisti competenti di scienza, traduttori e filologi che sarebbe arduo non definire anche filosofi (si pensi a Ficino), intervengono con competenza sui testi trasmessi, non da «settori di cadaveri», ma come «inspectores» di una realtà vivente e modificabile.
Qui mi sembra stia un ulteriore merito da riconoscere all'impostazione di questo volume, disposto a fare i conti con un altro pregiudizio storiografico, quello che nega al Rinascimento un contenuto filosofico (metafisico, logico, fisico) e lo giudica un fatto meramente filologico e artistico: una parentesi letteraria tra la filosofia tardoscolastica e la filosofia seicentesca. Per quanto paradossale possa sembrare, nel corso del Novecento la storiografia filosofica e quella scientifica hanno registrato un sostanziale accordo sulla valutazione negativa (per sottrazione) del Rinascimento: una «metafora impropria» (E.J. Dijksterhuis), perchè nulla aggiunse alla storia della scienza e nulla innovò rispetto al Medioevo; una enclave retorica e letteraria (E. Gilson), che non risolve la continuità tra la metafisica tardoscolastica e quella di Cartesio, tra la fisica di Buridano e quella di Galileo. Proprio Galileo Galilei e la nascita della nuova scienza (M. Camerota) è chiamato a chiudere in maniera enigmatica questo itinerario rinascimentale. Una nuova collocazione storiografica per un'antica e discussa identificazione del moderno. Forse, una metafora della natura ambigua e ancipite del Rinascimento, dell'equilibrio, per nulla inerziale, tra 'rinascita' e 'rivoluzione'.
«Medioevo»
01-01-2009
«Il Corriere della Sera»
07-11-2008
«L'Avvenire»
05-11-2008
 Jean Claude Bologne
Jean Claude Bologne
La conquista amorosa
«L'Espresso»
16-10-2008
«Minerva»
01-10-2008
«www.lettera.com»
15-09-2008
Parte infatti dalle usanze preistoriche ed arriva al "rimorchio" del XX secolo, passando per la mitologia, l'antica Roma e la Grecia, il Medioevo, il Rinascimento, il Seicento l'Illuminismo e l'Ottocento, Jean Claude Bologne, che con l'approccio del filologo analizza la bellezza di 110 trattati sull'arte della seduzione (di cui sessantatré anteriori al 1980), dall'Ars Amandi di Ovidio che risale agli inizi del I secolo a quelli del terzo millennio. Kierkegaard, Plutarco, Platone, Giovanni Della Casa, Rabelais, Proust, Flaubert sono soltanto alcuni degli scrittori citati insieme alle memorie di seduttori famosi come Casanova, ai trattati scientifici ed ai testi sacri.
Racconta di poeti e di libertini, di fanciulle caste e di grandi puttane, di patriarcato, liberazione della donna e relazioni omo. Dello stupro, che rivela il rifiuto e l'incapacità di compiere il primo passo. E di come in periodi non troppo lontani, dove il maschilismo è garantito dalla società e dalla religione, l'arte della seduzione è considerata negativamente perchè "Non c'è seduzione senza libertà".
"La cultura romana e quella cristiana" scrive infatti, "coltivano un disprezzo condiscendente nei confronti del seduttore. Ma che cos'hanno da contrapporgli? Il ratto, lo stupro o il matrimonio combinato -tutte circostanze in cui la seduzione non è necessaria, perchè non richiedono il consenso della donna", e le donne devono passare da uomo a uomo, da padre a marito senza alcuna possibilità di decidere per sé. "Se oggi seduciamo la figlia e non i genitori, è perchè questa è libera di scegliere. Libertà, uguaglianza... Il rimorchiare sarebbe repubblicano?" Bologne si perde in qualche digressione politica (e per repubblicano intende il modello francese, ovviamente) e si risponde da solo: "I Romani hanno scoperto la necessità di sedurre accanto a donne libere, che non dipendevano che da se stesse. Oggi il rimorchiare è reso necessario dall'emancipazione della donna. Donde, forse, di che riabilitare il concetto".
In tempi prolifici di saggi superficiali dalle citazioni stolte, stupiscono e danno piacere la più che nutrita bibliografia, la puntualità storica e filologica ed il buon senso che illumina l'autore nell'analizzare usi e costumi di periodi e società così diverse e lontane nel tempo. Garbato nell'affrontare quel che è approccio propedeutico ad un fine che tutti sappiamo e sempre uguale dalla notte dei tempi, lì si ferma, perchè "[...]per quanto ci riguarda, alla soglia della camera da letto si ferma l'arte del rimorchiare."
(Simonetta Degasperi)
«Il Mattino»
26-08-2008
«La Sicilia»
18-08-2008
«II problema è annoso – dice –. Gli uomini preferiscono credere al loro fascino naturale, all'amo dello sguardo che deve pescare il cuore della fanciulla. Ma la seduzione è anche un'arte con tecniche cervellotiche, discorsi, gesti, regali, strategie complesse. E non basta: per rassicurarsi, si accetta l'aiuto di fattori esterni, degli Eros e dei Cupido, mediatori di sicuro effetto».
Quali sono i passi più importanti per arrivare ad una conquista amorosa?
«I mezzi più semplici sono i più antichi: parole e regali. Ma il modo cambia. Nell'antichità bisognava fare ricchi regali perché l'amore s'indirizzava a donne inferiori, cortigiane affrancate di rara bellezza e maestria. Nel Medioevo e nel periodo romantico, si preferivano regali simbolici: un abito, un frutto, una ciocca di capelli, fino al dono simbolico del cuore. Certi gesti sono eterni: una tastatina col piede, bere nello stesso bicchiere, scrivere sulla tavola con il vino parole azzardate: sono atti già presenti nei testi di Plauto o di Ovidio. Nel Settecento, si cerca di rinnovare le antiche tecniche. Nel Neveu de Rameau di Diderot, il personaggio afferma di avere inventato cento modi e più di sedurre una ragazza, anche in presenza della madre, e dieci modi di compilare un biglietto galante».
Ai nostri giorni, quali strategie bisogna mettere in campo per sedurre le belle ragazze? «I manuali di seduzione del Novecento e dei nostri giorni chiedono consigli agli scienziati o alle professioniste della seduzione. Il "love-marketing" usa le stesse tecniche dei rappresentanti di commercio e, per esempio, sedersi accanto alla ragazza e non di fronte, dare del "noi" e non del "tu" creano psicologie produttive che favoriscono gli scambi: e così si parla d'amore come se si volesse vendere un divano o qualunque altro prodotto. L'etologia insegna i gesti della seduzione, e i segnali corporei inconsci. Negli Stati Uniti e ora anche in Europa si sono sviluppate nuove scuole per "rimorchiare", i Pickup Artists (Pua), che usano tecniche psicologiche, e il Neuro-linguistic programming (Nlp), che costituiscono comunità di internauti, per lo scambio di metodi di seduzione che sono innumerevoli: ogni anno, da venti anni, si pubblicano in francese due trattati di seduzione».
Eva è stata la prima seduttrice, ma dopo di lei le armi della conquista si sono molto affinate. Oggi, quali sono quelle più sicure e sottilmente diaboliche?
«La seduzione femminile esiste da sempre, ma doveva rimanere passiva. La donna lascia capire che è pronta ad ascoltare una dichiarazione galante con un'occhiata e un sorriso. Se la donna si permetteva di più, era diffamata: la moglie di Putifar nella Bibbia, Fedra nella mitologia greca, sono condannate per il loro contegno. Il Seicento ha inventato molte tecniche passive per le donne, ma il flirt, dalla fine dell'Ottocento, permette più audacia alle ragazze, anche se i limiti non sono precisi. Solo da trent'anni si permettono alle donne tecniche attive senza essere screditate».
Oggi, l'amore è ancora un sentimento fatto di tenerezza o l'ambizione della conquista ha smussato il lato dolce della questione amorosa?
«In tutte le epoche, la conquista fisica fu, per una parte importante della popolazione maschile, il primo scopo, attuato talvolta con cinismo: penso al Catéchisme d'un roué di Stendhal, scritto quando era di guarnigione in Italia, che fornisce le ricette brutali di giovani militari per forzare una donna all'inizio dell'Ottocento. Lo stesso Stendhal scrive venti anni dopo De l'amour, la più sensibile analisi dell'innamoramento. La nostra epoca mi pare meno cinica, perché negli anni Sessanta la contraccezione e la penicillina hanno sdrammatizzato i rapporti sessuali e permesso una sessualità più responsabile, e dunque più aperta al rispetto dell'altro, alla tenerezza e all'amore. L'arrivo dellAids non ha modificato questa evoluzione».
Dalle titubanze del passato, si è passati alla spavalderia del secondo Novecento...
«La novità, nella nostra epoca, è che i rapporti prematrimoniali non sono più disdicevoli o disonorevoli per una ragazza, fatto che ha cambiato profondamente la conquista amorosa. Cento anni fa, la migliore prova d'amore era il rispetto per la donna; alla fine del Novecento, era quasi il contrario. Ma accanto a questo movimento, si nota un ritorno di antichi valori e della castità prenuziale, che non esclude una tenerezza sensuale perché i giovani sono più a loro agio con il loro corpo». (Francesco Mannoni)
«Il Sole 24 Ore»
17-08-2008
«Famiglia Cristiana»
20-07-2008
«Il Secolo XIX»
18-07-2008
 Alexandre Jollien
Alexandre Jollien
Cara Filosofia
«Letture»
01-11-2008
«Il Giornale di Brescia»
21-09-2008
(Francesco Mannoni)
«Il Nostro Tempo»
14-09-2008
(Paolo Perazzolo)
«Famiglia Cristiana»
30-08-2008
«Panorama»
28-08-2008
 Roberto Mancini
Roberto Mancini
La lingua degli dei
«l'Adige»
13-01-2009
«Il Secolo XIX»
03-09-2008
«In tutte le religioni il silenzio ha un ruolo significativo», dice Mancini, «ad esempio nello Zen si persegue la mente vuota, il permanere nella stasi, e nella pratica yoga c'è un livello di realizzazione che si basa sul controllo assoluto dell'immobilità del corpo in tutte le sue manifestazioni. Nello shintoismo cè addirittura un mito delle origini secondo cui avrebbero avuto la parola pure i minerali e i vegetali, ma nella trasformazione dal caos al cosmos la maggior parte del mondo sarebbe piombato nel silenzio. È però il cristianesimo ad aver sviluppato più dettagliatamente il dibattito sulla dicotomia parola/silenzio, risolvendo una questione che nell'Antico Testamento era rimasta un po' ambigua. Perché da una parte il silenzio era il necessario atteggiamento al cospetto di Dio, ma dall'altro la parola era indispensabile per pregare e spiegare i precetti divini. Sono stati gli antichi Padri della Chiesa, e in particolare Pacomio, l'ideatore del cenobitismo, istituendo le regole per la vita monastica, a stabilire modi e tempi del parlare».
Questa disciplina della parola, alla base di tutte le esperienze monastiche occidentali, ha avuto influenza anche a livello sociale? «Il linguaggio politico, le tecniche di base dell'articolata convivenza civile, derivano dal "sistema delle circostanze" ideato dai teologi altomedioevali, che stabiliva che cosa dire, dove, quando, come, a chi. Nella prima metà del Duecento nacque una letteratura "podestarile" che adattava alla politica questo sistema, integrandolo con le tecniche della retorica classica. Il silenzio era il punto di partenza di ogni discorso, che doveva comunque essere moderato, incline al poco. Le corti dei principi furono aree di silenzio, luoghi dove il potere si esprimeva in modo formale e regolato. L'imperatore Federico II si teneva accanto il logoteta Pier delle Vigne, che parlava per lui». (Daniela Pizzagalli)
«La Provincia di Como»
12-07-2008
Professore, si fa sempre un gran parlare dell'utilità della parola, ma spesso la stessa viene sprecata e fraintesa. È possibile un equilibrio?
Le regole della circostanza sono per noi (nella cultura Occidentale) portatrici di questo equilibrio: non spendere inutilmente la voce e nello stesso tempo spenderla quando è necessario. Sta al singolo riconoscere quando è il caso di parlare e di tacere in relazione all'efficacia del suo discorso. Se noi pensiamo che il flatus vocis è qualcosa di prezioso, che è come un tesoro che deve essere conservato in un forziere, e se questo forziere è il nostro corpo, ecco allora che la moderazione nel parlare è come la moderazione nello spendere: operazione utile, talvolta inevitabile, e tuttavia rischiosa perché se attuata male potrebbe svuotare pericolosamente le nostre tasche e impoverirci. La nostra voce non è infinita, la ricchezza del nostro io non è illimitata, i pensieri che ci sono, sono il nostro tesoro che è necessario amministrare con oculatezza.
Dall'antichità ad oggi, come è cambiata la comunicazione?
Oggi si assiste ad una proliferazione di messaggi con l'inevitabile brusio di fondo che si crea. Ora, non si tratta di imporre nuovi e più prolungati silenzi, nel senso che non sarebbe opportuno che in una società libera si ponessero limiti alla parola. Porrei la questione in questi termini: sarebbe opportuno recuperare la dimensione dell'ascolto. Dell'ascolto attento, rispettoso, effettivo dell'altro o degli altri. Ecco, se questo accadesse avremmo recuperato del tempo perduto, con l'ascolto e la riflessione, con la lettura, per esempio, scopriremmo quanto sia interessante mettersi in attesa, rifilettere.
I politici, soprattutto quelli del nostro tempo, come si destreggiano tra il dire e non dire? Quello dei politici che non dicono per ragioni di opportunità e di calcolo politico riguarda più che altro il problema della reticenza. Questione anch'essa complicata. È del tutto evidente che la politica (le sue strategie e le sue tattiche) richiede riservatezza e prudenza: non tutto può essere esplicitato, non sempre è opportuno che l'interlocutore o l'avversario politico conosca nel dettaglio ogni passo dell'agire politico. Altro però è il caso del politico che chiede consenso e fiducia agli elettori. In quel caso, sulle questioni per le quali chiede il voto o il sostegno, la reticenza diventa illegittima? Quale fiducia accordare a chi non è sincero?
Il corpo come esprime il suo linguaggio "silenzioso"?
Il corpo si esprime per gesti che non hanno bisogno di emissioni vocali. Il linguaggio dei gesti è stato un formidabile strumento per parlare senza parlare.
Le donne considerate sempre troppo loquaci, quale peccato commettono parlando continuamente?
Garrulitas, scurrilitas, multiloquio.
(Francesco Mannoni)
«Il Sole 24 Ore»
29-06-2008
«L'Avvenire»
19-06-2008
 Francesco Zorzi Muazzo
Francesco Zorzi Muazzo
Raccolta de' proverbii, detti, sentenze, parole e frasi veneziane, arricchita d'alcuni esempii ed istorielle
«Il Gazzettino»
20-05-2008
 Enrico Niccolini
Enrico Niccolini
Ricordanze 1938-1945
«Corriere del Veneto»
29-04-2008
«Il Giornale di Vicenza»
27-04-2008
 Davide Lopez
Davide Lopez
Schegge di sapienza, briciole di saggezza, e un po' di follia
«Il Giornale di Vicenza»
22-01-2008
 Simonetta Marin
Simonetta Marin
Il culto dei santi e le feste popolari nella Terraferma veneta
«La Nuova Venezia»
30-11-2007
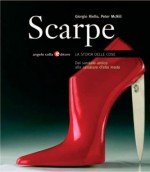 Peter McNeil, Giorgio Riello
Peter McNeil, Giorgio Riello
Scarpe
«Il Mattino di Padova»
04-01-2008
«La Domenica di Repubblica»
11-11-2007
«La tentazione di possedere tante paia di scarpe accompagna da sempre le donne. Ora un libro ci spiega come è cambiato il costume e quando è nata la nostra attrazione ... Gli esperti si leccano i baffi, sociologi, filosofi, sondaggisti, storici, economisti, ma anche sessuologi, persino psichiatri: ecco un campo di studi senza fine, su cui tutti possono discettare, le scarpe, cui attribuire massime simbologie, deviazioni psichiche, rimandi sessuali, significati freudiani o marxisti. La moda non ne sa niente, e neppure i produttori calzaturieri, ancor meno gli acquirenti compulsivi che accumulano scarpe come testimonianza di sé, rovinando spensieratamente piedi, colonna vertebrale e risparmi ... Ma può esistere qualcosa, soprattutto se di alto valore mercantile, che non venga subito trasformata in altra fonte di denaro, cioè in Cultura o, come si diceva negli anni Settanta, in Kultura? Chi non pretende la massima bizzarria, per esempio una copia d´epoca (1667) del Calceo antiquo di Benoit e Negrone, prima opera dedicata interamente alle calzature, può trovare adesso in libreria Scarpe, di Giorgio Riello e Peter McNeil, docenti universitari uno a Londra l´altro a Sidney, editore Angelo Colla, 359 pagine di magnifiche illustrazioni e saggi illuminanti e talvolta esagerati per accanimento culturale...» (Natalia Aspesi)
 Giovanni Gurisatti
Giovanni Gurisatti
Schopenhauer
«Il Domenicale»
29-10-2007
«C´è un altro Schopenhauer oltre a quello arcigno e pessimista che predica la nuluntas e insegna l´arte del non vivere come fine ultimo? Sì, è lo Schopenhauer più rivolto al mondo greco e meno a quello cristiano, più rivolto a Zenone e meno al Bhudda, è il filosofo che fa dell´arte del vivere di matrice epicurea e stoica suo materiale di studio e scrittura. In questo senso vanno interpretate le parti aforismatiche del suo lavoro le cui varie traduzioni, in anni recenti, hanno innalzato il pensatore di Danzica a figurina pop del mondo post-moderno. Ciononostante vale la pena di approfondire il tema, capire come la deriva eudemonologica non sia una ritirata senile del filosofo dal campo della metafisica, bensì un filone sempre presente nella sua ricerca fin dagli studi giovanili, un modo per inverare il concetto di ragion pratica e intendere la filosofia non come teoria, bansì come pratica, stile di vita, esercizio, disciplina, cura di sé»
«Il Giornale di Vicenza»
09-10-2007
 Maria Pia Pagani
Maria Pia Pagani
I mestieri di Pantalone.
«www.esamizdat.it»
01-07-2009
L'introduzione di Sisto Dalla Palma propone una riflessione sulle relazioni della commedia dell'arte con la cultura russa, non solo teatrale. Da subito emerge come la commedia sia stata protagonista di intrecci col mondo popolare e ortodosso, oltre che fonte di ispirazione per l'ambito culturale. Spetta al teatro russo del Novecento il compito di far fruttare l'incontro col teatro italiano, non solo della commedia e di Goldoni, ma anche di grandi attori come Salvini, Rossi e la Duse, di cui si ricordano fortunate tournées.
Come sottolinea Sisto Dalla Palma, è possibile riconoscere nel lavoro di ricerca di Miklaševkij, Mejerchol'd, Vachtangov, Evreinov, una straordinaria stagione di rinnovamento della scena teatrale attraverso la commedia (p. XVIII), che passa per uno studio approfondito dei tipi e delle maschere, come di quel “perfetto uomo di mondo” (p. 3) che fu Pantalone.
È con una analisi dell'opera di Miklaševskij che si apre lo studio di Maria Pia Pagani. Rileggendo La Commedia dell'Arte o Il teatro dei commedianti dei secoli XVI, XVII, XVIII, la studiosa ha colto quei passi capaci di restituire un tuttotondo della figura di Pantalone. Miklaševskij non si limitò a intraprendere uno studio filologico della commedia, poiché operò con l'intento di farla rivivere sulla scena attraverso le sue collaborazioni con Evreinov e Mejerchol'd. Senza dubbio quest'epoca presenta una straordinaria fioritura di sperimentazioni caratterizzate dall'innesto del seme dell'“improvvisa” sul fertile terreno degli Studi; tuttavia la raffinatezza del libro della Pagani ci conduce verso apparizioni meno note del mondo della maschera in Russia, quando ad esempio l'autrice cita e commenta la monografia (pubblicata postuma) di Aleksej Karpovič Dživelegov e gli articoli di Stefan Stefanovič Mokul'skij degli anni '40.
La Pagani ha saputo intrecciare sapientemente studi russi e italiani sull'argomento, cambiando di volta in volta lente prospettica: ha così riletto la trascrizione di una conferenza di Ettore Lo Gatto degli anni '50 e '60, dal titolo “L'influenza del teatro italiano sul teatro russo” (p. 22), dove il nostro insigne slavista sottolineava l'importanza dell'opera di Vladimir Nikolaevič Peretc.
Questo percorso di ricostruzione filologica appartiene al primo dei cinque capitoli del libro, intitolato I volti del magnifico.
Con un accenno a un articolo del '55 di Anton Giulio Bragaglia sulla natura istrionica di Pantalone, si apre il secondo capitolo, Il giullare Pantalone, il cui titolo riprende un racconto di Nikolaj Semenovič Leskov. Skomoroch Panfalon (titolo originale dell'opera) offre alla Pagani la possibilità di penetrare la questione dello stitilismo nell'ortodossia russa, e di vedere come questo si possa ricongiungere alla giullareria attraverso l'incontro di Ermio con Pantalone, noto come colui “che tiene allegri tutti gli abitanti di Damasco” (p.35).
Nel terzo capitolo, Far orecchie da mercante, viene analizzata una bylina, un antico canto popolare, che ha per protagonista un veneziano. Il testo, dal titolo Solovej Budimirovič, è tradotto dalla Pagani a seguito di un commento della storia, ambientata a Kiev.
Nel ritrarre i vari aspetti di Pantalone, l'autrice non manca di menzionarne l'avarizia. Con l'indagine di questo carattere peculiare della maschera veneziana, si apre il capitolo San Pantalone, medico dei bisognosi, dove il rapporto controverso tra Pantalone e il Dottore trova “un significativo riscontro nella figura di san Pantaleone da Nicomedia, giovane medico professatosi cristiano, che ricevette il martirio nell'anno 305 d.C.” (p. 63). La figura di san Pantaleone è protagonista di un antico testo agiografico (Il martirio del santo e glorioso martire san Pantaleone) di un anonimo autore greco, che la Pagani esamina offrendo la possibilità di comprendere i punti di contatto tra la maschera e il santo, accomunati dall'essere soccorritori “dei bisognosi”.
L'infiltrazione del codice della commedia in terra russa ha radici lontane e appartiene alla fascinazione che l'arte italiana ha sempre suscitato fin dai tempi dell'Impero zarista: la conoscenza dei tipi e delle maschere risale ai tempi della corte di Anna Ioannovna. A ciò si riferisce l'ultimo capitolo del libro, dal titolo Il celebre veneziano, che cita la raccolta Peretc, “basilare testimonianza dell'attività spettacolare proposta dai professionisti della Commedia dell'Arte alla corte russa nel triennio 1733-1735” (p. 73).
L'Appendice propone una traduzione di alcuni testi della raccolta Peretc e della raccolta Tichonov, dove la figura di Pantalone è protagonista dell'azione.
La pregnanza storica delle traduzioni goldoniane di Aleksandr Valentinovič Amfiteatrov, pubblicate solo in parte nel 1922, è trattata nell'ultimo capitolo e rivela il ruolo avuto dall'intellettuale e giornalista russo e dalla moglie, le cui lettere sono riportate in Appendice a testimonianza dell'intenso lavoro svolto dai coniugi.
Chiude il libro una sentita e acuta testimonianza di Erik Amfitheatrof, nipote del grande traduttore goldoniano. In queste pagine egli ripercorre brevemente la vicenda umana e professionale di Aleksandr Valentinovič, ricongiungendola all'intenso periodo storico e commentando la risonanza, talvolta positiva, talaltra negativa, che l'opera di questi ha avuto in Russia.
Per la varietà dei documenti analizzati e proposti, lo studio della Pagani si rivela particolarmente prezioso e originale, caratterizzato da una tessitura che segue un disegno tematico, e non prettamente cronologico, in grado di restituire la complessità e l'intensità dei rapporti che si intrecciarono tra intellettuali russi e italiani a favore della Commedia. (Erica Faccioli)
«Il Giornale di Vicenza»
16-01-2008
«Il Gazzettino»
20-10-2007
 Werner Hofmann
Werner Hofmann
La caricatura. Da Leonardo a Picasso
«Il Mattino di Padova»
16-06-2006
«Gazzetta di Parma»
23-05-2006
«Il Giornale di Vicenza»
06-04-2006
 Enzo Croatto
Enzo Croatto
Vocabolario del dialetto ladino-veneto della Valle di Zoldo (Belluno)
«Corriere del Veneto»
23-03-2006
«...Croatto ... con una meticolosa inchiesta sul campo ha raccolto e schedato un immenso patrimonio lessicale, di cui il vocabolario rende conto con criteri ineccepibili per il glottologo ma chiari ed accessibili anche per il lettore non professionista...
«Il Cadore»
07-07-2005
«...Il materiale lessicale, toponimico e antroponimico che costituisce l´ossatura di quest´opera è davvero ricco, sviluppandosi attraverso circa 25 mila lemmi, comprese molte forme arcaiche e spesso sconosciute alle giovani generazioni ... proverbi, modi di dire, filastrocche ... accrescono sensibilmente l´interesse e la completezza dell´opera, che si propone autorevolmente nel panorama dei vocabolari dialettali del Bellunese e non solo»
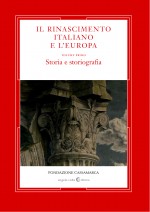 Autori Vari
Autori Vari
Il Rinascimento italiano e l'Europa.
«Il Domenicale»
18-02-2006
«...Il Rinascimento come cultura itinerante, veicolata da libri e artisti di passaggio, fiorito anche laddove il grande pubblico meno si aspetterebbe di trovarlo. Lontano dal più classico triangolo Firenze-Urbino-Ferrara lo presenta Jan Harasimowicz nel saggio Il Rinascimento fuori dal limes romanus, uno dei contributi raccolti nel volume Il Rinascimento italiano e l´Europa. Storia e storiografia, primo tassello di un´opera articolata in ben dodici volumi ... Il primo, un elegante tomo di circa ottocento pagine con abbondandi rinvii interni e un ricco apparato iconografico in appendice, si prefigge ... di "separare la realtà storica dalle vicende interpretative da essa suggerite", presentando la status quaestionis di una delle categorie storiografiche più abusate, quella di un Rinascimento "perennemente sospeso tra il mito e la storia". Si trattava innanzi tutto di fare i conti con il Rinascimento o sarebbe meglio dire con i tanti, forse perfino troppi Rinascimenti ... Chi è e da dove è spuntato fuori questo Rinascimento? E´ mai esistito il Rinascimento?, gli fa eco Jean Delumeau in apertura di una sezione che fin dall´etichetta affibbiatale preannuncia al lettore tutta la complessità della questione: Il Rinascimento come problema...» (Giancarlo Petrella)
«Il Domenicale del Sole 24 Ore»
05-02-2006
«Compare il primo volume di un’opera su il Rinascimento italiano e l’Europa che si annuncia monumentale: dodici volumi di grande formato ... Il primo volume, Storia e storiografia, indica i tratti originali di tutta l’opera, anzitutto "la volontà di rimarcare il carattere policentrico del Rinascimento" ... In questo primo volume molti saggi sono dedicati, come era necessario, a riesaminare il problema del Rinascimento quale categoria storiografica, alla luce soprattutto degli studi della seconda metà del Novecento. Non potendoli presentare tutti, vorremmo segnalare un saggio, che direi sperimentale, di un autore specialista di cultura rinascimentale, Amedeo Quondam: Classicismi e Rinascimento: forme e metamorfosi di una tipologia culturale. Qui l’autore, muovendo dalla descrizione di tre castelli del Tirolo (zona cerniera) – uno tardo medievale dei cavalieri teutonici, rimasto sempre abitato nei secoli ampliandosi con diversi corpi di fabbrica ma mantenendo l’aspetto scuro e guerriero; un altro, sorto nel secondo quarto del Settecento sul luogo di un precedente castello espressamente abbattuto, tutto luce, costruito secondo esemplari viennesi; un terzo del Quattro-Cinquecento che coniuga aspetti guerrieri e colti, esemplarmente rappresentati dalla ricca armeria e dal loggiato, ricco di iscrizioni latine con precetti classici: qui abita il signore della guerra e il gentiluomo di raffinata cultura umanistica –, allude quasi metaforicamente a una periodizzazione del Rinascimento come la grande epoca della modernità, dal Quattrocento alla Rivoluzione francese, l’età dell’Ancien Régime, omogenea nella continuità di ideali culturali e di letture ... L´opera ... sarà certo un punto di riferimento fondamentale per gli studi rinascimentali del nostro millennio» (Tullio Gregory)
 François Jullien
François Jullien
L'Ombra del Male.
«Internazionale»
10-09-2005
«E´ lunga, e non sempre illustre, la trafila dei filosofi occidentali, incuriositi o affascinati dal pensiero cinese, che hanno tentato di far dialogare la sapienza dell´oriente con le categorie della riflessione europea. Più interessante è quando a compiere la stessa operazione è un sinologo, e per di più un sinologo erudito come Francois Jullien. In questo libro sono a confronto l´ossessione giudeo-cristiana per il Male come categoria morale e la concezione, prevalente in Cina, del Negativo come parte di un sistema di polarità non connotate in senso etico - concezione che trova profonde rispondenze in Eraclito e in Hegel»
 Eric Hebborn
Eric Hebborn
Italico per Italiani
«Alumina»
10-08-2005
«Gli italiani non sanno più scrivere a mano in modo leggibile. Quella che un tempo era una discussa prerogativa della classe medica, da sempre composta di pessimi calligrafi, è divenuta ormai norma comune, anche se alle prove di concorso e nella selezione del personale gli esaminatori esigono sempre più spesso curricula manoscritti e grafie comprensibili, se non altro per interpretare la personalità dello scrivente ... Quanto mai opportuna la pubblicazione di un moderno trattato di calligrafia come questo di Eric Hebborn che, rinnovando in maniera geniale il manuale dell´Arrighi, propone a tutti gli italiani un rapido e facile corso di apprendimento calligrafico della forma di scrittura a noi maggiormente vicina e familiare, vale a dire il corsivo cancelleresco o italico...»
«Donna Moderna»
05-04-2005
«Ritorna di moda la calligrafia ... Scrivere bene è un´arte. Ma è anche un piacere, che sta diventando di moda. Vi piacerebbe provare? Italico per italiani è un manuale creato per autodidatti dal famosissimo falsario d´arte Eric Hebborn...»
 Franco Barbieri, Renato Cevese
Franco Barbieri, Renato Cevese
Vicenza. Ritratto di una città.
«L'osservatore romano»
10-06-2005
«Non tutte le guide sono uguali: i testi, gli strumenti veramente validi alla fine svettano di parecchio su uno sconfinato panorama medio basso. Ne è splendido esempio una guida storico-artistica su Vicenza firmata da Franco Barbieri e Renato Cevese ... Il volume è molto articolato, è di per sè una piccola biblioteca, o meglio uno scaffale ben fornito su Vicenza storico-artistica». (Mario Spinelli)
 Davide Lopez, Loretta Zorzi Meneguzzo
Davide Lopez, Loretta Zorzi Meneguzzo
Narcisismo e amore.
«Famiglia Oggi»
10-01-2006
«...Non si può parlare d´amore se non si parla anche di narcisismo e soprattutto se non si chiarisce a fondo la differenza tra un sano amore di sé, consapevole del valore e del sacro in ognuno di noi, e il narcisismo luciferino, immaturo e vampirizzante. La magistrale disamina di quest´ultimo da parte degli autori conduce a rilevarne la presenza anche nel rapporto d´amore ... Molto si è parlato della crisi del rapporto d´amore maturo, della crisi della funzione genitoriale, della difficoltà a tollerare la tensione interpersonale e intergenerazionale, ma è raro che a tale disamina si affianchi, come accade invece in questo libro, l´indicazione esplicita e coraggiosa della via di elaborazione e di superamento...». (Gabriella Mariotti)
«Marie Claire»
01-06-2005
«Coppia nella professione ma anche nella vita: succede. Ma nel caso di Davide Lopez e Loretta Zorzi c’è qualcosa di più: perché il nucleo stesso del loro ultimo lavoro, Narcisismo e amore, riguarda la coppia, la relazione matura. E, in qualche modo la sua celebrazione. Stiamo parlando di passaggi evolutivi che solo alla fine portano a quello che per molti (psicoanalisti e non) rimane un sogno: “un amore perdurante, fertile, generativo, brioso, fecondato dall’umorismo”. Impossibile non chiedersi quanto di autobiografico ci sia in tutto ciò». (Anna Alberti)
 Ettore Scipione Righi
Ettore Scipione Righi
Fiabe e racconti veronesi Vol. II
«Alberto Mario Cirese»
22-06-2005
«Ho ricevuto il bel volume dell´avviata ristampa della storica raccolta di fiabe di Ettore Scipione Righi. È stata una gioia. Gioia per l´importanza storica e scientifica dell´antico lavoro di Righi ora reso accessibile ai tanti che lo ignoravano e che avranno da impararne e da goderne. Gioia per la cura attenta dei curatori Viviani e Zanolli (che preziosa quella tavola sinottica finale, per giunta con la classificazione Aarne-Thompson!). Gioia per la presentazione di Daniela Perco che traccia con mano sicura un così ricco quadro degli studi folklorici ottocenteschi nel mondo e nei tempi di Righi. Ed è motivo di letizia anche la cura editoriale: un libro di questa mole, per restare leggibile (aprirlo, sfogliarlo, piegarlo...: quello che si fa quando davvero si legge, e se ne vuole interi l´agevolezza e il piacere) occorre che lo si sia editorialmente costruito con capacità da un lato e amore dall'altro».
«L'Arena»
17-02-2005
«...Formidabile collezione di fiabe e racconti colti dalla voce dei narranti e trascritti con uno scrupolo filologico assai raro ... Un evento di rilievo ben più ampio della limitata cerchia degli interessi provinciali ... Recupera per la prima volta forme gergali, locuzioni, modi di dire ed espressioni gnomiche che fanno parte non solo della nostra parlata più tradizionale ma anche del nostro immaginario collettivo». (Giuseppe Brugnoli)
 François Jullien
François Jullien
La grande immagine non ha forma.
«Il Foglio»
26-02-2005
«Attraverso l’analisi della pittura delle epoche Tang (VII-X sec.), Song (X-XIII) e del grande Shitao (XVII), Jullien conduce un paragone tra pensiero occidentale e cinese, chiamando in causa Laozi e Wang Bi, ma anche Leonardo, Picasso, la filosofia greca. Scrive a ritroso la storia di un incontro tardivo tra due concezioni del mondo, avvenuto in Europa agli esordi delle grandi avanguardie artistiche, quando i cubisti, a Parigi, scelsero di scomporre la forma, mettendo in discussione l’estetica europea classica. Quella stessa forma che l’arte cinese si era guardata bene dal definire con precisione, creando sistemi espressivi in cui i pieni e i vuoti, l’assenza e la presenza fluiscono in rappresentazioni dal sapore surreale, onirico». (Claudia Gualdana)
«Il giornale dell'arte»
10-01-2005
Giudicato “miglior libro dell’anno” da Francesco Bandarin, direttore Centro Patrimonio Mondiale Unesco, nella classifica “Il meglio e il peggio del 2004”
«L'Espresso»
15-10-2004
«Quando un saggio è avvincente si dice che si legge come un romanzo. Questo di Jullien, invece, si legge come una poesia» (Carla Benedetti)
 Mario De Ruitz
Mario De Ruitz
Magli e fucine in Europa.
«Premio Gambrinus "Giuseppe Mazzotti"»
01-01-2003
Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” – Sezione Artigianato di Tradizione – XXI edizione 2003, con la seguente motivazione: «Opera originale molto suggestiva ed efficace che ricollega la nascita e lo sviluppo della ‘rivoluzione metallurgica del ferro’, sviluppatasi nell’arco alpino specie nelle regioni centro-orientali durante l’età preindustriale. Le tecniche di lavorazione del metallo e la tipologia dei prodotti vengono accuratamente descritte e illustrate da una ricca iconografia, completata da un prezioso ‘lessico metallurgico’».
